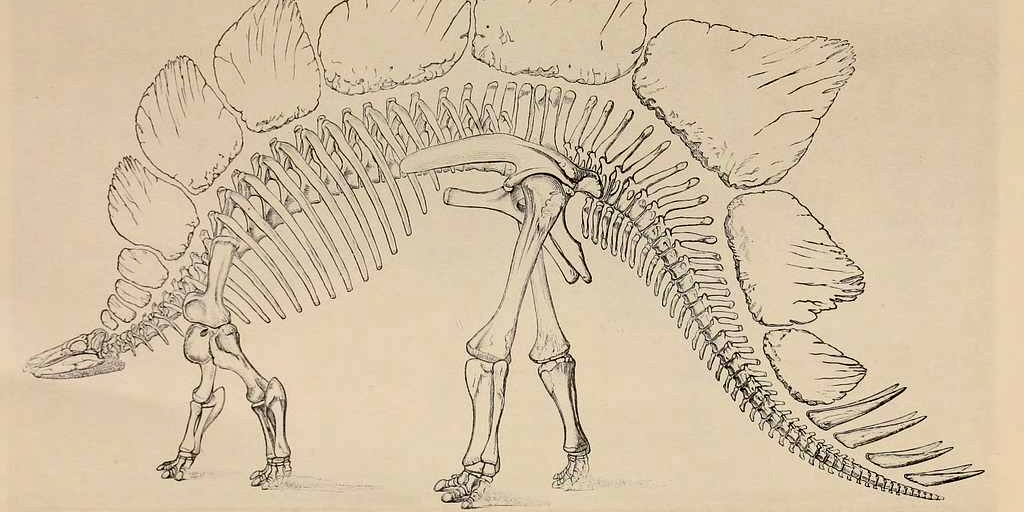EUROPA

«We have a deal». La Brexit e la vittoria mutilata di Boris Johnson
Tra certezze (poche) e nodi irrisolti, Regno Unito e Commissione europea sono arrivati a un accordo in extremis. Cosa succede ora ai sudditi di Sua Maestà? Cominciamo con questo intervento una serie di articoli sul Regno Unito lontano dall’Europa
E alla fine la Brexit arrivò. Quando abbiamo cominciato a scrivere queste note, nove giorni fa, non era ancora chiaro cosa sarebbe successo, e tutte le preoccupazioni erano concentrate sulla “nuova” variante del virus esplosa nel sudest del Regno Unito. La variante inglese che si affaccia pericolosa sull’Europa continentale non è più lo strappo più importante e traumatico della pur flebilissima unità europea, ma un virus che ha avuto la capacità (in Occidente) di mettere in un cantuccio tante altre questioni sociali e geopolitiche – Brexit inclusa. Poi alla vigilia di Natale il tanto atteso accordo tra Ue e Regno Unito è arrivato, spazzando via il temutissimo no-deal ma di certo non le incertezze e i problemi in prospettiva futura.
Accordo al foto-finish
Non sapremo mai se le code chilometriche di mezzi pesanti registrate la vigilia di Natale a Dover a seguito della chiusura delle frontiere con il Regno Unito causa mutazione inglese del virus di Covid-19 abbiano giocato o meno un ruolo fondamentale nella sigla dell’accordo commerciale e di sicurezza fra il Regno Unito e la Commissione Europea. Probabilmente no.
L’incertezza fino all’ultimo è in realtà figlia dell’esigenza del premier britannico Boris Johnson di ricostruire la propria popolarità, dopo un anno disastroso che ha rivelato tutti i limiti del governo Tory nel gestire l’impatto della pandemia. L’accordo siglato al foto-finish è stato infatti presentato ai sudditi di Sua Maestà come un capolavoro di diplomazia britannica che, nonostante «le enormi difficoltà» (da qui la necessità di arrivare al ridosso della fine del periodo di transizione facendo salire la tensione) riportava finalmente il destino del Regno Unito nelle mani dei suoi cittadini: «Take back our money, our borders, our laws, our economy and our waters» e «Get Brexit Done» erano d’altronde gli slogan con cui Johnson vinse le elezioni lo scorso anno e che ha ripetuto ieri in pompa magna nel dibattito lampo a Westminster per la ratifica dell’accordo sulla Brexit. Un successo raccontato in patria con una retorica intrisa di sovranismo e di nostalgia imperiale.
Se in qualche modo i conservatori ne sono usciti mediaticamente vittoriosi, il Labour ha perso un’altra occasione: il segretario Starmer ha imposto (whipped) un voto a favore dell’accordo, provocando una mini-rivolta interna nel Parliamentary Labour Party, con 39 deputate/i che hanno violato la disciplina di partito astenendosi o votando addirittura contro il deal. Una posizione abbastanza incomprensibile quella di Starmer se rammentiamo che nell’era Corbyn era stato il fautore della posizione del partito a favore di un secondo Referendum.
Che la trattiva degli ultimi giorni fosse tutta una messinscena a uso puramente mediatico si evince dalla farsa riguardante lo stallo nei negoziati alla voce pesca. Un settore che nel Regno Unito vale infatti meno dell’1% del Pil, ma che evoca le, ormai lontane, memorie della supremazia marittima delle navi battente bandiera di Sua Maestà e la sconfitta (questa più recente, nella prima metà del Novecento) nella guerra commerciale ittica contro la Norvegia. Emblematica, in tal senso, è la minaccia, evidentemente inverosimile, degli ammiragli della Royal Navy di inviare gli incrociatori per vietare l’ingresso nelle acque territoriali ai pescherecci francesi, belgi e olandesi. Accesso che poi nell’accordo siglato è stato ovviamente garantito, introducendo addirittura un elemento di non reciprocità: mentre i pescherecci europei possono pescare fra le sei e le dodici miglia dalle coste britanniche, i pescherecci britannici non sono autorizzati a pescare entro le acque territoriali dell’Unione Europea (dodici miglia dalle coste). Altri dettagli, svantaggiosi, riguardanti le quote di pescato hanno fatto levare voci insoddisfatte da parte dei pescatori scozzesi. Di questo riparleremo in un articolo di prossima uscita.
Chi ha vinto?
Insomma, sulla pesca, che la propaganda di Johnson aveva descritto come il tema centrale, su cui il Regno Unito non avrebbe arretrato, il bilancio è fortemente sfavorevole. Un leitmotiv che in realtà riguarda tutto il trattato: l’unica vittoria, non trascurabile tuttavia, di Johnson è aver messo, almeno temporaneamente, la parola fine a questa tragicommedia iniziata il 23 giugno 2016 e aver mantenuto la promessa elettorale. E, anche questo aspetto non trascurabile, di poter gestire indipendentemente la lotta alla pandemia, in particolare per quanto riguarda i vaccini, mentre la gestione comune della Commissione Europea sta già creando frizioni in particolare con la Germania.
Allo stato attuale, l’accordo siglato fra Commissione Europea e Regno Unito sulla sicurezza e sulle relazioni commerciali rappresenta di fatto principalmente uno status quo, «as short as possible, as long as necessary». E, a dire il vero, non avrebbe potuto essere altrimenti: il 52% dell’import del Regno Unito proviene dall’UE dalla quale importa in media oltre la metà di frutta e verdura fresca. Nei mesi autunnali e invernali questa dipendenza alimentare dall’Unione Europea può raggiungere il 90% per alcune tipologie di prodotti (ad esempio lattuga e pomodori). Questa necessità, letteralmente vitale, di poter accedere al mercato unico Ue senza barriere tariffarie ridimensiona drasticamente la tanto sbandierata sovranità britannica riconquistata con la Brexit: il conflitto fra l’accesso al mercato comune e l’autonomia legislativa si è risolto, e si risolverà sempre, in favore del primo.
Ecco perché, nonostante il trattato preveda una rinegoziazione periodica ogni 5 anni (utile per far rifiorire stagionalmente il sovranismo britannico che ormai ha le redini del partito Conservatore), l’accordo è destinato a rimanere tale ad perpetuum.
È bene sottolineare, tuttavia, che sebbene la stragrande maggioranza delle relazioni commerciali resterà invariata rispetto al passato, per alcuni settori, come la già citata pesca, l’accordo presenta novità problematiche per l’economia e la sicurezza britannica. In primo luogo, l’industria dei servizi (80% del PIL UK, 50% dell’export complessivo dell’isola) perde, almeno temporaneamente, l’accesso al mercato comune, in attesa di una decisione unilaterale di Bruxelles relativa all’equivalenza, ad esempio, di alcuni titoli di studio. In secondo luogo, il Regno Unito perde l’accesso ai database comunitari dell’Europol, rendendo più complessa la lotta al terrorismo, in cima, almeno dal punto di vista mediatico, alle priorità dei Tories.
Un altro nodo è quello del programma Erasmus, da cui il Regno Unito esce nonostante le promesse di fare altrimenti. Al di là della retorica sulla generazione Erasmus, su «un’esperienza che cambia la vita», sicuramente si privano di un’opportunità, parzialmente pagata dalle istituzioni pubbliche, migliaia di persone – circa 15mila studenti britannici ogni anno. L’auto-esclusione dal programma Erasmus rappresenta inoltre, come lo stesso Johnson ha ammesso, una perdita economica per il suo paese. Il vaneggiato Turing scheme (da Alan Turing) che dovrebbe sostituire il programma Erasmus e spedire gli studenti britannici nelle migliori università mondiali è per ora solo un annuncio, che rispecchia però l’idea di grandeur e la poca concretezza del leader Tory.
Confini
Restano poi da capire molte questioni aperte. Una riguarda le dinamiche interne tra le quattro nazioni che compongono il Regno Unito. L’Irlanda del Nord ha infatti molto da perdere da questa situazione (con l’unico lungo confine di terra con l’UE), e sulla Brexit si è consumato com’è noto un netto scontro tra Inghilterra e Scozia. Così ieri (30 dicembre) mentre Ian Blackford, il leader dello Scottish National Party a Westminster, si affrettava a dire che molti scozzesi preferirebbero vivere nell’Unione Europea piuttosto che in una «rotta Brexit Britain» (non è del resto vero anche per molti inglesi?), il parlamento scozzese rifiutava l’accordo sulla Brexit, così come quello gallese e l’assemblea nordirlandese.
Voti simbolici, sicuramente, ma che danno il senso di un paese diviso. Ancor più complicata è la questione dei due territori d’oltremare britannici in Europa, e cioè Akrotiri e Dhekelia (le due basi a Cipro, di cui essenzialmente non si parla) e Gibilterra, nella penisola iberica. Nel promontorio vivono 34mila persone che hanno votato quasi all’unanimità contro la Brexit e lavorano 15mila spagnoli, il cui destino è ancora incerto.
Dal punto di vista simbolico questo accordo e in generale le negoziazioni e i voti di questi ultimi giorni marcano un altro passaggio molto importante in un lungo percorso di allontanamento del Regno Unito dalle istituzioni europee. Un percorso cominciato con il referendum del giugno 2016, da molti vissuto come un trauma, e poi avviatosi sui binari di una lunga attesa che pareva non portare davvero a qualcosa. Ora restano da capire gli effetti reali di un accordo che Johnson ha definito come la «fine di un inizio», formula confusa che forse involontariamente allude a ciò che rimane da fare per dare sostanza alla parola «indipendenza» – per ora poco più di una dichiarazione di «isolazionismo» – in un contesto in cui tre delle quattro regioni che compongono il Regno Unito si avviano a capitalizzare il disaccordo con la capitale Inghilterra. Di grande alla Gran Bretagna è rimasto ben poco.
Immagine di copertina da commons.wikimedia.org