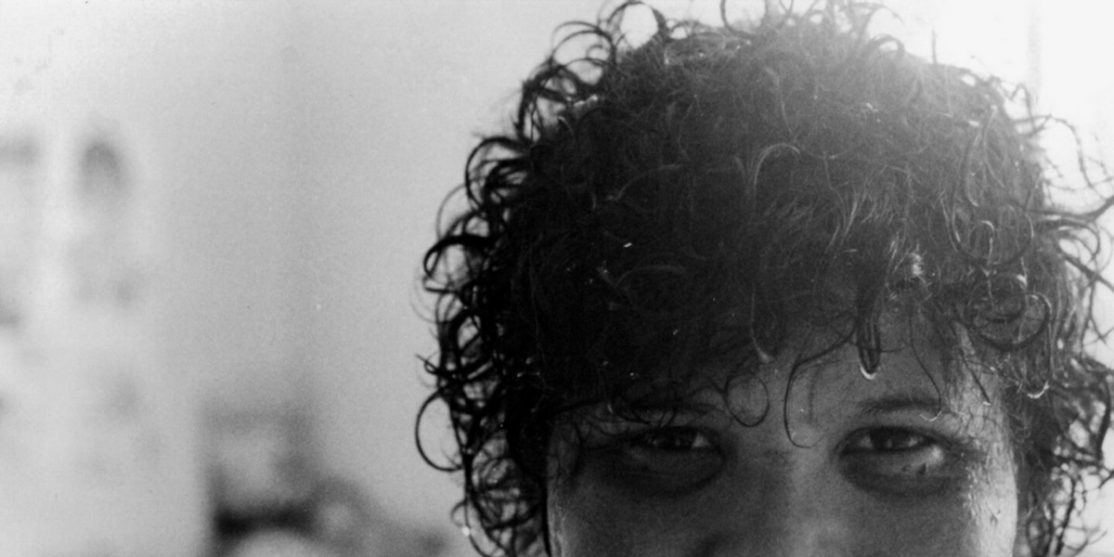DIRITTI
Tutti i dati, le cifre e le conferme delle gravi violazioni all’hotspot di Taranto

Un’inchiesta che riporta numeri, dati e cifre sul sistema hotspot di Taranto: ecco la conferma degli abusi, delle violenze e le violazioni dei diritti umani messe in campo oggi in Italia sulla pelle di migranti e rifugiati
I
n otto mesi – da marzo ad ottobre 2016 – sono stati emessi 1111 ordini di allontanamento dal territorio italiano. Tra questi, quattrocentoventotto sono stati i provvedimenti di respingimento. Mentre 683 sono state le espulsioni differite, cioè senza obbligo di accompagnamento coatto alla frontiera, ma con l’ordine per lo straniero, comunque, di allontanarsi dal territorio italiano entro sette giorni. Ottantadue, invece, i trattenimenti disposti nei Cie (centri di identificazione ed espulsione).
Sono i numeri della fabbrica dell’esclusione, dell’hotspot di Taranto, centro di identificazione e trattenimento a non meglio precisata natura giuridica amministrativa dove sono transitate – secondo i dati resi disponibili dalla locale questura – nel tempo considerato, 14.576 persone. Istituito nella città di Taranto in quanto possibile punto caldo di sbarco, in realtà, si scopre che è servito a ben altro. Infatti, dei quattordicimila e più migranti in questione, solo 5.048 sono quelli provenienti da sbarchi, mentre la maggior parte, 9.528 sono gli stranieri rintracciati sul territorio italiano e condotti a Taranto per essere identificati.
Come è spiegato in un rapporto della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato scritto a margine di una visita nel centro hotspot di Taranto: “si tratta di una prassi che desta molte perplessità poiché in nessuno degli hotspot visitati dalla Commissione (Lampedusa e Pozzallo) accade una pratica di questo tipo”. Nello stesso report – che DINAMOpress ha potuto consultare – si legge che “alla stessa Commissione diritti umani sono arrivate diverse segnalazioni riguardo a richiedenti asilo fermati in massa dalle forze dell’ordine e trasferiti a Taranto senza un controllo preventivo della loro condizione giuridica”. Si fa riferimento qui in particolare all’episodio già denunciato accaduto il 22 ottobre scorso a Milano quando un centinaio di migranti sono stati fermati nel corso di una serie di controlli intorno alla stazione centrale da parte delle forze di polizia e trasferiti a Taranto, al fine di verificare la regolarità della loro presenza sul territorio italiano. La Commissione parlamentare ha confermato, dopo aver verificato la documentazione, che “alcuni di loro avevano già avviato la procedura per la richiesta d’asilo, erano in possesso di regolare permesso di soggiorno e disponevano di un posto nel circuito di accoglienza della città lombarda”. Dunque, sono gli stessi parlamentari ad ammetterlo: “non si comprende il motivo del loro trasferimento a Taranto in presenza di un documento valido”.
Non solo. È mancata del tutto una opportuna azione informativa sui motivi e sugli esiti dell’operazione, sempre secondo quanto scrive la Commissione nel rapporto: “ancora non si capisce perché una volta verificata la provenienza della persona da una struttura di accoglienza, non si sia proceduto a garantire il titolo di viaggio per ritornare nella stessa struttura”. E ancora: l’episodio del rastrellamento di Milano fa il paio in tutti i casi con il racconto, con la testimonianza resa da un ragazzo di sedici anni il quale alcuni giorni prima aveva lasciato la comunità per minori di Pescara (dove risiedeva) per tentare di raggiungere la Francia dalla frontiera di Ventimiglia. Il minore ha riferito di essere stato fermato dalla polizia francese, di essere stato consegnato agli agenti italiani ( per poi essere trasferito a Taranto) “senza che fosse verificata, a Ventimiglia, la possibilità di fare ritorno nella comunità di provenienza”.
Ed è sempre nello stesso rapporto considerato che i parlamentari scrivono: “è difficile comprendere la vera natura della struttura di Taranto dopo aver verificato tali prassi”. Le perplessità dei deputati rispetto a tali pratiche sono sicuramente dovute al fatto che è l’identificazione dei migranti in seguito allo sbarco, il fine arcinoto per cui l’Agenda europea per l’immigrazione ha previsto l’adozione dell’approccio hotspot. Ma non soltanto. Perché è anche il fatto che in qualsiasi ufficio immigrazione sul territorio nazionale è possibile verificare la regolarità della presenza sul territorio italiano di un cittadino straniero, a porre seri dubbi sul reale rispetto dei diritti fondamentali delle persone transitati dalle frontiere di Como, Chiasso e Ventimiglia.
Tra clandestinità ed esclusione. Nello stesso periodo considerato, tra le attività dell’hotspot di Taranto, occorre considerare anche diverse espulsioni eseguite con effettivo rimpatrio alla frontiera. Ottanta sono state le persone rimpatriate. Cinquantotto a maggio, venti ad agosto e le ultime due a ottobre. A riferirlo sono stati alcuni alti dirigenti della questura jonica al vice – presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione diritti umani del Senato, Riccardo Mazzoni, durante una visita tenuta dallo stesso parlamentare nel centro di identificazione e trattenimento di Taranto, avvenuta dieci giorni fa.
In quell’occasione gli stessi poliziotti hanno dichiarato che i rimpatri sono avvenuti attraverso due voli specifici, uno verso l’Egitto e l’altro verso il Sudan. Si tratta dei 48 cittadini sudanesi fermati a Ventimiglia il 19 agosto, identificati e foto-segnalati, per poi essere trasferiti, il 21 agosto, con dei pullman presso l’hotspot di Taranto, dove dopo una nuova identificazione è stato loro notificato un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposto dal Prefetto Umberto Guidato e convalidato da un giudice di pace della stessa città. Salvo poi ritornare verso Nord, a Torino, dove li aspettava un volo diretto per Khartoum, capitale dello stato sudanese.
Dalla questura di Taranto hanno riferito inoltre che da marzo a ottobre 2016 sono state identificate nell’hotspot, nel dettaglio: 1.965 donne e 12.610 uomini. Compresi in quel totale ci sono 1.503 minori, di cui 252 avevano meno di 10 anni, 128 minori di età compresa tra i 10 e i 14 anni, 1.123 tra i 14 e i 18 anni. Tra le nazionalità di provenienza la fa da padrona quella eritrea, con 3103 presenze censite. Numerosi i cittadini sudanesi. Quasi tremila. E i nigeriani, quasi duemila.
Sempre gli stessi funzionari della pubblica sicurezza hanno tenuto a sottolineare che “in nessun caso si è ricorso a metodi coattivi per prendere le impronte digitali”. Gli operatori delle organizzazioni internazionali presenti nel centro, intervistati dalla Commissione, se da un lato hanno confermato che negli ultimi mesi, a quanto è dato loro sapere, non si sono verificati rifiuti di foto-segnalamento, dall’altro hanno riferito che nei primi mesi di attività, le situazioni di tensione accadevano spesso, in particolare, nel caso di migranti di origine sudanese, i quali, non rientrando tra le nazionalità che hanno accesso al programma di relocation, contestavano quanto previsto dal regolamento di Dublino ribadendo l’intenzione di chiedere protezione in altri Stati membri. Dunque erano tra le nazionalità più restie a concedere le impronte.
Non solo. Alcuni tra gli stessi operatori “hanno segnalato un episodio critico avvenuto a giugno quando un gruppo di cittadini sudanesi ha opposto forti resistenze al rilevamento delle impronte e ci sono stati gravi momenti di tensione”. Si tratterebbe – a dirlo è lo stesso rapporto della Commissione diritti umani, dello stesso episodio riportato nel dossier di Amnesty International pubblicato a novembre 2016.
Le pagine diciannove e venti del rapporto, in particolare, contengono cinque interviste realizzate da Amnesty International in cui i migranti riferiscono di pestaggi attraverso l’utilizzo di manganelli elettrici in coincidenza dell’arrivo di un gruppo di circa 300 di loro all’hotspot di Taranto, dopo essere sbarcati al porto di Reggio Calabria. È la notte tra il 24 e il 25 giugno 2016. Quel che accade lo racconta Ibrahim, un uomo di 27 anni del Sudan che sta cercando di raggiungere il fratello nel Regno Unito: “il gruppo era sbarcato a Reggio Calabria il 23 giugno, prima che la polizia ci trasferisse su sei autobus a Taranto, dove siamo arrivati la mattina presto”. Così: “quando gli autobus si sono fermati davanti al centro ci siamo rifiutati di scendere temendo che ci avrebbero immediatamente preso le impronte digitali”. È ancora lui, Ibrahim, a riferire: “di essere stato colpito con un bastone elettrico, di essere svenuto a terra circondato dai poliziotti che da lì mi hanno portato di forza all’ufficio accanto per fare la foto. Poi mi hanno preso le impronte digitali”.
Ecco dunque i numeri, le cifre che confermano le violazioni dei diritti umani e gli abusi che il sistema hotspot contribuisce ad alimentare. Lo riconosce pienamente ora – dopo le denunce di organizzazioni internazionali, associazioni, giuristi per l’immigrazione, attivisti; e diverse inchieste giornalistiche, anche una commissione parlamentare: “il rischio maggiore è che vengano trascurate le necessarie valutazioni degli elementi soggettivi e della storia individuale della persona sbarcata”. Come dire, senza che vi sia alcuna valutazione in ordine al diritto d’asilo. È l’approccio hotspot a funzionare così.