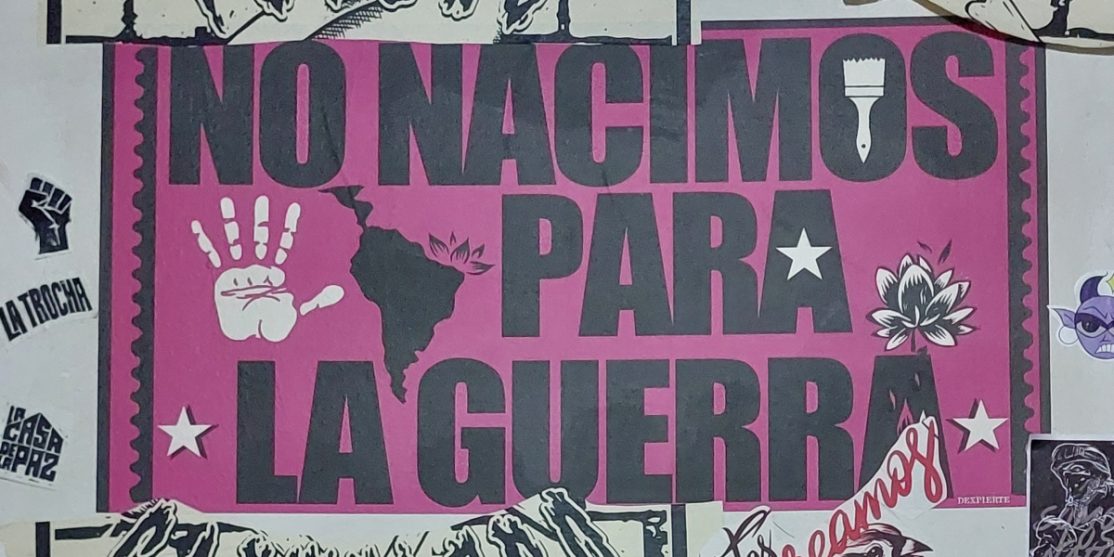DIRITTI
Poche note sul Rapporto annuale dell’INPS

Non vi è rapporto annuale di fonte istituzionale che non ricordi a questo paese le profonde discriminazioni che le donne vivono dentro e fuori il mercato del lavoro.
È ora la volta del Rapporto annuale dell’Inps che, nell’analisi dei dati pensionistici, misura anche il “prezzo”, in termini retributivi, che le donne lavoratrici pagano quando decidono di diventare madri. Si tratta di una perdita secca relativa al proprio reddito che, a soli due anni dalla nascita di un figlio o una figlia, si aggira attorno al 35%. Una donna su quattro circa, nei 24 mesi successivi alla nascita del bambino o della bambina, si trova infatti costretta a lasciare la propria occupazione a causa delle enormi barriere che incontra nel preservare il proprio posto di lavoro. Difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, sovraccarico del lavoro riproduttivo e domestico, l’ormai rarefatta offerta pubblica di servizi all’infanzia, alla cura degli anziani e dei disabili, condannano sempre più spesso le donne alla disoccupazione forzata e al ruolo di supplenti permanenti del welfare state in via di dissoluzione. Ma anche per coloro che riescono, dopo la gravidanza, a mantenere il lavoro (perlopiù precario), la discriminazione non tarda a palesarsi: in media, dopo la nascita della figlia o del figlio, nella busta paga queste donne trovano il 10% in meno del proprio precedente stipendio.
Ancor più grave è l’aumento del fenomeno dell’interruzione del rapporto di lavoro se si pensa al già esiguo tasso di occupazione femminile: in Italia si ferma al 48,5%, contro il 61,2% nella UE (peggio di noi solo la Grecia). In altri termini, continua a crescere il tasso di mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ed è altrettanto evidente, a partire da queste storie di bassa, intermittente o inesistente contribuzione, quale sarà, nei prossimi decenni, l’entità della povertà femminile in vecchiaia.
Insomma, la stessa Relazione dell’Inps spiega con chiarezza l’impatto che queste dinamiche hanno sulla propensione alla maternità, e dunque come sia sempre più difficile che le lavoratrici precarie e con scarse tutele contrattuali – ossia la maggior parte della forza-lavoro femminile – scelgano di diventare madri. La preoccupazione di Tito Boeri in merito è assai semplice: sempre meno donne lavoratrici, sempre meno figli, sempre meno contributi versati nelle casse dell’Inps. L’allarme che lancia: chi pagherà in futuro le pensioni? Lo stesso discorso vale per le e i migranti, di qui le ulteriori preoccupazioni del Presidente per la chiusura delle frontiere. L’auspicio è quello di agevolare, insieme all’occupazione femminile, un nuovo baby-boom, di tornare a far essere le donne italiane e non delle ben funzionanti macchine per la riproduzione, al netto di qualche concessione – briciole – sul piano del lavoro e del welfare.
Come Tavolo Lavoro e Welfare di Non Una Di Meno riteniamo fortemente inadeguate le misure prospettate in tal senso tanto dal Presidente Tito Boeri – per quanto nello scenario politico attuale possa sembrare addirittura figura illuminata – quanto dal governo. Il punto dirimente, in una prospettiva femminista – in un paese in cui ogni due giorni una donna viene uccisa, in cui la nuova povertà riguarda primariamente le donne, in cui il tasso di disoccupazione femminile è altissimo, come quello, del resto, del differenziale salariale, in cui l’elemento della dipendenza economica continua a pesare come un macigno sulla possibilità per le donne di intraprendere percorsi di fuoriuscita da relazioni violente –, sta innanzitutto nell’abbattimento della logica secondo cui alle donne spetterebbero per definizione le attività domestiche e di cura. Di qui il rifiuto di ogni approccio teso a favorire la cosiddetta conciliazione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo; la questione della riproduzione non è un “problema femminile”, ma riguarda tutti, perciò deve essere ri-socializzata alla società nel suo complesso. Per questo vogliamo che l’indennità di maternità sia generalizzata e incondizionata, non solo dunque per le lavoratrici subordinate e parasubordinate e non solo in presenza di un contratto di lavoro; lo stesso per quella di paternità, chiediamo cioè una radicale estensione di essa come sostegno effettivo alla genitorialità condivisa; il rifinanziamento, il potenziamento e l’accesso universale ai servizi per l’infanzia.
Ancora, vogliamo combattere la disparità salariale e i meccanismi di dumping – che colpiscono soprattutto le lavoratrici e i lavoratori migranti – con un salario minimo dignitoso almeno su scala europea. Vogliamo poter rifiutare il ricatto della precarietà, dei salari da fame, del lavoro purché sia, delle molestie e delle violenze sui luoghi di lavoro – in aumento dopo il Jobs Act, vista l’ormai totale assenza di tutele contrattuali e dunque la crescita esponenziale dei livelli di ricattabilità delle lavoratrici – attraverso l’introduzione di una forma di reddito di base, universale e incondizionato.
Lo abbiamo chiamato reddito di autodeterminazione, perché deve essere strumento di autonomia e liberazione, e non misura di intervento sulla povertà. Strumento di prevenzione – perché garanzia di indipendenza economica – rispetto al problema della violenza maschile sulle donne, e non solo risposta concreta ex post per tutte coloro che intraprendono percorsi di fuoriuscita da situazioni violente. Insomma, una misura assai distante da quella appena varata dal Governo per contrastare la povertà, il REI – reddito di inclusione –, di cui rifiutiamo i tratti distintivi: il fatto di essere categoriale (riguarderà cioè solo poche famiglie [1], con figli minori o disabili a carico e in condizioni di gravissima indigenza materiale misurata attraverso l’ISEE e IRS [2]), rivolto alla famiglia e non alla persona, condizionato a un percorso di “inclusione” la cui non osservanza da parte del beneficiario comporta la sospensione del beneficio stesso (peraltro irrisorio, 340 euro mensili circa, a tal punto da collocarsi al di sotto della soglia di povertà assoluta calcolata da ISTAT). Dunque niente di più lontano dai principi dell’universalismo, dell’individualità, dell’autodeterminazione e dell’autonomia sottesi alla nostra proposta femminista.
La famiglia – ormai anche i dati come la stampa mainstream hanno dovuto riconoscerlo – è infatti il primo luogo di origine della violenza maschile contro le donne, per questo il calcolo dell’erogazione del reddito, affinché possa essere davvero uno strumento di autodeterminazione delle donne e di tutti, deve essere su base individuale; anche perché respingiamo l’imposizione della norma famigliare eterosessuale, per riconoscere piuttosto anche tutte le forme di affettività e relazionalità al di là di essa. Rifiutiamo inoltre, come nel caso del REI sempre, l’elemento della condizionalità, e quindi l’approccio workfaristico, perché netto è il rifiuto del ricatto dello sfruttamento: non vogliamo, in cambio di briciole, dover essere anche costrette ad accettare lavoretti che nulla c’entrano col nostro percorso formativo e professionale, utili solo alle aziende e alle amministrazioni per sfruttare manodopera a basso costo, quando non a titolo gratuito (i famosi lavori socialmente utili). Vogliamo piuttosto che la ricchezza che quotidianamente produciamo e che quotidianamente ci viene sottratta venga equamente redistribuita.
#GenitorialitàCondivisa
#NonConcilio
#WelfareUniversale
#RedditoDiAutodeterminazione
#SalarioMinimoEuropeo
[1] 400 mila famiglie saranno interessate dalla misura a fronte di 1.600.000 circa famiglie in condizioni di povertà assoluta.
[2] Con ISEE inferiore ai 6000 euro e IRS a 3000 euro.
Tratto dal blog Non una di meno