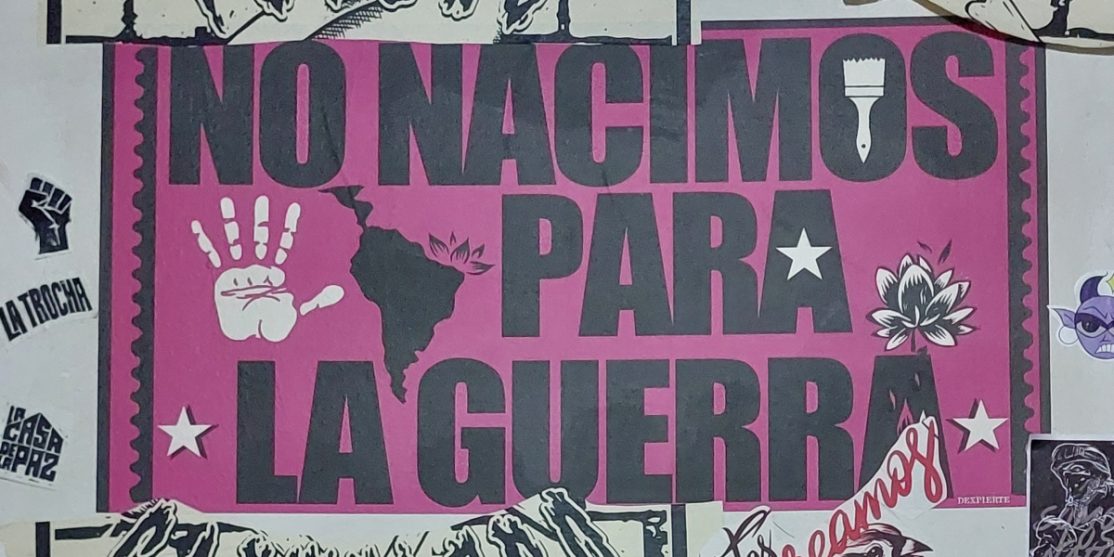TERRITORI
L’Ilva vista dall’interno: controllo dei corpi e disciplina gerarchica

Ultima tappa dell’inchiesta sulla grande fabbrica di Taranto. Viaggio all’interno dello stabilimento, tra condizioni di lavoro pesanti, stress psicologico e morti tra i lavoratori
“Quando sono a lavoro mi sento guardato a vista. Se non ci sono i vigilanti, ci sono quelli che noi chiamiamo fiduciari della proprietà. Osservano e riferiscono.” La frase in questione è la memoria di un operaio Ilva ed è contenuta nelle migliaia di pagine che compongono gli atti giudiziari del processo “Ambiente Svenduto”. Le testimonianze di alcuni lavoratori e quelle rese da alcuni rappresentanti dei sindacati sono alla base di un troncone dell’inchiesta (successivo al sequestro degli impianti) che chiama in causa una parte della struttura dirigenziale della fabbrica: quella costituita dai cosiddetti fiduciari dei Riva, cioè dai dirigenti – ombra che avrebbero avuto il compito, in particolare, di controllare e spiare i dipendenti. Più in generale, di massimizzare ad ogni costo i profitti dell’azienda. Risparmiando su tutto: dalle normative in materia ambientale a quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. C’era dunque una sorta di governo aziendale occulto operante all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto, costituito da soggetti denominati fiduciari, non inquadrabili nell’organico aziendale ma riconducibili direttamente alla proprietà, cioè alla famiglia Riva. Sono le parole – anch’esse agli atti dell’inchiesta – di Marco, un altro operaio (il nome è di fantasia) a svelare come funzionava la catena di comando sulla carta “invisibile” che sovraintendeva al funzionamento della più grande fabbrica italiana: “ci sono tre motori elettrici. Se ne rompe uno. Chiami l’ufficio manutenzione, che a sua volta chiama l’ufficio tecnico. Quest’ultimo chiama il fiduciario responsabile di quel reparto. Poi si fa la trafila al contrario e ti dicono di andare avanti! Fino a che non ti riduci con due motori e le gru zoppicanti. In questo modo è tutto risparmio”.
L’allora segretario provinciale della Fiom, Rosario Rappa, ora responsabile nazionale del comparto siderurgia per il sindacato dei metalmeccanici, i fiduciari li aveva scoperti già nel 2010, prima che lo facessero, due anni dopo, i magistrati. Così, in un’intervista, descrive il loro potere: “i fiduciari non sono ufficialmente in organico e rispondono direttamente alla società. Si tratta di dipendenti in pensione arruolati come consulenti. Sulla carta dovrebbero collaborare con i dipendenti più giovani mettendo a disposizione la loro esperienza. Di fatto determinano i ritmi produttivi. E la loro parola è decisiva per gli avanzamenti di carriera e di qualifica”. Il sindacalista ci andò giù duro quella volta, tanto che quelle dichiarazioni furono poi acquisite dagli stessi magistrati: “sono figure che contribuiscono a militarizzare la fabbrica, intimidendo i lavoratori con fare da kapò”. Disse ciò che in realtà molti già sapevano e che è stato messo nero su bianco nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito nel 2013 cinque dirigenti, ora tutti imputati nel processo che si sta celebrando davanti alla Corte d’Assise di Taranto, accusati dei reati di “associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro”. Di una strage, insomma. Accusati di reati gravissimi sono: Alfredo Ceriani, 76 anni, Giovanni Rebaioli, 71 anni, Agostino Pastorino, di 62, infine i quasi ottuagenari Enrico Bessone e Lanfranco Legnani, quest’ultimo considerato il direttore – ombra dello stabilimento. Comunque, al di là dei risvolti penali che interessano la vicenda, per comprendere i ruoli avuti e i compiti effettivi, dei dirigenti al soldo dei Riva, basta quanto ha dichiarato ai magistrati un altro operaio:” i fiduciari non firmano niente, sono marziani, vengono dalle valli lombarde, non risultano nella gerarchia ma stanno sopra in ordine di importanza ai capi reparto. A volte sono ex operai mandati giù come nelle colonie. Hanno una tuta anonima grigia. Ogni tanto qualcuno sbotta. Come quello che una volta diede in escandescenza e si mise a gridare verso gli operai del “rivestimento tubi” gridandogli addosso: “africani”! Il mio reparto ne aveva due, uno più anziano e uno più giovane. Ora, entrambi sono spariti”.
Inoltre, sempre tra le carte dell’inchiesta, si legge che: “nella fabbrica, la formula andata di moda è stata: velocità uguale produzione, a prescindere dal fatto che tale obiettivo fosse raggiungibile con metodi o regole diverse da quelle protocollari, a discapito della sicurezza”. Non solo. I giudici ritengono la mancata esecuzione delle manutenzioni e lo stato precario in cui versano i luoghi di lavoro (situazioni da considerare sia sotto il profilo della sicurezza che da quello dell’inquinamento) responsabili di serie ripercussioni avute dal personale, sia in ordine a infortuni gravi, addirittura alcuni mortali, sia a stati di malessere psico – fisico. Tant’è.
Tuttavia, c’era, o c’è ancora, una sorta di meccanismo premiale messo in atto dall’azienda per garantire il silenzio dei dipendenti, o comunque per addomesticare i loro corpi. Interessante è quanto racconta ai magistrati una fonte sindacale: “vi sono alcuni premi elargiti dall’azienda in maniera discrezionale, non soggetti a controlli o parametri verificabili. Si tratta di “premi fine anno”, elargiti a dicembre, non sono diritti individuali, ma ad personam”. Quale ne sia lo scopo, più o meno evidente, di questi premi, è spiegato ancora nella testimonianza resa dal sindacalista:” le consistenti liberalità elargite, indubbiamente hanno il fine di incrementare in maniera abnorme le quantità produttive, sottoponendo i lavoratori a ritmi stressanti che accrescono il rischio di infortuni sul lavoro”. Questi sono i cosiddetti premi di produzione, poi ve ne sono altre, di premialità specifiche date da Ilva Spa. Racconta la fonte sindacale: “negli ultimi anni l’azienda ha elargito premi speciali ( buoni spesa da Auchan) nei reparti dove vi è stato un decremento degli infortuni. Tutto ciò, se da un lato significa voler sensibilizzare maggiormente il lavoratore nel processo produttivo, dall’altro significa sollecitare minori denunce relative agli infortuni subiti da parte degli operai”. È la faccia altamente spietata di un sistema di controllo e disciplinamento dei corpi, attuata sotto la maschera rassicurante e benevola del datore di lavoro.
L’Ilva è un’ “istituzione totale”, prendendo in prestito le parole del sociologo canadese Erving Goffman: “nelle istituzioni totali c’è una distinzione fondamentale tra un grande gruppo di persone controllate, chiamate internati e un piccolo staff che controlla”. Un regime chiuso e fortemente amministrato. Una realtà così simile a quella raccontata da Bianca Guidetti Serra, avvocata ed ex staffetta partigiana (scomparsa di recente) in Le schedature Fiat (Rosenberg 1984). Un libro che ha fatto epoca, ma terribilmente attuale, che narra delle decine di migliaia di schedature realizzate dai vertici Fiat ai danni dei suoi dipendenti, in cui erano appuntati i dettagli della vita privata, le abitudini, la fede politica, di tantissimi di loro. Per non parlare dei reparti confino, che nella fabbrica di auto torinese hanno attraversato diverse stagioni storiche. Si va da quelli istituti da Vittorio Valletta nella Fiat degli anni’ 50 e 60, a quelli a cui ha dato vita Romiti nella stagione fortemente drammatica dei primi anni’ 80; quella della marcia dei 40.000 impiegati di Mirafiori e dei tantissimi suicidi tra operai cassaintegrati e delegati sindacali, a finire con i reparti confino per sindacalisti inaugurati alla Fiat di Nola tra gli anni ‘90 e 2000. Sono luoghi in cui vengono relegati gli ingovernabili, gli operai non controllabili. Che siano uffici senza suppellettili, senza sedie, né scrivanie, o magazzini spogli, la sostanza non muta.
All’Ilva di Taranto, invece, c’era una palazzina, semi – ristrutturata, “adibita” allo scopo. Si chiamava palazzina Laf, acronimo di reparto laminatoio a freddo. Lì dentro, dal novembre 1997 al dicembre 1998, ci finirono in settantanove. Più o meno tutti quelli che in seguito alla privatizzazione di Ilva, e al passaggio dallo Stato alla famiglia Riva, avvenuta nel 1995, rifiutarono la novazione del rapporto di lavoro, ovvero il demansionamento, da impiegati a operai. Molti di loro erano iscritti ai sindacati. Furono costretti a non far nulla. A passeggiare lungo i corridoi muti, avanti e indietro, a contare i buchi del pavimento o i fori dei muri.
La dottoressa Marisa Lieti è una psichiatra specializzata in stress da lavoro. Ha importanti pubblicazioni e ricerche scientifiche alle spalle. Già responsabile del centro di salute mentale della Asl di Taranto, di lavoratori in crisi depressiva ne ha curati ( e ne cura ancora) a centinaia: “si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone affette da disturbi del sonno, crisi isteriche, in certi casi manifestano anche idee suicide”, spiega a Dinamopress: “negli ultimi anni l’ambito dei pazienti in cura si è diversificato, molti sono anche i dipendenti dei call – center, non solo operai. Gli stress gravi, come quelli di cui mi occupo, possono essere provocati dal super lavoro, oppure dalla sua assenza/ mancanza. Faccio un esempio: uno degli studi più importanti che ho condotto è stato nei primissimi anni’ 80, al tempo del piano di ristrutturazione della Fiat, quando la cassa integrazione venne somministrata in dosi massicce come ammortizzatore sociale e in breve tempo in tutta la provincia di Torino risiedevano cinquantamila cassintegrati. Così fu svolta una ricerca, in collaborazione con l’Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali e la Cgil di Torino.
Da questo studio su “cassa integrazione e disagio psichico” vennero fuori centocinquanta casi di suicidio tra i dipendenti cassintegrati, oltre che disagi anche tra i familiari. L’allontanamento dal lavoro fu particolarmente doloroso per quei dipendenti che nella fabbrica avevano investito una parte importante del loro tempo di vita, infatti registrammo numerosissimi casi di suicidio fra delegati di fabbrica”.
I dati diffusi, all’epoca, suscitarono una particolare indignazione. Tra l’altro fu il primo studio al mondo fatto su questo argomento: sui suicidi provocati nei cassaintegrati. Un eco vastissimo, in tutto il Paese, ebbero anche le ricerche condotte dalla psichiatra sulla palazzina Laf. Dalle memorie contenute in quegli studi, da lì partirono i magistrati per processare Emilio Riva e altri dieci dirigenti. Il processo vide condannare in secondo grado il “patron delle ferriere”, il “ragiunat” a un anno e dieci mesi di reclusione. Gli altri dirigenti a pene comprese tra i quattro e i diciotto mesi.
“La vicenda della palazzina Laf, in generale i casi di stress e malattia che ho registrato, nel tempo, tra gli operai dell’ Ilva di Taranto, evidenziano come la vessazione più che nascere da una sorta di persecuzione individuale, magari relativa ad un disagio mentale, nasce in realtà da una precisa scelta imprenditoriale, legata a precisi criteri di organizzazione del lavoro”. Di questo si tratta, secondo la trentennale esperienza della dottoressa Lieti. Di una precisa strategia aziendale, di come è organizzato il lavoro di fabbrica. E poi aggiunge: “ in alcune realtà lavorative esistono dei sistemi di controllo e punizione che andrebbero puniti più incisivamente”. Dunque, c’era (o c’è ancora) una dimensione disciplinare particolarmente evidente che si caratterizza all’interno dei due insediamenti industriali più grandi presenti in Italia: la Fiat di Torino e l’Ilva di Taranto. Ma c’è anche un altro filo rosso che lega le due fabbriche: la prima è attualmente il cliente più importante ( in termini di acciaio acquistato) della seconda. Di un’azienda che sta perdendo, al mese – secondo i dati diffusi dagli stessi commissari governativi Pietro Gnudi, Enrico Laghi, Corrado Carruba – 50 milioni di euro; gli stessi che hanno anche annunciato l’azzeramento delle perdite entro il 2017. Proprio per questo il Governo Renzi ha previsto, nella legge di stabilità, di stanziare ulteriori 800 milioni di euro per il salvataggio del siderurgico, un’azienda decotta, da vendere nuovamente ai privati, con lo Stato che dovrebbe occuparsi delle bonifiche. Più o meno così prevedeva anche il “patto” tra il Ministero del Tesoro guidato da Lamberto Dini ed Emilio Riva, siglato nel 1995. Come dire che cambia l’epoca, cambiano i simboli, i linguaggi. Resta lo sfruttamento dei corpi.
Leggi le altre due puntate dell’inchiesta di Gaetano de Monte:
Genealogia di un disastro ambientale. Come si è arrivati al processo all’Ilva
Soluzioni di governo e processi di soggettivazione: l’altra faccia della questione Ilva