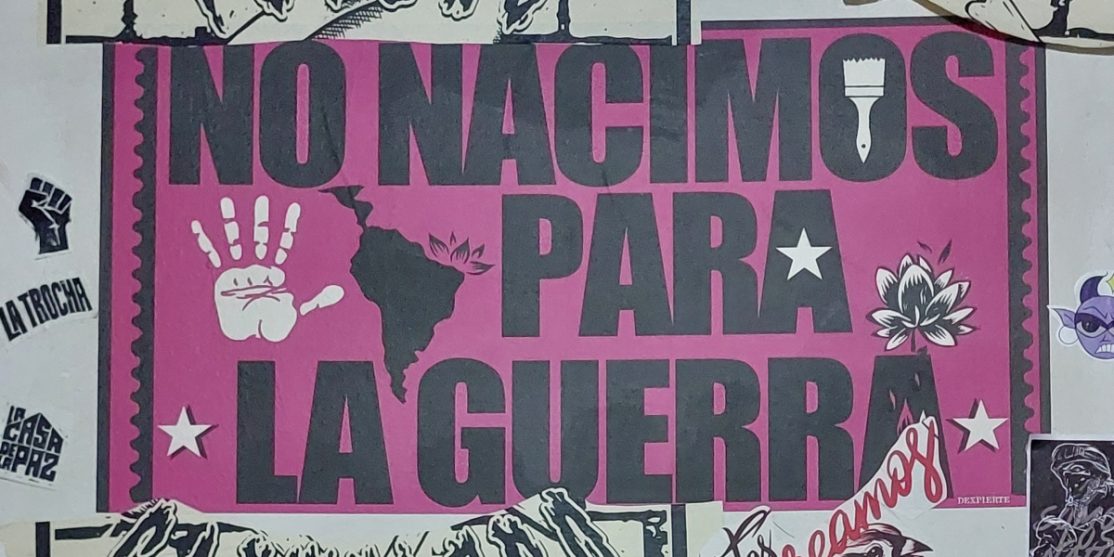OPINIONI

Khasha Zwan, non sarà una risata a seppellire i talebani
La retorica occidentale a proposito del comico ucciso dai “barbuti”, sul quale stanno uscendo ora nuove informazioni, tradisce la nostra ansia di voler essere comunque al centro della tragedia afghana
Una risata non seppellirà i talebani. Per ora, a essere seppelliti (anzi, nemmeno) sono i corpi delle vittime della violenza che sta imperversando sul territorio afghano, fra l’attentato e le esplosioni rivendicate dallo Stato Islamico, la repressione degli aguzzini governativi o para-governativi e gli omicidi mirati coi droni.
Semmai, con una risata – che ha però da essere molto molto amara – ci si potrebbe seppellire il tentennante discorso di Biden, incapace di render conto di una decisione che sia una, di fornire una minima spiegazione (politica? strategica? valoriale?) di ciò che gli Stati Uniti (non) stanno facendo, di ciò che hanno fatto e di ciò che presumono di fare da qui in avanti.
Ma il disorientamento (e le lacrime) non sono solo i suoi: sono quelli di un intero sistema di pensiero e dominio che si è “improvvisamente” sfaldato, che sembra precipitare sempre più in un “buco nero di senso”. In questo disorientamento, quasi tutto occidentale, stanno riemergendo anche fatti e testimonianze di un passato più o meno recente che acquisiscono una nuova rilevanza, un diverso significato.
È il caso della morte di Nazar Mohammed, più noto come Kasha Zwan: un “comico” afghano, come si legge nelle ricostruzioni delle testate che stanno riprendendo la notizia, che era diventato popolare pubblicando video su TikTok in cui irrideva i talebani e che (pare) proprio per questo il 22 luglio è stato prelevato dalla sua abitazione a Khandhar, torturato e ucciso da alcuni guerriglieri legati al gruppo dei “barbuti”.
In tanti, a partire dal giornalista Roberto Saviano o dall’ex-grillino Lorenzo Tosa, stanno inoltre riprendendo sui social un video in cui si mostra il momento del sequestro: Kasha Zwan, ammanettato, viene fatto salire sul retro di un’automobile da un miliziano armato di Ak-47, ha uno scambio verbale con un’altra persona seduta, in cui il comico pronuncia una frase a metà fra lo sfottò e l’insulto, viene allora schiaffeggiato violentemente.
La retorica si spreca: «Khasha Zwan è morto facendo battute, sorridendo in faccia ai suoi aguzzini, con la potenza anarchica dell’ironia spesa sino alla fine», scrive appunto Saviano. Gli fa eco Tosa: «Ha tolto ai talebani il potere più grande che hanno: quello della paura. È come se avesse detto loro: potete anche torturarmi, massacrarmi, uccidermi, ma non mi toglierete mai il potere di prendermi gioco di voi, la mia dignità, quello che sono».
Alcuni fanno notare come, però, la realtà potrebbe essere un po’ più complessa: un articolo del Washington Post (che qui da noi viene peraltro riportato dalla testata “La luce”, diretta da un ex-rappresentante della comunità islamica italiana) sostiene infatti che, oltre a produrre video comici, Khasha Zwan fosse anche a capo di un’unità della polizia di Khandhar che avrebbe messo in atto gesti di repressione arbitraria nei confronti dei talebani. Lo stesso report di Human Rights Watch che a fine luglio dava notizia della sua uccisione menziona il fatto. Lo confermano poi, attraverso sue conoscenze in Afghanistan, il vignettista Vauro in un suo post Facebook e, più recentemente, un articolo di “Arab News” sebbene su testimonianze indirette (per una ricostruzione esaustiva si veda Il Post).
Ma la realtà (per chi, come Saviano e noi, per ora non la subisce sulla propria pelle, s’intende) conta poco. Non conta tanto che i commentatori si siano avventati su una notizia forse falsa, o comunque incompleta e imprecisa. Conta invece che, ancora una volta, la morte di un corpo altro e lontano viene strumentalizzata nell’infosfera mediatica, solo per coprire la nostra incapacità di sostenere il disorientamento che ci investe: è una retorica di stampo “positivo”, che vorrebbe esprimere solidarietà con il popolo afghano, ma che in fin dei conti non fa altro che sovradeterminarlo secondo desideri, pensieri e interpretazioni che probabilmente non sono i suoi, o che comunque non possiamo conoscere con precisione.
Scriveva Jacques Rancière ne Lo spettatore emancipato:
«Se l’orrore è banalizzato, non è perché vediamo troppe immagini. Sugli schermi non vediamo troppi corpi sofferenti, ma troppi corpi senza nome, troppi corpi incapaci di restituirci lo sguardo che rivolgiamo loro, vediamo corpi che sono oggetto di discorsi, ma che sono privi della possibilità di parlare. Il sistema dell’informazione non funziona nutrendosi dell’eccesso di immagini, funziona selezionando gli esseri parlanti e ragionanti capaci di decriptare il flusso dell’informazione che riguarda le moltitudini anonime».
Un tale eccesso di discorso, il volontarismo cognitivo da parte dei commentatori occidentali di questi giorni stanno dunque producendo una “banalizzazione dell’orrore” afghano. Il messaggio, che pure inconsciamente si vuol far passare attraverso il corpo di Khasha Zwan (o meglio, attraverso l’immagine del suo corpo), è un messaggio rassicurante: i talebani sono un gruppo di fondamentalisti “medievali”, rozzi e ignoranti, che “hanno paura” (sic) dell’ironia, della libertà di pensiero e d’espressione, della musica.
Che hanno paura, in ultima istanza, dei buoni principi democratici (per come pensiamo di conoscerli). Si tratta di un automatismo davvero rivelatore perché è sintomatico di una situazione di impotenza, perché vuol farci credere che per sconfiggere il fanatismo siano sufficienti le armi della tradizione illuministica, di cui tutto sommato già disponiamo e che magari possiamo pure esportare alla bisogna. Ma non sono certo l’ironia, l’arte e la democrazia a far paura ai fondamentalismi, non lo hanno mai fatto. Al massimo, lo sono le condizioni materiali che questi tipi di libertà rendono possibili e concretamente praticabili, sempre che ci sia qualcuno che desideri assumerseli come orizzonte di lotta.
Andare a scorgere in ogni piccolo segnale un tale desiderio, interpretare qualsiasi gesto vagamente oppositivo come un gesto di “resistenza” e di “eroismo”, laddove invece esistono rapporti di forza più intricati e probabilmente ancora poco chiari, esprime allora l’ansia di voler essere comunque noi protagonisti al centro della tragedia afghana, di voler occupare il campo del simbolico dopo aver abbandonato in fretta e furia il terreno di battaglia.
Ma la verità, triste, che la retorica à la Saviano e Tosa tende a nascondere è che su questo terreno di battaglia verrà inevitabilmente versato ancora parecchio sangue e coloro che si sentono solidali col popolo afghano ora possono osservare quanto sta accadendo solo in qualità di spettatori, di “testimoni secondari” come diceva Cesare Cases a proposito dei grandi conflitti del Novecento. Se spettatori e testimoni “emancipati”, per restare fedeli a Rancière – vale a dire testimoni capaci di sospendere un minimo il giudizio, di leggere il flusso delle immagini anonime senza decriptarlo secondo principi prestabiliti, di non rendere le urla e il riso per forza degli insegnamenti – ecco, quello forse possiamo ancora sceglierlo.
Immagine di copertina da commons.wikimedia.org