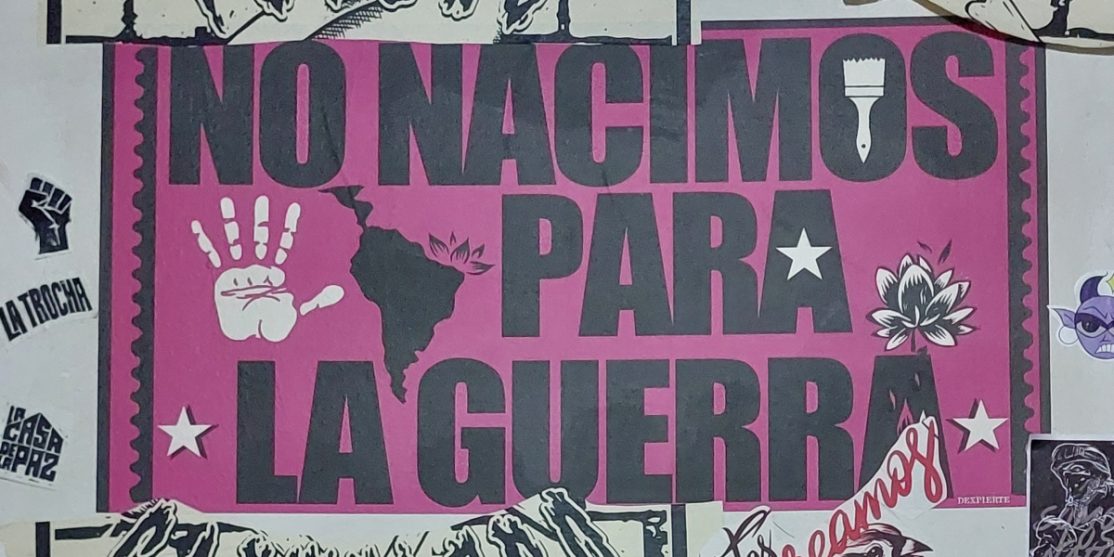POTERI
Altro che #happydays

Molto fumo e poco arrosto nelle strategie europee di Renzi, mentre il progetto riformista arranca e la stagnazione dilaga.
Il ritorno di Renzi da Bruxelles è stato salutato con fanfare ma da scarni resoconti di concessioni fattuali. Basti leggere l’intervista rilasciata dal suo ventriloquo razionale, il sottosegretario neo-catecumenale Delrio, che alla domanda se allargare la flessibilità vuol dire togliere il tetto deficit/Pil al 3% risponde: «Non credo sia una legge scolpita per sempre nella pietra ma non vogliamo essere noi a spostarla sulla sabbia». Vorrei, ma non posso, anche se la Germania lo ha fatto nel 2003.
Allora che vuol dire? Non considerare deficit una parte della spesa, magari il cofinanziamento per la messa in sicurezza delle scuole o del territorio, chissà se si possono sommare le voci fino a raggiungere i 10 miliardi. Si potrebbe mutualizzare il debito cedendo parte del patrimonio immobiliare e non: dismissioni, privatizzazioni e derivati –ma che bello e soprattutto mai sperimentato (con disastri). Ah, ecco, tante riforme istituzionali, a casaccio ma a scroscio. Senza troppo tagliare i deputati. E senza preferenze, soprattutto. Voto anticipato? No, però se le riforme non passano, qualcuno se ne prenderà la responsabilità. Leggi: voto anticipato ad autunno.
Intanto il debito pubblico si gonfia e il Pil stagna o regredisce leggermente, comunque ben lontano dalla previsioni governative, mentre i consumi restano fermi e la disoccupazione sale inesorabile, tornando a maggio al picco del 12,6%.
Le autorità europee hanno ribadito senza deroghe il divieto di oltrepassare il rapporto tra deficit pubblico e prodotto interno lordo pari al 3% e le regole ancor più stringenti del patto di Stabilità e del Fiscal compact. Hanno respinto la richiesta italiana di spostare il pareggio di bilancio dal 2015 al 2016. Il tutto condito da belle frasi sulla (già esistente) flessibilità in documenti di valore meramente consultivo e da generici inviti ad aumentare gli investimenti per creare più posti di lavoro, purché partano o si implementino «riforme strutturali che agevolino la crescita e migliorino la sostenibilità dei bilanci». Insomma, ulteriore smantellamento della protezione dei lavoratori e del welfare. Respinta anche la richiesta di potere utilizzare i fondi europei senza dover contribuire con stanziamenti propri. Rinviata alla nuova Commissione (fra sei mesi) e a Juncker la facoltà di decidere su eccezioni nazionali nella tempistica.
Al di là del solito balletto renziano di vanterie e promesse senza costrutto, come se fosse antani, vale però la pena di riflettere sulle novità che intervengono sotto il nome di post-austerità: al contempo presa d’atto del fallimento dell’austerità neo-liberale e sua riproposizione a livelli più penetranti di sfruttamento.
Spogliate dalle tinte elettoralistiche o governamentali, di populismo autoritario o di Grosse Koalition (alludiamo, rispettivamente, agli 80 € renziani e all’innalzamento tedesco del salario minimo), le misure anticicliche assunte dai governi e sostitutive (specialmente in Italia) di una dinamica rivendicativa dal basso sono un eccellente esempio del tentativo di instaurare politiche attive e del lavoro, supportate nel primo caso da esperimenti workfaristici ancora incerti (legge Poletti, Garanzia Giovani e bozze del Jobs Act), nel secondo da collaudate misure quali i mini-jobs dello Hartz IV, che ora il salario minimo a 8,50 € corregge in senso espansivo.
Renzi cavalca avventurosamente questa strategia, senza l’ausilio di una struttura industriale governabile e in una situazione di immutata stagnazione. Per di più nello sfacelo di partiti di massa e sindacati che servano da apparati di percezione, trasmissione e compensazione; anzi dissolvendoli definitivamente con il suo stile becero di uomo solo al comando, senza mediazioni e negoziazioni.
In un fondamentale articolo esplorativo sulle nuove tendenze neo-liberali e sul sindacalismo sociale pubblicato su questo sito da A. De Nicola e B. Quattrocchi si spiega che «lo Stato nazionale, lungo il ciclo neo-liberale, continua a svolgere una funzione regolativa della redistribuzione attraverso le politiche fiscali, disciplinando gli istituti della contrattazione salariale e attraverso il passaggio dal welfare universale al work-fare e ai sistemi improntati ad una logica di residualità». Funzione equitativa e di governo della forza-lavoro che diventa essenziale per cercare di superare la crisi e per gestire le relazioni internazionali fra i grandi settori imperialistici e i nuovi soggetti emergenti, i Bric. Le proporzioni, sempre variabili, fra rendita finanziaria e profitto industriale e le gerarchie fra aree capitalistiche si ridefiniscono anche in funzione delle politiche attive nazionali del lavoro e della liquidità bancaria e dei livelli ineguali di crescita, ciò che conferisce una base oggettiva alle diverse strategie di Usa e Ue e alle differenziazioni interne all’Ue.
Tuttavia la ripresa, malgrado un avvio Usa presto rientrato, non c’è stata, i Bric non tirano una vertiginosa crescita mondiale delle esportazioni, l’Europa sta messa piuttosto male (proprio per le sue esitazioni nella conversione da austerity a post-austerity) e l’Italia in particolare è immersa in una stagnazione che la fa sorpassare dalla Spagna e forse perfino dalla malconcia Grecia. La governance europea e quelle nazionali riescono ancora a controllare la forza-lavoro tradizionale e precarizzata, ma non la deflazione e la disoccupazione. Quest’ultima serve loro per il controllo, ma la deflazione strozza la domanda interna e ostacola l’altra leva di una politica di ricatto, l’offerta di un pezzo di pane complementare alla minaccia di una povertà emarginante.
Inoltre l’amministrazione europea deve, detto brutalmente, salvarsi il culo, cioè frenare le crescente pulsioni populiste e sovraniste che farebbero saltare la macchina sovranazionale e tutti gli interessi che le si sono aggregati intorno, quindi delegare ai governi nazionali il compito di smorzare le insofferenze più acute e gli accessi di xenofobia e fascismo fingendo maggior benevolenza verso le vittime della crisi. La sempre più probabile ascesa di Marine Le Pen alla Presidenza della Francia dopo i guai di Sarkozy getta un’ombra perfino sulla tenuta della Merkel.
Renzi inserisce il suo rutilante discorso sulle riforme in questi spazi e cerca di farne un punto di forza anche nel semestre europeo, sostituendosi alla Francia nella rappresentanza del Sud-Europa. Peccato (per lui, non per noi) che non abbia le basi materiali per sostenere questa ristrutturazione “post-austera” e debba limitarsi a residualizzare le vecchie strutture desuete di epoca fordista (partito di massa e sindacato, certi rami di amministrazione statale) e a bloccare le rivendicazioni sociali, in parte anticipandole con sedazioni di breve respiro (80 €), in parte cercando di schiacciarle (pubblico impiego, occupanti case), senza però riavviare una ripresa che sola gli conferirebbe legittimità e consenso di tipo non effimero. La situazione debitoria gli impedisce, d’altronde, di ridurre sostanzialmente le tasse e in genere i bei tempi del riformismo bellico-finanziario alla Blair (il suo modello) sono da un pezzo tramontati.
Stesse sereno Matteo, gli #happydays non torneranno, quali che siano gli slogan delle riabilitate Feste dell’Unità. E faremo di tutto perché ciò non avvenga.