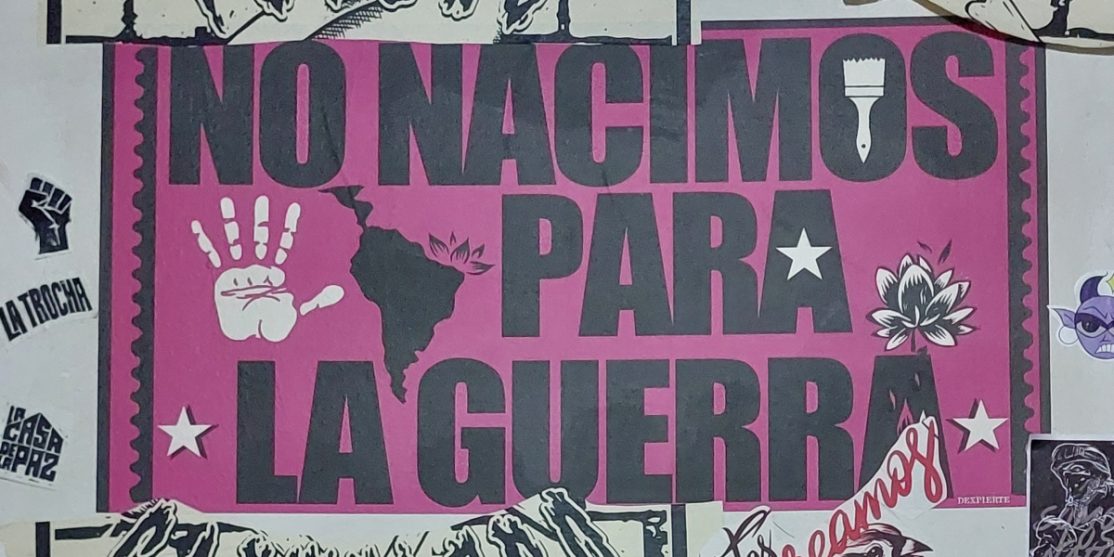ITALIA

Processo Stefano Cucchi: “non mi uccise la morte ma due guardie bigotte”
La morte di Stefano Cucchi è rimasto un mistero per molti anni, pur essendo svelato già in partenza dalle evidenze sotto gli occhi di tutti. La responsabilità è stata attribuita per legge a due agenti, anche se imputabile dovrebbe essere anche il sistema che ha permesso ciò che è avvenuto e l’omertà di chi non ha parlato
«Possiamo dire che è stato ucciso di botte, che giustizia è stata fatta nei confronti di coloro che ce l’hanno portato via», dichiara Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Ieri quattro aprile, a distanza di 13 anni dall’assassinio di Cucchi arriva la condanna definitiva dalla Cassazione ridotta da 13 a 12 anni per omicidio preterintenzionale dei militari dell’Arma Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro.
La famiglia del ragazzo dopo le numerose calunnie e accuse da parte della destra italiana e dal sindacato della polizia, per i quali la causa della morte sarebbe imputabile al solo abuso di droga, ha portato a galla la verità sui fatti.
La sera del 15 ottobre del 2009 Stefano Cucchi viene fermato dai carabinieri della stazione Appia nella zona del parco degli Acquedotti a Roma, senza un’apparente motivazione. Nelle sue tasche qualche grammo di hashish, cocaina e farmaci per l’epilessia di cui soffriva. Viene portato in caserma e in seguito a casa per una perquisizione, dove i genitori lo vedono per l’ultima volta in buona salute.
La ricerca non rileva niente, ma il giorno seguente l’attende un processo per direttissima per convalidare l’arresto. Stefano passa la notte in bianco, ma a tenerlo sveglio non è la preoccupazione per il carcere, bensì le violenze che subisce da parte delle forze dell’ordine in caserma.
I segni degli abusi da parte degli agenti sono palesi in aula durante l’udienza e non solo ai familiari, infatti viene visitato dal medico del tribunale prima di essere trasferito al carcere di Regina Coeli; qui un’altra visita, poi il trasferimento al pronto soccorso, dove rinuncerà al ricovero, che sarà obbligato e d’urgenza il giorno seguente a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche.
Stefano in una settimana attraversa due caserme dei carabinieri, le celle di sicurezza, le aule e l’ambulatorio del Tribunale di Roma, l’infermeria e una cella del carcere di Regina Coeli, il pronto soccorso del Fatebenefratelli, il reparto detentivo dell’ospedale Sandro Pertini dove la degenza durerà sei giorni, fino al decesso. Durante questo tempo i familiari tentano di fargli visita, ma non gli è permesso di vedere Stefano, né tanto meno di avere notizie circa le sue condizioni.
Nessuno prende in carico Stefano Cucchi, ragazzo di trentun anni, nessuno denuncia i segni delle violenze, per tutti è più semplice credere alla giustificazione fornita: una caduta dalle scale.
Nei giorni seguenti le associazioni A buon diritto e Antigone entrano in contatto con la famiglia e avviano il procedimento volto a fare luce sulla morte, anche in seguito alle foto del corpo fornite dall’agenzia funebre ai familiari e in seguito divulgate. Un processo durato 13 anni, 150 udienze e 15 gradi di giudizio, che ancora attende la conferma di 4 anni di reclusione per Roberto Mandolini e 2 anni e mezzo per Francesco Tedesco accusati di falso, con rischio della prescrizione sull’appello bis.
Le violenze da parte dei corpi di polizia non sono un’eccezione, testimoni i fatti del G8 di Genova. Gli abusi delle forze dell’ordine sono avvenuti e continuano ad avvenire in caserma, in carcere e in piazza e sono diverse le associazioni e i movimenti che nel tempo si sono occupate di monitorarli, tra cui appunto A buon diritto, Antigone e Acad (Associazione contro gli abusi in divisa).
Federico Aldrovandi, Aldo Bianzino, Giuseppe Uva, Arafet Arfaoui, Stefano Frapporti, Serena Mollicone sono solo alcuni dei nomi di persone ammazzate dalla forza pubblica, non tutte hanno trovato verità, ma in tutte ci sono elementi che ricorrono: l’occultamento delle prove e la ricerca di espedienti a carico della vittima per giustificare l’accaduto, l’assenza di comunicazione con i familiari, il silenzio del personale sanitario dei reparti detentivi.
La risposta istituzionale a tutto ciò non pare essere ancora matura, nel 2017 dopo 29 anni dalla prima proposta la Camera ha approvato la legge sulla tortura, ma con diverse rimostranze da parte dei soggetti attenti ai diritti umani, come le associazioni sopracitate e Amnesty International. In particolare a destare contrarietà sono tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari.
Le motivazioni che spingono a sollevare perplessità e a richiedere di qualificare la tortura come reato proprio e non come atto di violenza tra individui qualsiasi, non vuole essere un accanimento nei confronti dei corpi di polizia, spiegano le associazioni nei loro siti web, ma sottolineare questi trattamenti inumani che avvengono in un rapporto di potere disuguale e tramite l’abuso di autorità da parte di chi avrebbe il compito di tutelare cittadini e cittadine.
Luigi Manconi presidente di A buon diritto in una intervista pubblicata sull’Espresso del 2017 rispondendo a una domanda sul ritardo rispetto all’introduzione del reato dichiarò « si preferisce che i corpi di polizia restino così come sono: compatti e omogenei, gerarchicamente immobilizzati e scarsissimamente permeabili a quanto accade nella società e, di conseguenza, sempre pronti a tutelare gli interessi di quanti tra loro commettono reati, ricorrono a trattamenti inumani o degradanti, esercitano la tortura. E, invece, sarebbe interesse dello Stato democratico indurre i corpi di polizia ad autoriformarsi, a sottoporsi a un processo di verifica delle proprie convinzioni democratiche, ad acquisire consapevolezza dei rischi che quel mestiere, inevitabilmente, comporta».