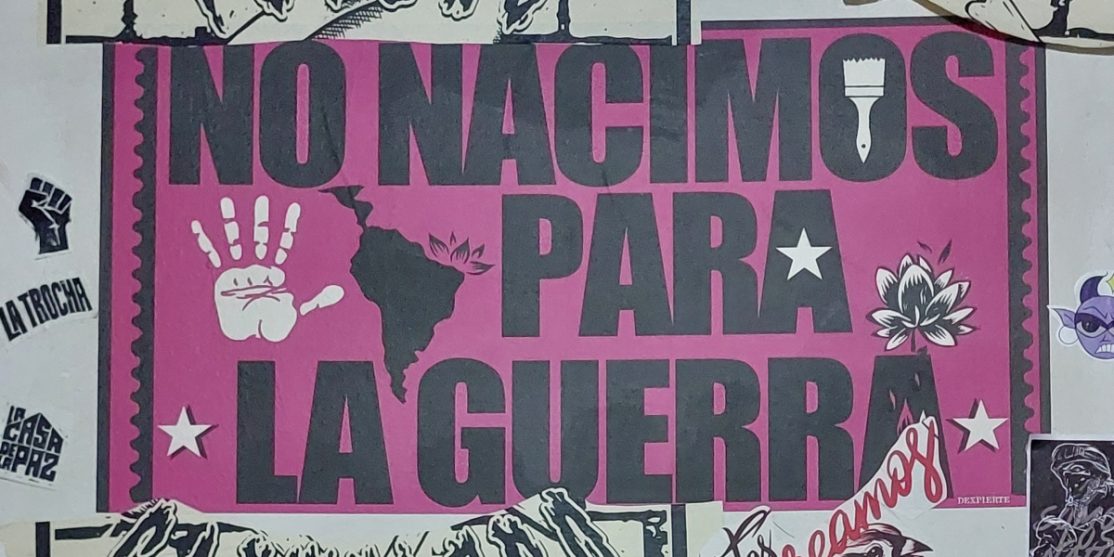PRECARIETÀ
Per non morire di merito.

Strategie di resistenza nell’università della promessa, un contributo del collettivo degli intermittenti della ricerca di Roma. L’utilizzo strumentale del paradigma del merito nell’imporre le ultime riforme del mondo della formazione e il progressivo definanziamento del comparto, in nome dell’efficienza e della solvibilità del debito pubblico richiesta dall’Unione Europea, ha profondamente ridisegnato i meccanismi di funzionamento delle Università e di conseguenza la composizione sociale e le figure lavorative che le attraversano. Intento del testo che presentiamo è l’analisi di queste trasformazioni e la descrizione in via preliminare dell’impatto che queste ultime hanno avuto sul lavoro precario svolto nelle Università e sulla funzione sociale dell’Università del Merito nell’epoca del biocapitalismo finanziario, alla luce, inoltre, degli ultimi provvedimenti del Governo Renzi.
Nella Legge di Stabilità è stato recentemente approvato un ulteriore taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per un importo pari a 1,4 miliardi di Euro (su 7 miliardi totali, il 20%) dal 2015 al 2023. Una riduzione superiore ai tagli draconiani introdotti con la riforma Gelmini, sia in termini assoluti che relativi. Non essendoci un Governo Berlusconi da destituire come nel 2010, i media mainstream naturalmente si guardano bene dall’attaccare Renzi e il suo Partito della Nazione, soprattutto su un terreno che renderebbe evidenti le contraddizioni del Governo sui temi della formazione, della disoccupazione giovanile, della crescita e della competitività globale. I tagli ai bilanci delle Università appaiono in netta controtendenza rispetto agli altri paesi europei dove la spesa per le istituzioni accademiche e per la formazione superiore è in notevole aumento, dalla Germania (+20% dal 2008 ad oggi) alla Francia, per non citare i paesi Scandinavi. L’Italia è infatti secondo l’Ocse il paese che negli ultimi anni, dal 2008 in poi, ha disinvestito maggiormente nel settore innovazione e ricerca (-14%), aumentando, di conseguenza, l’importo delle tasse universitarie (+63% in dieci anni). Tutto ciò mentre in Germania, che investe pro-capite per la ricerca il triplo delle nostre risorse, l’accesso alle Università è nuovamente gratuito per legge, stranieri e fuori corso inclusi. Tuttavia, le trasformazioni profonde cui sono soggette le Università non dipendono unicamente dall’entità dei tagli, seppur molto cospicui: un ruolo fondamentale nella metamorfosi del mondo della formazione è svolto dai meccanismi di valutazione degli atenei, promossi dalla retorica del merito e dell’efficienza, con l’obiettivo dichiarato di eliminare le sacche di clientelismo baronale presenti all’interno dei dipartimenti. I criteri quantitativi introdotti per una valutazione “trasparente” e “oggettiva” sono, e sono stati, spacciati come neutri, al riparo da qualunque controversia, in quanto indicatori matematici. In realtà, i parametri di valutazione sono stati definiti a priori dall’Agenzia plenipotenziaria ANVUR, attraverso un processo predittivo regolato dell’idea di Università che si è voluto imporre.
La ripartizione fra le Università della porzione premiale dell’FFO (ora pari a 1,5 miliardi di Euro su 7 che diventeranno 5 miliardi su 5,5 a regime) viene infatti determinata sulla base di indicatori come il numero di laureati che trovano lavoro entro un certo periodo dalla laurea, la capacità di attrarre finanziamenti esterni, il numero di laureati per iscritti, la porzione di budget assorbito dalle spese per il personale, la valutazione della ricerca e, novità renziana dell’ultim’ora, i “costi standard” e una fantomatica “internazionalizzazione”. Si evince facilmente come i primi due criteri siano volti a creare un sistema universitario a più velocità, fondamentalmente su base territoriale: un numero, esiguo, di atenei di serie A, immersi in un tessuto produttivo favorevole (concentrati quindi nelle regioni del Nord) e un insieme, più numeroso ma non troppo, di atenei di serie B, molti dei quali concentrati nelle regioni meridionali. Le Università di Serie A, superstiti della innaturale selezione a colpi di ranking valutativi, diventeranno quelle che nel sistema anglosassone, non a caso, sono denominate Research Univerities. La ricerca diventerà prerogativa solo di questi atenei d’élite le cui attività saranno profondamente determinate da finanziatori privati, con l’intento di formare quadri aziendali gratis e avere centri studi a costo zero. La formazione e l’individuazione delle linee di ricerca saranno quindi ritagliate sulle esigenze del mercato, spesso di corto respiro, rimuovendo in via definitiva il concetto di autonomia della ricerca. Gli atenei di Serie B, o Teaching Universities, assolveranno invece una funzione ben diversa: offrire un’alternativa alla disoccupazione alle generazioni che le attraverseranno, in altre parole un parcheggio per giovani. Va da sé che in questi atenei vi sarà un forte declassamento della qualità della didattica (conseguenza anche dell’indicatore che tiene conto del numero di laureati/iscritti) dato che il fine ultimo è la consegna di un diploma completamente svuotato di significato, utile unicamente a partire con qualche punto di vantaggio nella giungla della precarietà lavorativa che attenderà i neo-laureati al termine del percorso “formativo”. Inoltre, per questi atenei di servizio si intravede in realtà un percorso di progressiva dismissione, arrivando in tempi più o meno brevi alla chiusura di numerosi dipartimenti, se non di intere sedi. Le Università, da potenziale motore per la crescita sociale, economica e culturale delle zone più depresse, vengono quindi trasformate in fonti di ulteriori criticità e disoccupazione. Questo processo di differenziazione degli atenei restaurerà un sistema accademico a forte connotazione classista, considerando il prevedibile aumento esponenziale delle tasse universitarie degli atenei virtuosi (già in parte avvenuto in tutti gli atenei per migliorare l’indice spese per il personale/entrate, sforando il tetto del 20% dell’FFO imposto per legge) ed i costi della mobilità. Il diritto all’accesso a una formazione universitaria plurale e di qualità viene quindi trasformato in un diritto esclusivo riservato ai ceti più abbienti, alle classi dominanti.
In questo processo di ristrutturazione dell’accademia, che ha come suo principale modello quello dell’impresa, il sapere diviene quindi mero bene produttivo. Il principio competitivo, sotto le spoglie del merito e della valutazione, estende così le logiche di mercato a tutte le relazioni sociali, senza risparmiare la così detta “torre d’avorio” della formazione superiore. La produzione di sapere basata sulla cooperazione sociale, la condivisione delle conoscenze, la messa in discussione dei meccanismi di riproduzione del pensiero dominante cede il passo a un’università pubblica modellata su egoismo e individualismo e costruita intorno a un’accezione meramente economica della competitività. In sintesi, le Università diventeranno direttamente luogo di formazione di persone addestrate allo sfruttamento e, contemporaneamente, luogo privilegiato di estrazione diretta di capitale umano per il mercato del lavoro (precario). Nell’ambito specifico del lavoro precario svolto all’interno degli atenei, le dinamiche competitive appena illustrate hanno potuto innestarsi solo a seguito della frammentazione del mondo della ricerca ottenuta attraverso le riforme che dal 2005 hanno trasformato drasticamente l’assetto universitario e la figura giuridica del ricercatore. Con la legge Moratti (2005) si è stabilizzata la precarizzazione nel mondo della ricerca eliminando i contratti di ricercatore a tempo indeterminato, RTI, (l’unica forma professionale di inserimento stabile nelle Università), mentre la riforma Gelmini del 2010 ha dato l’ultimo colpo di grazia, definanziando in modo considerevole il comparto università e introducendo ben due figure di ricercatore a tempo determinato (RTD A/B) in sostituzione dei vecchi RTI, bloccando di fatto l’entrata in ruolo dei precari. Parallelamente e, forse, per bilanciare questa crescita vertiginosa del numero di ricercatori precari, la riforma Gelmini ha anche fissato un tetto massimo per la durata degli assegni di ricerca (4 anni) creando le condizioni per un’espulsione di massa degli assegnisti (6000 all’anno, da quest’anno in avanti), che saranno riassorbiti solo in parte esigua dalle nuove forme contrattuali a tempo determinato (dal 2011 al 2014 sono stati banditi soltanto 300 RTD A/B ogni anno).
Le “innovazioni” di questi anni hanno determinato le dinamiche interne agli atenei, promuovendo e stabilizzando un sistema già pienamente consolidato nelle università a gestione baronale, caratterizzato da ricattabilità, cooptazione e, soprattutto, dall’economia della promessa. E’ infatti l’eterna promessa di un dottorato prima, un assegno, un contratto da ricercatore a tempo determinato o addirittura un posto da Professore Associato dopo, a determinare i meccanismi perversi di cooptazione, declinati in forma di affiliazione paternalistica al Professore di turno, e di riproduzione della composizione precaria all’interno delle Università. In quest’ottica, i precari della ricerca, soprattutto dottorandi ed assegnisti, sono costretti a svolgere mansioni che non dovrebbero competere loro (lezioni, esami, attività di segreteria, gestione totale degli aspetti amministrativi di congressi e conferenze, servizi di autista, per ricordarne solo alcune). A queste attività corollarie si aggiunge il lavoro più prettamente di “ricerca”, che in realtà con la ricerca ha poco a che fare. In termini pratici, tale lavoro è finalizzato ad aumentare l’impatto del proprio Professore sugli indici di valutazione accademica, funzionale, per non dire fondamentale, all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed europei. Questi ultimi, rappresentano allo stato attuale la fonte principale di finanziamento delle strutture di ricerca, con i quali vengono retribuite le varie figure precarie all’interno delle Università. Si viene così a creare un perverso circolo vizioso per il quale la sopravvivenza dei precari all’interno delle università è completamente vincolata al successo del proprio Professore nei bandi nazionali e, soprattutto, europei. Non si fa quindi ricerca seguendo i propri interessi, le proprie passioni, intravedendo una ricaduta sociale delle proprie ricerche, per la propria carriera accademica o per un supposto amore per il sapere, ma si lavora per incrementare la produzione scientifica del proprio Professore. A tal fine si scrivono articoli, se va bene a doppio nome, e saggi ad hoc unicamente per citare i lavori precedenti del proprio Professore e della rete internazionale di citazioni cui appartiene (l’evoluzione nell’Università del Merito e dell’Eccellenza della vecchia cupola degli ordinari, non più difendibile pubblicamente). Questa dinamica, tuttavia, genera, per lo meno nelle discipline scientifiche, una vera e propria bolla inflattiva delle citazioni (andando a mettere in discussione totalmente l’oggettività e la trasparenza delle procedure di valutazione) e va ad aumentare esponenzialmente il peso, e quindi il potere, del proprio Professore di riferimento, in cambio di qualche briciola di citazione, un articolo pubblicato in una non meglio definita rivista di fascia A (per le materie umanistiche), e qualche evanescente promessa di rinnovo contrattuale elargita ai precari.
Nello scenario attuale, dunque, l’unica possibilità di sopravvivenza dei precari all’interno degli atenei è quasi sempre vincolata ad una completa messa a disposizione delle proprie vite a favore del Professore, nella speranza che in cambio quest’ultimo, grazie alla sua eccellenza bibliometrica costruita a tavolino e alle relazioni di potere che ha saputo tessere all’interno dei dipartimenti, riesca a mettere in piedi bandi cuciti su misura per i suoi collaboratori dove l’unico parametro di valutazione è il grado di fedeltà. Il valore della ricerca svolta (quelli vera) magicamente scompare. La sopravvivenza è quindi strettamente legata all’instaurazione di una dipendenza, oggi sempre più mortale. Parallelamente, il costante definanziamento delle Università ha addirittura peggiorato i livelli di sfruttamento cui sono sottoposti i lavoratori precari della ricerca. La diminuzione in questi anni del turnover (dove non del tutto bloccato) ha infatti instaurato una guerra fra gli ultimi producendo livelli di auto-sfruttamento totalizzanti, una vera e propria messa a valore delle intere esistenze. Sono sempre più diffuse le prestazioni lavorative gratuite all’interno delle Università, percepite però spesso dai lavoratori precari come processi di auto-valorizzazione. L’esistenza di pratiche sempre più diffuse di lavoro gratuito testimonia come ancora una volta le Università siano state in questi anni, e lo sono tuttora, dei laboratori per la prescrizione delle soggettività nel resto della società.
Alla luce del quadro appena descritto, è evidente come una trasformazione dell’esistente sia possibile unicamente attraverso l’organizzazione collettiva di pratiche di conflitto incisive ed espansive da parte di ricercatori, studenti e dottorandi, a patto naturalmente di mettere da parte i corporativismi diffusi che si riscontrano nell’ambiente, di sottrarsi alla sempre più dilagante e degradante guerra fra gli ultimi e di mettere invece al centro del proprio agire politico la funzione sociale delle Università, l’autonomia della ricerca, un percorso formativo libero e di qualità, la rivendicazione di una continuità di reddito, e quindi di dignità, per sottrarsi dalla morsa della precarietà e da tutte le dinamiche che ne derivano. Le Università nell’Era del Merito e dell’Eccellenza, sono infatti istituzioni che tenderanno ad avere come unico fine la propria riproduzione, conservando i sistemi di potere feudali, mascherati con il merito e i meccanismi di valutazione, con lo scopo di continuare a redistribuire al proprio interno, in modo strettamente piramidale, soldi e potere. Affacciandosi anche, per aumentare i propri asseti, nel campo della finanza speculativa alla quale già avranno garantito un flusso cospicuo e costante di denaro proveniente dall’indebitamento studentesco, necessario per poter accedere ad una formazione universitaria di medio – alto livello (le Università di Serie A descritte sopra). E’ quindi chiaro come invece vada ristabilita e riconquistata la vera funzione sociale delle Università, ovvero l’elaborazione e la trasmissione del sapere, che non può darsi in un quadro individualista e competitivo, ma deve necessariamente trarre la propria forza da processi virtuosi di cooperazione e condivisione. Anche perché è utile ricordare che dal 2002 al 2013 (quando qualche soldo arrivava ancora) l’auto-sfruttamento e la guerra fra i poveri all’interno dei dipartimenti sono stati ricompensati con la stabilizzazione di 500 assegnisti di ricerca su 55.000 (meno di 50 ogni anno, una frazione inferiore all’1%!), a riprova che le dinamiche di sottomissione e autodisciplinamento non pagano in nessun caso.
Nell’ambito specifico dei precari della ricerca l’organizzazione collettiva è quindi l’unica pratica potenzialmente in grado di cambiare realmente le dinamiche perverse che agiscono su questa soggettività, partendo da un elemento di forza che la precarizzazione massiccia delle figure professionali ha prodotto negli ultimi anni: la porzione di lavoratori precari nei dipartimenti è in costante aumento superando in alcuni casi specifici il numero degli strutturati. E’ quindi evidente come i dipartimenti si reggano in piedi unicamente sfruttando il lavoro dei ricercatori precari. Questo è un elemento centrale su cui si innesta in modo naturale la prospettiva di lungo termine cui deve tendere la mobilitazione dei precari della ricerca, ovvero il blocco completo dall’interno del funzionamento dei dipartimenti. Analogamente a quanto accade per le figure precarie di qualunque ambito del mondo del lavoro, il raggiungimento di un tale scopo richiede l’aggregazione di un numero molto elevato di precari disponibili a mobilitarsi nonostante il ricatto della precarietà. A tal fine, è fondamentale da un lato innescare un processo di riconoscimento della propria condizione individuale come condizione in realtà comune a tutti gli altri precari, dall’altro ricostruire un’alleanza trasversale tra le figure subalterne del mondo universitario (ricercatori, studenti, dottorandi) per riconnettere e organizzare i differenti volti che assume la precarietà all’interno dell’Università. Le potenzialità reali di questo processo di riconoscimento si sono manifestate nel corso dello Sciopero Sociale del 14 novembre (attraverso le biografie degli Strikers) di cui è stato uno degli elementi vincenti, riuscendo a rompere lo spirito di rassegnazione e solitudine che caratterizza le componenti precarie del lavoro. Su questo piano del discorso va anche evidenziato come l’autosfruttamento e l’affiliazione al Professore di turno siano proprio quegli elementi che permettono al sistema attuale di riprodursi, rafforzarsi e di continuare quindi a imporre le dinamiche umilianti e la spirale di impoverimento descritte nei paragrafi precedenti.
A questo lavoro politico di soggettivazione, va affiancata una campagna informativa capillare che sappia mettere in luce come all’economia della promessa (già inaccettabile!) si stia sostituendo l’economia della menzogna, visto che un reclutamento irrisorio se non nullo è all’orizzonte per i prossimi anni (a fronte di un’espulsione massiccia di assegnisti e RTD-A). E’ anche necessario rifiutare i tentativi di cooptazione che verranno effettuati proclamando da una parte un incremento consistente dei bandi per RTD-A (vero, ma certamente infinitesimo rispetto alle espulsioni che ci saranno dal sistema e comunque si tratta di un contratto a tempo Determinato) e dall’altra una riapertura certa del reclutamento a fronte di una diminuzione consistente degli strutturati negli ultimi quattro anni (da 60.000 a 50.000) che andrà ad aggravarsi nei prossimi cinque (vero, ma il numero di immissioni sarà molto esiguo data l’intenzione di un chiudere un numero consistente di dipartimenti). Sempre sul piano discorsivo, è necessario mettere in atto delle pratiche comunicative in grado rovesciare le retoriche di eccellenza su cui “l’Università del Merito” è stata fondata, mettendone in luce le evidenti contraddizioni e denunciando come in realtà siano state strumentalmente utilizzate per conservare il sistema di potere esistente: cambiare tutto per non cambiare niente. Diventa inoltre fondamentale decostruire il piano del discorso che non riconosce il lavoro cognitivo svolto nelle Università come tale. E’ infatti opinione diffusa che voler seguire le proprie aspirazioni e le proprie passioni, voler scegliere un lavoro dal quale trarre delle soddisfazioni e che potrebbe avere un impatto sociale rilevante, sia quasi uno sfizio o, meglio, un lusso, e che quindi sia del tutto giustificato lo sfruttamento del lavoro gratuito e le diffuse finestre di intermittenza di reddito riscontrate fra i precari della ricerca. Ribaltare questo discorso è fondamentale sia per mettere in pratica una campagna per l’accesso agli ammortizzatori sociali per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che per ampliare e sostenere le campagne sul reddito di base, rivendicando il diritto fondamentale alla scelta del lavoro come elemento di libertà e il diritto a poter intraprendere un percorso di studi libero dal ricatto della precarietà. Sempre in questa direzione, per eliminare le dinamiche di ricattabilità e dipendenza è molto importante esigere l’accesso e la gestione dei finanziamenti da parte di gruppi autonomi di ricerca composti dalle diverse figure del mondo dell’Università in modo da poter ristabilire, almeno parzialmente, un’effettiva autonomia della ricerca e articolare un dispositivo di autoformazione all’altezza della fase attuale.
In conclusione, siamo convinti che nel nuovo assetto accademico ci siano le condizioni per organizzare un conflitto espansivo e incisivo nelle Università con l’obiettivo primario di bloccare dall’interno il funzionamento dei dipartimenti, agitando campagne specifiche (per esempio contro stage e tirocini gratutiti), cercando di ricomporre la componente studentesca con le varie forme di precarietà che attraversano le Università, provando a far tornare gli atenei uno dei luoghi propulsori per poi innescare dinamiche conflittuali nelle metropoli. In tal senso risulta fondamentale promuovere azioni diffuse di sottrazione da quelle attività lavorative che non competerebbero a studenti e ricercatori, dimostrando come di fatto “una settimana senza di noi”, incepperebbe il normale svolgimento delle attività accademiche. A fianco di iniziative come questa vanno sostenute ed organizzate forme collettive di sabotaggio e di inflazionamento dei criteri di valutazione. La cooperazione e la condivisione di spazi, saperi e conoscenze, la sottrazione dalle logiche di autosfruttamento risultano infatti le uniche strategie di resistenza per non morire di merito, per non autoescludersi (l’abbandono universitario è un altro dato importante da prendere in considerazioni) o per non essere espulsi dal mondo universitario e lavorativo post-lauream.
E’ quindi fondamentale in questa fase attivare la creazione di spazi di discussione, ricomposizione e organizzazione fra le varie figure che compongono il mondo della formazione. Per questo, riconoscendo la centralità del nodo della formazione nell’organizzazione di un movimento reale contro la precarizzazione delle nostre esistenze e visto lo spazio politico aperto dal processo dello Sciopero Sociale, crediamo sia importante partecipare al workshop sull’Università e la Ricerca nell’ambito del secondo appuntamento dello Strike Meeting (13-15 febbraio, Roma, blog.scioperosociale.it) e all’assemblea dei Ricercatori Non Strutturati, il 20 febbraio sempre a Roma, Università La Sapienza.
E’ arrivato il momento di battere il tempo dello Sciopero Sociale nelle Università.