cult
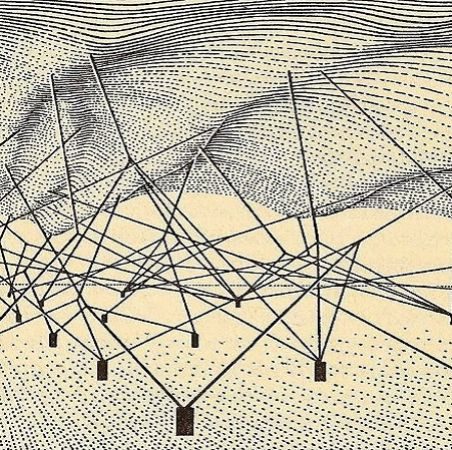
CULT
Karman
La rubrica CULT di DinamoPress e la Filosofia. Una recensione dell’ultimo saggio di Giorgio Agamben. Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto edito da Bollati-Boringhieri.
Questo Breve trattato sulla colpa, l’azione e il gesto, che Giorgio Agamben ha intitolato efficacemente Karman, non risulta inserito nella serie più celebre dell’Autore, Homo Sacer, ma condivide certamente con quest’opera i presupposti metodologici e alcuni dei principali esiti speculativi.
Un problema che i lavori di Agamben pongono è innanzitutto il seguente: per parlare di un qualsiasi problema filosofico, non è possibile interrogare direttamente gli oggetti stessi del pensiero, ma bisogna prendere un Umweg, una via obliqua, e ricercare prima di tutto dove quegli oggetti risiedono nel linguaggio, per attraversare così le nozioni e le rappresentazioni che di quell’idea noi abbiamo storicamente costruito. Esattamente come nella strategia di scrittura platonica è fondamentale la tessitura narrativa e dialogica, che ha lo scopo di sciogliere le tesi dei personaggi per mostrarne, infine, la cosa stessa, così per Agamben è fondamentale la ricerca storico-filologica, che permette di esporre i modi in cui l’idea abita nel linguaggio.
La ricostruzione etimologica e filologica delle nozioni di causa, di colpa, di azione, ha precisamente questo intento: mostrare infine il modo in cui queste nozioni possono esistere liberate dal linguaggio che le trattiene, dai modi in cui noi le abbiamo utilizzate impropriamente per dirigere il nostro comportamento. Una ricerca che non arrivasse a questo punto si fermerebbe a metà strada, e sarebbe del tutto inutile. In questo senso, le nozioni di gesto, inoperosità, potenza destituente, non sono altre nozioni, contrapposte rispetto a quelle di azione, di colpa, di potere costituente, etc., bensì sono queste stesse nozioni una volta che siano liberate dai loro più gravi fraintendimenti.
Non si tratta dunque, per Agamben, di sostituire a un modello sbagliato un modello giusto, il che significherebbe in definitiva lasciare intatto il dispositivo fondamentale, ma – secondo quella che è la genuina via filosofica – si tratta piuttosto di liberare quelle nozioni erronee, cristallizzate, a un uso inedito, sottratto a ogni sforzo e intento esecutivo. Quelle nozioni che contemplavamo separate, falsificate, segnate storicamente, le ritroviamo ora nel nostro uso abituale, come se avessero subìto solo una lieve modificazione – ma decisiva. La verità non è qualcosa che si metta in pratica, ma qualcosa che, una volta esperita, libera la vita nei diversi gesti (e questo carattere sperimentale appartiene a tutta l’opera dell’Autore). È un punto fondamentale, questo, su cui non si insiste mai abbastanza, e che maggiormente disorienta i lettori meno accorti.
Questo punto metodologico è, a ben vedere, anche l’oggetto del pensiero di Agamben. Non è semplicemente un problema giuridico, politico e etico a essere qui posto e risolto, ma una questione sotto ogni aspetto filosofica: qual è la relazione tra ciò che si è e ciò che si fa? Qual è lo statuto ontologico di quella particolare regione dell’essere che tradizionalmente identifichiamo con la prassi? Si può pensare l’essere umano – e soprattutto, la sua felicità – al di là di questa sfera? Ne Il Regno e la Gloria Agamben aveva ricostruito i modi tortuosi con cui la teologia cristiana ha tentato di articolare, in Dio, lo scarto tra essere e agire, nella costruzione della macchina governamentale-escatologica dell’occidente. Qui invece non è più il mistero del governo a essere interrogato, bensì l’origine della più tenace tra le superstizioni etiche e politiche occidentali, quella per cui l’uomo realizzerebbe nell’azione e nell’opera il proprio essere, per cui egli sarebbe prodotto da ciò che produce, frutto del proprio frutto.
Azione si può dare solo una volta che venga generato uno scarto interno all’essere, uno scarto su cui si fonda – Agamben lo ricostruisce bene – persino la tragedia greca, e nel quale si sono insediate e hanno preso dimora la morale e la politica occidentali. Essere e agire devono essere separati e non possono in alcun caso coincidere esattamente. Perché possa venire imitata e possa dunque diventare paradigma morale, l’azione deve aprirsi in una sfera separata, che non coincida con l’essere di ogni uomo, e retroagisca poi sul soggetto che la compie, segnandolo fatalmente. Volontà e libertà sono gli strumenti attraverso cui quello scarto verrebbe sanato, e quindi attraverso cui l’uomo si lega alle sue azioni, altrimenti anonime, e se ne appropria. Il pensiero buddhista riconosce nel desiderio di appropriazione (nella sete) questa pulsione immaginaria, che condanna l’uomo a un’infinita serie di nascite e tribolazioni, vittima della falsa idea di continuità di sé come soggetto agente. La norma, morale o giuridica, ha bisogno per esistere di questa zona opaca in cui le autentiche differenze etiche e ontologiche possano venire annullate e rese indifferenti, lasciando così spazio solamente a quelle giuridiche e morali. La necessità di questa zona ontologica indifferente, che sta accanto e retroagisce sull’essere, mostra anche la prossimità, sempre evidenziata da Agamben, tra diritto e linguaggio.
Le quattro sezioni di Karman rintracciano così questo legame tra colpa, azione e volontà, i diversi modi in cui si tenta di stringere l’uomo alla colpa (o, il che è lo stesso, alla virtù). Agamben rintraccia le origini di questo modello nel pensiero aristotelico. Qui il Bene non è più, come in Platone, un fatto di intonazione metafisica, ma diventa oggetto di una prassi, diventa l’agire bene di contro all’agire colpevole, sottomesso in questo modo alla norma e alle aporie dell’intenzione e della volontà. Agamben ricostruisce molto convincentemente queste aporie, fino a svolgere una critica penetrante della teleologia, in particolare kantiana.
Il Bene rappresenta il fine delle nostre azioni, a cui dobbiamo tendere attraverso la volontà, nostra libera facoltà di agire: così suona il più diffuso pregiudizio morale. Un’autentica esperienza etica, invece, che faccia esperienza del Bene, è in realtà esperienza dell’impossibilità del male, del fatto che esso non consiste mai in una serie di azioni sbagliate, ma in una impotenza trasformata confusamente in potenza (come Agamben scrive in una delle pagine più belle del suo libro più importante, La comunità che viene: «Il male è unicamente la nostra inadeguata reazione di fronte a questo elemento demonico [il potere di non essere], il nostro ritirarci impauriti davanti a lui per esercitare – fondandoci in questa fuga – un qualche potere di essere»). Il Bene è possibile solo attraverso un autoafferramento del male, e non può essere mai raggiunto grazie a una serie di azioni definite, prescritte, che lo fuggano.
Ma che cosa resta, dunque, se si tolgono all’etica queste sue categorie fondamentali, l’azione e la colpa? Riusciamo ancora a pensare le differenze etiche, senza le categorie di colpevolezza e innocenza, senza una morale che si risolva in una serie di imperativi? Si tratta forse per tutti noi di non agire? Le ultime pagine del libro sono, per tali questioni, fondamentali. Il problema non è l’azione, il karman, ma «il nesso che lega il dispositivo azione-volontà-imputazione a un soggetto» (p.128). Una volta spezzato questo nesso, restano i gesti, con cui questa ricerca sembra aprire a un nuovo soggetto etico, che potremmo forse identificare, restando nell’ambito buddhista, con lo stato «adamantino» della Tatha-ta, la parola sanscrita che vuol dire «esser-così», e che definisce l’affermazione piena e senza riserve, la forma indistruttibile dell’ethos.
Immagine tratta da qui
