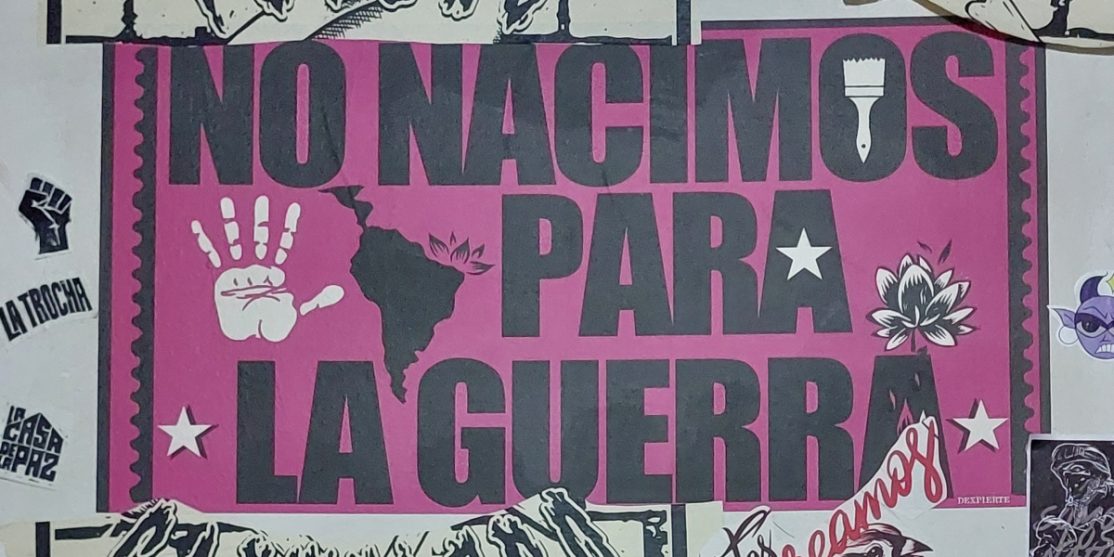ROMA

Giorni Felici e come fare i conti con l’infelicità. Intervista a Zuzu
In una caldissima estate romana tra il 30 giugno e il 3 luglio il festival del fumetto Bande De Femmes è stato ospitato nel quartiere Pigneto, con domicilio alla Libreria Tuba. In questo contesto, nella varietà dellə artistə che hanno presentato il loro lavoro, c’era ZUZU, la giovanissima fumettista candidata recentemente al Premio Strega con il suo nuovo fumetto «Giorni Felici»
Zuzu, nella vita Giulia Spagnuolo, ha 26 anni ed è salernitana. Le sue pubblicazioni sono iniziate nel 2019 con «Cheese» e, passando per diverse collaborazioni anche con “Internazionale” e “Repubblica”, è approdata nella strade del Pigneto per presentare il suo ultimo fumetto Giorni Felici. Ciò che salta subito all’occhio, interagendo con lei, è la sua giovane età, coronata da una profonda intelligenza emotiva che trasmette nelle sue storie e nelle sue parole. Giulia, infatti, non racconta solo fiction immaginifici e distanti, ma si tuffa nella crudele dimensione dei disturbi alimentari, delle relazioni tossiche e violente e della solitudine. D’altro canto, tuttavia, ciò che la riconduce immediatamente al lettore con empatia sopraffina è la capacità di non dare giudizi etici rispetto agli accadimenti della vita. E’ necessario rimanere presenti sia di fronte alle negatività, che di fronte a ciò che in fin dei conti dà sapore alle giornate di tutti: le avventure che viviamo e la bellezza di condividerle con qualcuno.
Complice questa profondità, i testi di Zuzu si rivelano essere fenomenologie di trasformazioni così intense da cambiare i nostri tratti somatici. Per questo motivo, Zuzu in Cheese e Claudia in Giorni Felici non sono solo sterili personaggi di storie di fantasia, ma sono mappe in cui viene tracciato un percorso esistenziale che, in realtà, tutte le persone vivono. In bilico tra la fiction e l’autobiografia, a Giulia non interessa raccontare qualcosa di specifico, ma di condividere le magiche lenti con cui lei guarda questo mondo. Ma, soprattutto, la sua opera si realizza nella capacità del lettore di iniziare a guardare attraverso le proprie di lenti. E in questa intervista ce lo racconta molto bene.
Ciao Giulia, vorrei partire da te: presentati.
Ciao, sono Giulia ho 26 anni. Ho fatto il liceo classico, ho disegnato tutta la mia vita e poi mi sono fermata durante l’adolescenza perché non mi sentivo all’altezza del compito perché ho iniziato a subire il concetto di “bel disegno”. Poi ho ripreso l’ultimo anno di liceo quando mia madre mi ha convinto a iscrivermi allo IED, indirizzo illustrazione. Perché da quel punto di vista ha sempre creduto in me, più di quanto facessi io stessa. Ho studiato il disegno e, nel 2019, per la mia tesi, invece di proporre un racconto illustrato ho proposto un fumetto che è appunto Cheese. Quindi, da quel momento in poi è stato tutto veloce. Non ho fatto la solita gavetta, le autoproduzioni, la ricerca dell’editore. E’ successo tutto così, insieme.
Nei tuoi testi è forte il tema della metamorfosi. Soprattutto in Giorni Felicic’è la protagonista che cambia, addirittura, aspetto fisico. E forse è un azzardo, ma il passaggio dalla vita personale in cui sei una ragazza che smette di disegnare a causa di un’estetica imposta dalla scuola fino a diventare ZUZU, può essere considerato una metamorfosi di per sé? Ti va di raccontarci un po’ questo passaggio?
Nel mio caso la metamorfosi assomiglia più a un ritorno. Perché comunque quando inizi a disegnare, quasi sempre devi disimparare ciò che pensavi di aver capito sul disegno. E disimparando torni indietro, recuperi un istinto naturale che si è corrotto nel tempo di come disegnavi, come tenevi la penna, come guardavi alle cose. È la parte più divertente per chi ricomincia a disegnare dopo tanto tempo, o decide di farlo con un metodo: questo lavoro di decostruzione e ricostruzione delle immagini. Quindi io, andando avanti, tornavo indietro e ritornavo un po’ bambina. E il mio nome d’arte, ZUZU deriva proprio da quello. Perché papà mi ha sempre chiamata Zuzu da piccola ed era il mio nomignolo: da Giulia, a Giugiu, a Zuzu. Quindi mi piaceva mantenere in questo lavoro un’identità che appartiene a un mondo più antico dove il disegno era diverso. Era più un bisogno, una necessità, un’urgenza. Non una cosa che “deve venir bene” perché “altrimenti non sei bravo”; che devi far vedere agli altri e che ti dà valore. E’, invece, una necessità di poter esprimere ciò che sentiamo dentro.
Effettivamente, nelle tue opere il corpo dei personaggi risulta essere il più grande protagonista di tutte queste metamorfosi che si vive durante la propria vita. Per cui risulta naturale chiedersi, alla luce anche della tua storia complessa in cui hai esperito e superato dei disturbi alimentari, oggi che rapporto hai con il corpo sia nel fumetto che nella vita reale?
È interessante perché nella vita, soprattutto in passato, il corpo mi sembrava una gabbia, una cosa che impediva di esprimere me stessa libera, felice e leggera. E quindi, ho fatto una guerra contro il mio corpo per ottenere quella leggerezza senza mai raggiungerla, chiaramente. Perché questa battaglia in cui non vince nessuno non fa altro che appesantirti. Invece, nel disegno il corpo mi sembrava, al contrario di un campo di battaglia, qualcosa di super stimolante, che puoi trasformare e manipolare. Può allargarsi, stringersi e questo mi dava assoluta libertà. Ed era incredibile per me, spostarmi dal tavolo di lavoro dove il corpo era totale libertà, alla vita privata dove il corpo era impedimento.

Questa cosa si è attenuata con il passare del tempo: nella vita ho smesso di fare quella battaglia. Il corpo ha smesso di sembrarmi – e ho smesso di sentirlo – un ostacolo. E anche nel disegno ho iniziato, credo, a devastarlo di meno. Se guardo il modo in cui disegno adesso e il modo in cui ho fatto Cheese, in passato ero molto più cattiva con il corpo mio e degli altri. Lo disegnavo crudo e più grottesco. Invece ora le linee sono più morbide e più gentili. Rimane che comunque mi piace manovrare e distruggere le prospettive, però, mi sembra che io sia meno ossessionata da questo desiderio di renderlo mostruoso. Poi in Giorni Felici l’ho fatto attraverso una metamorfosi vera e propria: cioè facendo assumere alla protagonista le sembianze di una bestia.
In linea con queste riflessioni sulle forme, nei tuoi fumetti appare ancora più lampante l’uso del colore. Dal primo fumetto, focalizzato su un profondo uso di bianco e nero, si passa al tuo ultimo lavoro dove i colori tenui riempiono le tele. Come mai questo cambio?
Intanto, mi è risultato molto difficile approcciarmi al colore. All’inizio mi risultava proprio difficile disegnare a colori, per un mio limite di gusto, credo: mi piacevano di più le cose fitte e in bianco e nero. Poi i miei gusti sono cambiati e cambieranno ancora. E il colore ha iniziato ad entrare in tutto della mia vita. Al punto che ho iniziato a colorare anche i miei capelli, cambiandoli continuamente. E poi oltre al mio sguardo, al mio gusto, avevo una storia completamente diversa che aveva bisogno del colore per essere raccontata, nel caso di Giorni Felici. Sarebbe stato molto strano raccontare quello sguardo, quella vita, quel personaggio con invece un universo così scuro e violento. Lo sguardo di Claudia me lo sono sempre immaginata molto dolce, armonico e semplice. Lo sguardo di Zuzu, in Cheese, per forza di cose non poteva essere così: è un personaggio molto immerso dentro i suoi dolori, meno aperto verso l’esterno. Sono due libri per me molto diversi perché uno mi sembra introiettato verso dentro, e l’altro verso il fuori. Claudia vola, mentre Zuzu ha gli occhi neri – è rivolta un po’ al contrario. E quindi, non riuscirei a immaginarmi i libri diversi rispetto a come sono dal punto di vista del colore.
Dunque, pensi ci sia una rottura tra Cheese e Giorni felici?
Oddio, sì, sicuramente c’è. Diciamo che sono io la continuità perché li ho scritti io, però sono due libri nati in momenti diversi e in modalità diverse. Il primo è appunto stata la mia tesi di laurea e mi ci sono approcciata in un modo totalmente diverso rispetto alla stesura di Giorni Felici che sapevo già che sarebbe stato pubblicato. Avevo anche molto più tempo per lavorarci, perché non avevo una scadenza, come la laurea, con cui dovevo fare i conti. Dunque sì, c’è una rottura forte. Ma, allo stesso tempo, credo che abbiano molte cose in comune. Prima cosa è il fatto che entrambi finiscono bene. Io non riesco a pensare delle storie che finiscono male, non so se mai farò una storia che finisce male. Consapevole che “bene” con cui finiscono i miei fumetti è totalmente ambiguo.
Questi happy ending all’interno delle tue storie sono in controtendenza rispetto alla tua ultima opera e all’omonimo testo teatrale di Backett da cui hai tratto ispirazione. Perché effettivamente, in entrambe le storie, i giorni veramente felici che vengono raccontati sono ben pochi. Dunque, cosa pensi sia la felicità?
Se devo pensare alla mia felicità è, un po’ come tutte le felicità, uno sguardo con cui guardi le cose. Si può essere felici in momenti diversi facendo cose diverse. Non riesco a pensare: «ah, sarei felice se in questo momento fossi lì a fare quella cosa». No, non lo so se sarei felice. Potrei fare tutt’altra cosa, magari anche sgradevole, ed essere felice. La felicità fa proprio di testa sua. Ho smesso di rincorrerla e di cercare di capirla. Infatti, più che una ricerca della felicità, Giorni Felici mi è rimasto impresso perché indaga il modo in cui si fa i conti con l’infelicità. E per il fatto che hai sempre un’occasione per essere felice, non dipende dalle circostanze. Può capitare come un accidente questa felicità. Può capitare anche a Winnie [protagonista del testo teatrale, ndr], mentre osserva gli oggetti che ha nella borsa. Può capitare a Claudia mentre le succedono di ogni. Può capitare a Zuzu mentre mangia le albicocche. Così, questi momenti sono epifanici. Forse non mi interessa scoprire che cosa sia la felicità, mi interessa più indagarla in quanto sentimento: quando l’ho provato, com’è stato, com’è riscriverlo e ricordarlo, come sperare che succeda. E non “cos’è” come se fosse un’entità pura, chimica di cui puoi vedere le componenti. Non credo sia possibile… del resto, oltre che è un emozione e solo una parola per cui è complicato snocciolarla.

Infatti, i tuoi finali più che felici, in realtà, sono aperti e contestualizzati in un specifico momento. Come ti rapporti con il finale aperto?
Mi ha sempre un po’ dato fastidio, quando leggo cose degli altri, quando mi sembra che il libro mi stia dicendo cosa pensare. Cosa devo aspettarmi dal dopo. Come devo interpretarlo. Voglio sentirmi libera di metterci il mio quando leggo… è questo il bello della lettura, del cinema, di qualsiasi forma d’arte. Che tu lettore, in realtà, hai un grande campo libero e che puoi riempire anche ciò che non viene raccontato. E quindi, penso che senza rifletterci mi sia venuto spontaneo di provare a evitare questa cosa e arginarla, cercando di non dire mai cos’è la cosa giusta, qual è il destino giusto per un personaggio, quale è il personaggio cattivo e quale quello buono. E il finale aperto è il mio modo per dire che è una storia quella che racconto, non una soluzione. La soluzione non la so, non la sa nessuno in realtà e, tanto meno i miei personaggi perché sono umani. Anche se animaleschi o bizzarri, in fondo sono umani.
Quindi, rigirandoci un po’ su Giorni Felici, questa volontà di non dare nessun tipo di giudizio alla storia ti permette di raccontare diverse contraddizioni come per esempio le relazioni tossiche, decostruendole però nel realismo carnale della vicenda. Per questo, pensi sia un po’ autobiografico il racconto di Giorni Felici?
Chiaramente sì, certo. Tutto ciò che faccio lo è, ma niente ha intenzioni autobiografiche. Non vorrò mai scrivere la mia autobiografia. Anche perché l’autobiografia è un genere che ha le sue caratteristiche e i miei libri non ci corrispondono: non c’è il mio nome e non tutte le storie che racconto corrispondono alla mia vita. C’è la mia vita dentro ma quello è abbastanza inevitabile. Credo che qualsiasi invenzione, qualsiasi forma di narrativa nasca dalla vita di chi la racconta. Qual è il loro recipiente, se non la vita? Che può essere anche dell’immaginazione e dei desideri. Magari molte cose che racconto non sono mai successe, ma ho voluto tanto che succedessero. O è stato come se le avessi vissute comunque. È un confine molto sottile quello tra l’autofiction, come si dice tanto adesso, e quello che è semplicemente scrivere. L’arte, la scrittura… tutte queste cose se nascono dal niente, dal puro artificio sono decorative. Anche se racconti la storia dei Minimei o della Strega Karabà, questa deve contenere la vita di chi la racconta.
Per concludere, essere artisti in Italia oggi può risultare parecchio complesso. Tu hai fatto un passaggio per lo IED che è un ambiente parecchio specifico nella tua professione. Ma adesso che ti stai aprendo a questa complessità di mondo, secondo te, cosa significa essere oggi giovanə artistə in Italia?
È un ambiente estremamente privilegiato a cui hanno accesso pochissime persone e questo è deprimente, perché se io non avessi avuto la possibilità di contare sui miei genitori che potevano aiutarmi, probabilmente non avrei deciso di fare questo lavoro nella vita. No? Probabilmente non avrei deciso di farlo attraverso l’università, probabilmente non avrei deciso di fare un fumetto come tesi perché avrei pensato che è un lavoro troppo instabile che mi costringerebbero di chiedere una mano ai miei genitori e i miei genitori non possono aggiungere un’altra spesa. Quindi, chi fa il fumettista, l’artista, il fotografo, tutte queste persone – nella maggior parte dei casi, chiaramente – sono tutte persone che nella vita hanno avuto il privilegio di poter scegliere di fare quella vita. Chissà quante teste, quante mani, quante visioni ci perdiamo poi perché semplicemente alcuni hanno rinunciato a priori a questa possibilità. E quindi cos’è essere artisti? È un lavoro…. È un lavoro? È quella la cosa! In Italia non è ancora considerato un lavoro. Quindi di che parliamo? Magari lavoro tanto, ho dei ritmi serrati, magari sono una persona molto disciplinata che si dedica anima e corpo tutti i giorni alla sua passione. Ma comunque sei in una società che non lo considera lavoro e se lo fa, in ogni caso non ti paga o lo fa con enormi ritardi. Questa, ahimé, è la situazione. Mi piacerebbe poter rispondere diversamente… Magari alla prossima intervista!