cult

CULT
Il capitale e la fine del mondo
Pubblichiamo un estratto da “Il virus e la specie. Diffrazioni della vita informe” (Mimesis, 2020), un libro che mostra quanto la specie costituisca una delle armi più affilate utilizzate dal capitale nella guerra sulla vita informe
Sulla scorta di quanto Eugene Thacker afferma in Tra le ceneri di questo pianeta, è bene distinguere, quando diciamo “mondo”, il mondo-per-noi (il Mondo), il mondo-in-sé (la Terra) e il mondo-senza-di-noi (il Pianeta). L’Immaginario, il Simbolico e il Reale, direbbe (forse) Lacan. La crisi che stiamo vivendo ha mostrato la tenebrosa oscurità del Pianeta/Reale, che non solo può fare a meno di noi ma che addirittura, in un’inversione ontologica totale, ci guarda senza vederci; ha mostrato l’ira funesta di una Terra/Simbolico che sembra decisa a sbarazzarsi dell’“animale parlante” che, senza pietà e per secoli, l’ha violentata, depredata, sfinita e, infine, che il Mondo/Immaginario dovrebbe prendere congedo dall’idea di cosmo ordinato e razionale per abbracciare quella di groviglio di relazioni incarnate fatte di vulnerabilità e finitudine.
«La vera sfida – sostiene Thacker – sta nel confrontarsi con questo enigmatico concetto di mondo-senza-di-noi, e comprendere come questo mondo-senza-di-noi continui a persistere tra le ombre del mondo-per-noi e del mondo-in-sé». Ecco, allora, l’impegno decisivo a cui Covid-19 ci chiama: cercare di pensare quell’iperoggetto, per usare la terminologia di Timothy Morton, che non vediamo in quanto vischiosamente avvolt* in esso e iniziare a comprendere che Homo sapiens, nonostante quello che ha creduto fino a poco tempo fa, non è né l’apice della creazione né una specie invulnerabile, in cima sia alla grande catena dell’essere sia alla catena alimentare. Più in breve, la pandemia dovrebbe favorire una fuoriuscita dall’antropocentrismo del noi.
Come ricordano Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro (Esiste un mondo a venire?), infatti, abbiamo sempre pensato la fine del mondo nei termini di mondo senza noi o in quelli di noi senza mondo: il «mondo che finisce» è sempre «il “nostro” mondo». E magari fosse vero che il “noi”, che sta parlando e di cui si parla, sia sempre «l’Umano, che lo si chiami Homo sapiens o Dasein». Questo “noi” è, invece, un noi molto ristretto, se consideriamo che il mondo di infinite schiere di altr*, umani e animali, è già stato distrutto. A tal proposito, basti ricordare lo sterminio dei popoli nativi del continente americano e la riduzione in schiavitù di milioni di african* che, come sottolinea James Bridle (Nuova era oscura), lasciarono, a seguito del collasso dell’agricoltura e della ricrescita delle foreste su entrambe le sponde dell’Atlantico, «molte tracce sul clima»: «l’Antropocene ha inizio con un genocidio di massa, con una violenza su scala planetaria talmente ingente da ritrovarsi anche nelle carote di ghiaccio e nell’impollinazione delle colture».
Forse, è per la presenza di questo scotoma che non riusciamo a immaginare la fine del capitalismo – altro iperoggetto che ci avvolge vischiosamente. La crisi in corso, nonostante imponga una vita a distanza, in cui la socialità e i gesti d’affetto sono ridotti a un livello tale da superare perfino i sogni nefasti del neoliberismo più sfrenato, mostra comunque che il capitalismo non è un sistema sociale eterno e insuperabile: quando mai la produzione industriale si è fermata o si è significativamente rallentata per diverse settimane, se non addirittura per mesi? Così come non sono eterne e insuperabili le ideologie della fine della storia fiorite all’ombra del capitale – ideologie che sono smentite proprio dall’incessante susseguirsi delle possibili fini del mondo (nucleare, ecologica, virale…). Il che non esclude che il capitale possa evolversi in distopie ancora più abominevoli di quelle che conosciamo. Il capitalismo, infatti, ha sempre mostrato un’inusitata plasticità auto-riproduttiva di fronte alle sue stesse contraddizioni, basti pensare al modo in cui ha saputo nutrirsi anche della crisi ecologica. Con la finanziarizzazione della natura, ossia con la realizzazione di un sistema globalizzato di distribuzione dei rischi basato su strumenti quali i derivati climatici e le obbligazioni catastrofe, il capitale ha continuato a collettivizzare i costi e a privatizzare i profitti. E a distruggere la Terra per un’idea delirante di Mondo, senza rendersi conto della perturbante avanzata del Pianeta.
Per quanto riguarda la fine del mondo, i Mondi, la Terra e il Pianeta continueranno a vivere/morire senza di “noi” – è già accaduto e accadrà in futuro. Per quanto riguarda il capitalismo, immaginarne la fine continua a sembrare impossibile. Ma, aggiunge Preciado (Terrore anale), «solo immaginando l’impossibile sarà possibile trasformare l’inaccettabile».
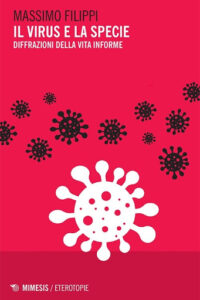 Il mattatoio e la sovrastruttura
Il mattatoio e la sovrastruttura
Se, come si è detto, la pandemia da coronavirus ha fermato, con un’intensità e per una durata semplicemente inconcepibili, la produzione e la distribuzione delle merci, la filiera della carne, l’impresa della carneficina, non si è mai arrestata. Ci si dirà che, ovviamente, non si poteva certo interrompere la produzione di alimenti. Vero. Ma da qui a ritenere che la carne sia un alimento indispensabile ce ne corre. Come ce ne corre a dimenticarsi che il mattatoio è uno dei luoghi in cui è ben difficile mantenere gli standard igienici che la crisi sanitaria ha imposto altrove. Si potrà infine obiettare che almeno in alcuni casi, per problemi legati al trasporto e alla distribuzione, la catena produttiva della carne si è fermata. Facile ribattere: sì, la produzione della carne si è un po’ ridotta qua e là per i motivi ricordati, ma di certo non vi è stata alcuna battuta di arresto della carneficina poiché le/gli animali sono stat* comunque abbattut*. E, allora, diciamoci la verità: il mattatoio non si è fermato perché la nostra è una società permeata fin dentro le sue fibre più intime dall’ideologia sacrificale.
Dal che discende che la classica divisione struttura/sovrastruttura, tanto cara ai marxisti ortodossi, necessita di essere rivista in profondità – come hanno suggerito, seppur da prospettive diverse, marxisti anomali, quali Gramsci, Adorno e Althusser –, dal momento che la sovrastruttura sacrificale (l’ideologia) non è più (solo) un mero epifenomeno dei rapporti di produzione (la struttura), ma (anche) ciò che produce, riproduce e perpetua tali rapporti. Oppure come affema Žižek in L’oggetto sublime dell’ideologia, l’ideologia «comporta che gli individui “non sappiano quello che fanno”» – che coloro che pensano di far parte di una realtà sociale non ne conoscano l’essenza e che, pertanto, l’illusione ideologica sia tesa a ingannare il grande Altro (l’ordine simbolico in cui bisogna continuare a credere anche quando non esiste più o non è mai esistito se non nella forma della violenza più cupa). In breve, l’ideologia non è tanto «uno sguardo parziale che non riesce ad abbracciare la totalità dei rapporti sociali», come sostiene il marxismo, ma piuttosto, lacanianamente, «una totalità volta a cancellare le tracce della propria impossibilità». Se così non fosse, se l’ideologia non fosse sempre all’opera, come mostra il filosofo sloveno in un altro testo dal titolo emblematico (L’epidemia dell’immaginario), perché i gabinetti, pur assolvendo allo stesso compito strutturale, assumono forme diverse in Germania («profondità riflessiva»), in Francia («impazienza rivoluzionaria») e in Inghilterra («moderato pragmatismo utilitarista»)?
Al tempo del coronavirus e dopo tante sconfitte, dovremmo cominciare a pensare a come sia possibile trasformare l’economia e l’ideologia del capitale e a come sottrarre le/gli uman* e le/gli altr* animali dalla sua incontenibile voracità. A come far riaffiorare – con un movimento opposto rispetto a quello dell’Almayer di Conrad – le tracce cancellate di quell’impossibilità che trasforma incessantemente il vivo in morto.
La hauntologia e il morto vivente
«Uno zombie è una persona morta che sembra viva o una persona viva che è morta», afferma Jean Rhys in Il grande mare dei sargassi. Se i morti che ritornano, tutto sommato, sono sempre pochi, oggi si assiste, come mai in passato, alla moltiplicazione esponenziale delle/dei mort* vivent*, di quella moltitudine sterminata di chi, ancora-in-vita, è già-morto. Questo è il motivo per cui la figura dello zombie è assurta a figura centrale dell’immaginario contemporaneo: quella che Lacan, nel Libro VII del suo Seminario, chiama «tra-le-due-morti», la «zona limite […] tra-la-vita-e-la-morte» – «morte che sconfina nel dominio della vita, vita che sconfina nel dominio della morte» – non è mai stata così sovraffollata. Le/i mort* vivent*, infatti, sono coloro che hanno superato la soglia di quanto, di volta in volta, è stato chiamato “morte civile”, “morte sociale”, “morte simbolica”, “reclusione in una schiavitù interminabile”. Le/i mort* vivent* sono le/i viventi mortali che sono entrat* nella sfera di invisibilità a cui è di solito consegnato il cadavere. In breve, le/gli oppress* di tutte le specie e, tra quest*, ovviamente, quell* direttamente smembrat* dal dispositivo di specie.
Il vivente, in quanto mortale e, quindi, spettro e revenant, perfora il presente, è sempre tracciato dalle tracce di ciò che non è già-più e di ciò che è non-ancora. Essendo percorso dall’apparizione dell’invisibile, il vivente mortale disfa la metafisica della presenza e la sua ontologia, mostra, come afferma Derrida in Spettri di Marx, la «non contemporaneità a sé del presente vivente e, quindi, la necessità di una hauntologia in grado di «rispondere al morto» e di «rispondere del morto», di rendere conto, per usare le parole di Mark Fisher in Spettri della mia vita, di ciò che nella realtà «non è più, ma che rimane efficace sotto forma di virtualità» e di ciò che «non è ancora avvenuto, ma che è già efficace nella sfera virtuale». Una hauntologia, per tornare a Derrida, che, nel pieno della guerra sulla pietà, arresti la «guerra impietosa» contro «il fantasma dell’altro e il proprio fantasma come fantasma dell’altro», che accetti l’«apparizione […] non del corpo senza vita o del cadavere, ma di una vita senza vita personale e senza proprietà individuale». Che dia corpo allo spirito.
Non è un caso, allora, se Lacan si debba far aiutare da Antigone per orientarsi tra-le-due-morti. Antigone è colei che, viva-già-morta e morta-ancora-viva, veglia l’infernale zona limite. Antigone sepolta viva per aver commesso il crimine di dare sepoltura al fratello, a colui che il nomos-del-Padre voleva lasciare insepolto. Come pure non è un caso se Derrida si debba appoggiare a Marx per tracciare le sembianze della sua hauntologia. Quel Marx che continua a vivere proprio grazie al lavoro del lutto e agli scongiuri del capitale che proclama senza sosta «Marx è morto, il comunismo è morto, con le sue speranze, il suo discorso, le sue teorie e le sue pratiche». Antigone e Marx che continuano ad apparire nella testa di chi si fa testimone della rivolta, declinando al presente un passato e un futuro che ritornano nell’inarrestabile movimento della com/mozione, del muoversi-insieme.
Nel tempo dissestato (out of joint) del coronavirus abbiamo un disperato bisogno di hauntologia, di una lingua medianica che, come sostiene Karen Barad, ci permetta di «parlare con gli spettri» non per «produrre o ricostruire una narrazione di come si sono svolti i fatti», ma per «rispondere, essere responsabili di ciò che ereditiamo (dal passato e dal futuro), delle aggrovigliate relazioni di eredità che siamo “noi”».
In copertina una foto di Adrian Pelletier
