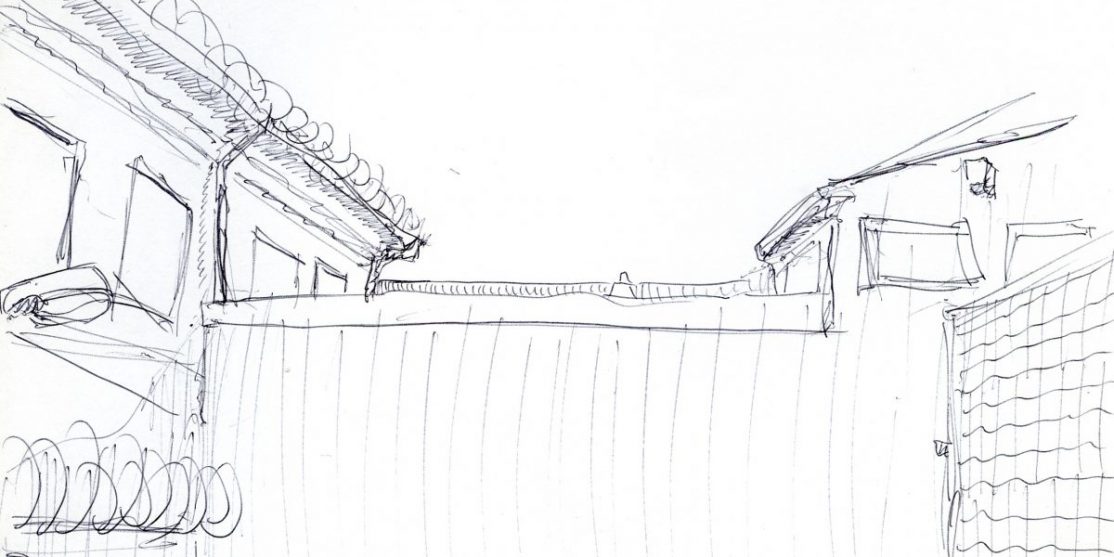OPINIONI

Il peccato originale della Superlega
Con la proposta delle squadre di vertice del calcio europeo a essere aggredito non è solo lo sport, ma il principio su cui si poggia il consenso sociale all’intero sistema, di cui il calcio finisce per essere potente metafora
Dopo tante voci e indiscrezioni, sono uscite allo scoperto: dodici società di vertice del calcio europeo (Juventus, Milan, Inter, Barcellona, Real e Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City e United, Chelsea e Tottenham Hotspurs) hanno lanciato la loro idea di superlega europea chiusa, sul modello Nba statunitense, per rilanciare un settore che in questi anni ha visto i conti aggravarsi in modo consistente con un decisivo peggioramento finale dovuto alla pandemia.
Una competizione la cui partecipazione non sarebbe basata sulla tradizione calcistica, il palmarès o la posizione nei campionati precedenti ma sui bacini d’utenza – quindi i clienti attuali – la dimensione economica e la valorizzazione potenziale dei rispettivi brand attraverso un brand unico.
Andrea Agnelli, nel comunicato ufficiale di lancio, ha parlato di un miliardo di attuali tifosi coinvolti nell’operazione.
Come nell’NBA i profitti non sarebbero gestiti dalle singole squadre, ma dal consorzio che li redistribuirebbe equamente, garantendo un torneo equilibrato e senza il dominio assoluto di una o due squadre visto nei campionati nazionali recenti, ragione di perdita di appetibilità, quindi vendibilità, del prodotto.

(immagine da commons.wikimedia.org)
Non si è fatta attendere la reazione delle federazioni e delle leghe nazionali ed europee, Uefa in testa, che minacciano cause miliardarie e l’esclusione dalle competizioni ufficiali odierne, temendo una competizione che potrebbe drenare larga parte dell’attuale torta dei diritti televisivi, da cui il calcio contemporaneo è fortemente dipendente. In poche ore sono arrivati a prendere parola politici come Letta, o capi di stato come Boris Johnson ed Emmanuel Macron.
L’argomento più utilizzato è quello del merito sportivo, il fatto che una competizione a inviti renderebbe impossibile la vittoria a squadre meno facoltose, le favole del Leicester, dell’Atalanta o dell’Ajax.
Molti tifosi, anche delle squadre proponenti, si sono sollevati vedendo minato questo principio base che rende tanto seguito questo sport in Europa. Come direbbe Nick Hornby: «La cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente, c’è sempre un’altra stagione. Se perdi la finale di coppa in maggio puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio, che male c’è in questo? Anzi, è piuttosto confortante, se ci pensi». A chi fregherebbe del calcio altrimenti?
A ben vedere in realtà questo principio nella realtà concreta è minato da un bel pezzo.

(immagine da commons.wikimedia.org)
Prendendo i campionati coinvolti nella proposta, la Serie A da 20 anni è vinta dalle squadre che parteciperebbero alla superlega, la Liga spagnola da 17, la Premier da ben 25, tolto l’anno del Leicester. Su 62 occorrenze una sola favola. O forse sarebbe meglio chiamarla eccezione a conferma di una vera e propria regola.
Che nello sport ci sia chi vince e chi perde è normale. Ma se a vincere sono sempre gli stessi evidentemente i motivi non risiedono affatto nelle capacità sportive.
Se andiamo a vedere le ragioni che hanno portato all’affermarsi di questa regola sono facilmente riscontrabili. Nel caso italiano, è a inizio degli anni ’80 (legge 91/81) che le società calcistiche si trasformano da associazioni sportive in S.p.A. e solo nel 1996 (legge 586/96) viene loro riconosciuto lo scopo di lucro. I diritti televisivi, la possibilità di vedere il calcio in tv, assumono un’importanza crescente arrivando a rappresentare il 35% dei ricavi dei top team e addirittura il 75% delle squadre medio piccole.
Anche le competizioni si trasformano, in particolare quelle europee. La Champions League, nuova formula della vecchia Coppa Campioni, garantisce ritorni milionari, in particolare a chi vi partecipa costantemente, aumentando a dismisura il divario nei ricavi tra poche squadre di vertice e il restante movimento sportivo.

(immagine da commons.wikimedia.org)
Questa trasformazione, che ha analogie legislative antecedenti nel resto d’Europa, ha portato poche squadre a vincere costantemente i rispettivi campionati nazionali e l’affermazione del cosiddetto “calcio-business”, la trasformazione di uno sport in vera e propria merce.
Se differenze nelle possibilità economiche delle rispettive squadre sono sempre esistite, mai sono state ampie come quelle odierne.
Mentre questa trasformazione ha lasciato sul campo i cadaveri di diverse squadre storiche, fallite o recuperate sull’orlo, ricavi più alti hanno permesso solo a poche società di garantire ingaggi annuali faraonici ai fuoriclasse del calcio: 30 milioni a Ronaldo, 70 a Messi, 65 a Neymar. Squadre stellari dai costi stellari.
I costi crescenti hanno portato queste stesse società a indebitarsi sempre più pesantemente per restare al passo con le concorrenti europee, spesso anche attraverso l’utilizzo di cosmesi di bilancio e plusvalenze gonfiate, facendo allo stesso tempo i conti con una contrazione dei compensi per i diritti televisivi per i campionati nazionali.
La ragione è presto detta: le multinazionali delle telecomunicazioni sono poco propense a investire più del necessario in partite dallo scarso interesse mediatico, che coinvolgono squadre di piccole cittadine, quindi bacini d’utenza ristretti, riversando il problema all’interno delle singole leghe.

(immagine da commons.wikimedia.org)
La spartizione dei diritti tv, infatti, vede le piccole e medie società alleate perché avvenga nel modo più egualitario possibile, mentre le squadre di vertice, che apportano il maggior numero di clienti, vorrebbero che tale spartizione avvenisse in modo proporzionale, aumentando ulteriormente il divario ma permettendo loro di mantenersi competitive.
Da questa impasse nasce la necessità di una superlega separata, che concentri i ricavi del prodotto calcio in modo definitivo e salvi i bilanci dei “big” escludendo chi vi apporta una quota di mercato inferiore.
In un mercato in cui la fede del tifo è stata già sostituta dalla fidelizzazione più misurata e fredda del cliente, anche attraverso la criminalizzazione del tifo meno disciplinato identificato col mondo ultras, si ritiene che i tifosi delle squadre medio piccole possano essere facilmente sostituiti attraverso la creazione di un prodotto mondiale. Vivrà di meno passione, più di visualizzazioni e merchandising.
Un esempio concreto già presente potrebbe essere rappresentato dal Manchester United: a seguito delle scelte aziendali della nuova proprietà americana molti tifosi storici abbandonarono i Red Devils e fondarono nel 2005 una propria squadra, lo United of Manchester. Cosa che non ha impedito allo United di fare a meno di loro contando su un bacino di clienti a livello mondiale.

(immagine da commons.wikimedia.org)
Ma se i tornei già in questo momento vengono vinti sempre dalle stesse squadre, se il prodotto calcio già oggi soffre di livelli di concentrazione così elevati, se già ad oggi il merito sportivo è così poco rilevante dinanzi alle possibilità di spesa come dimostra l’albo d’oro dei campionati, perché la proposta desta così tanto scandalo?
E soprattutto perché proprio ciò che ha portato a questo resta il principale oggetto del desiderio, almeno tra la larghissima maggioranza dei tifosi? Non vincere, cosa riservata a pochissimi, ma fare almeno un passaggio nel giro che conta.
La risposta potrebbe risiedere in meccanismi di adesione e consenso sociale ben più profondi del ristretto ambito sportivo. La società del profitto si poggia su un’eguaglianza formale che rende tollerabili le esclusioni sostanziali. La possibilità stessa della favola individuale rende accettabile che su un piano sociale quella favola non sia operativa nemmeno a livello potenziale. Vale nella società come nel calcio, in cui le possibilità di vittoria sono sempre meno una questione di sport.Se questo non detto diviene esplicito, formale, apparente, salta il meccanismo di coesione che tiene insieme interessi materiali profondamente divergenti.
Questo è il peccato originale della proposta della Superlega: rendere esplicito ciò che è accettabile solo in forma latente.
Riportare alla dura realtà un calcio che ha perso da tempo poesia, ma non aveva ancora perso un’illusione che i sentieri della valorizzazione del grande capitale non possono permettersi.

(immagine da commons.wikimedia org)
Tuttavia la critica, che dovrebbe coinvolgere l’intera logica alla base di questa degenerazione, si ferma unicamente ai suoi aspetti formali e si personalizza nelle figure degli attuali dirigenti – Agnelli Suning Perez -a cui viene attribuita addirittura la distruzione del calcio, quando al massimo sono la fenomenologia di un sistema già ampiamente compromesso che vira verso una direzione quasi obbligata.
Esattamente come quando si identificano gli effetti inumani del capitalismo con qualche marchio specifico, esentando in tal modo la logica che ne determina l’azione.
Probabilmente la proposta non passerà, non in questi termini. È plausibile ritenere che verrà usata come leva per ottenere una riforma delle competizioni europee, in particolare della Champions League, favorevole agli interessi dei club proponenti, magari garantendo loro un posto nell’Europa che conta e quindi gli incassi che ne derivano a prescindere dai meriti sportivi.
Un modello simile all’attuale Eurolega di basket a cui si affiancano ai vincitori dei campionati nazionali undici squadre accreditate su base pluriennale, proprio a seguito di uno scontro analogo tra Fiba e Uleb.
Questo permetterà di tenere insieme possibilità formale e disuguaglianza sostanziale. Non importa che la logica del calcio-business venga confermata, quella è già storia vecchia da un pezzo, criticarla è roba da nostalgici, l’importante è che non tolgano l’illusione di potercela fare, di essere potenzialmente tutti uguali.
Il ruolo di terzo incomodo tra Uefa e Superlega potrebbe svolgerlo proprio la componente del tifo, ancora frastornata dagli eventi, ma che ad esempio a Liverpool in segno di protesta ha già rimosso gli striscioni dalla storica curva Kop.

(immagine da commons.wikimedia.org)
Se non è un caso che questa improvvisa accelerazione emerga a seguito della repressione e della crisi profonda del tifo organizzato, è proprio su questo versante e dalle sue macerie recenti che potrebbe riaprirsi uno spazio critico non solo della specifica proposta, ma di quello che il calcio è diventato negli ultimi vent’anni, della sottrazione di una festa collettiva a favore del prodotto di intrattenimento.
Se invece la mediazione dovesse andare in porto senza disturbi si può immaginare facilmente il futuro.
Con un Leicester ogni vent’anni a rinnovare di nuovo il patto e un abbonamento streaming che ci rassicuri: lo spettacolo va avanti ed è sempre disponibile, per non perdersi proprio l’anno in cui si realizzerà la favola. Da oggi anche in 4K. Fino al prossimo risveglio, dettato dalle stesse dannate esigenze, potremo così tornare a dirci che Juve e Inter vincono sempre perché gli regalano i rigori.
Immagine di copertina da commons.wikimedia.org