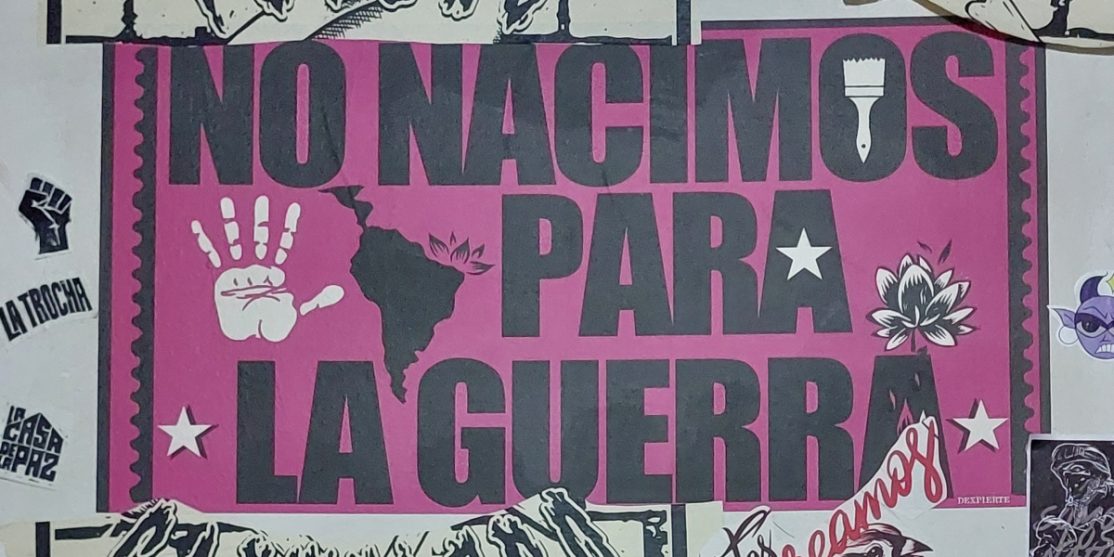ROMA
#2 Fuori Mercato: banditi!

Breve guida giuridica alle delibere con cui il Comune di Roma pensa di valorizzare il patrimonio pubblico sfrattando gli spazi sociali
.
#0 Fuori Mercato: che Roma sarebbe senza l’autogestione?
#1 Fuori Mercato: Casale Falchetti
Hanno nomi e cognomi gli strumenti di cui il Comune di Roma si è dotato, negli ultimi anni, per riorganizzare complessivamente il Patrimonio di sua proprietà e il modo in cui viene gestito, amministrato, messo a valore. E se nel linguaggio della politica quei nomi e quei cognomi corrispondono a quelli di Ignazio Marino, di Luigi Nieri, di Alessandra Cattoi; nel linguaggio del diritto, invece, per nominarli occorrono i numeri: Delibera 219/2014 e Delibera 140/2015. Due delibere della Giunta Capitolina che vanno lette insieme, e che insieme servirebbero a cancellare decenni di storia di autogestione, di mutualismo e di solidarietà a Roma, sacrificandoli sull’altare della necessaria “valorizzazione” del Patrimonio pubblico. Vediamo come.
La Delibera 219 del 23 luglio 2014, è – tra le due – quella più beffarda. Il titolo farebbe ben sperare: «Il Patrimonio Pubblico di Roma Capitale “bene comune”». Ma qualunque aspettativa benaugurante viene smentita immediatamente, poche parole dopo, nel prosieguo del titolo: «Approvazione dei criteri e modalità, con procedure di bando pubblico per l’utilizzo in concessione d’uso o affitto di immobili di proprietà comunale al fine di avviare i progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali e di imprenditoria, rivolti in particolare ai giovani». Eccolo lì, subito in bella mostra, il problema dei problemi: il “bando pubblico” come unica forma di messa a disposizione, da parte del Comune, dei propri spazi; il bando pubblico come totem della meritocrazia e della trasparenza amministrativa; il bando pubblico come dispositivo di selezione di quali realtà sociali siano degne di riconoscimento pubblico e di quali no. Ma veniamo al testo della delibera.
Le premesse, al pari del titolo, sembrerebbero essere delle migliori. Si premette che «Roma Capitale intende rilanciare – con forza e determinazione – la qualità del vivere urbano, nel rispetto della sostenibilità ambientale, coniugando, da un lato, l’obiettivo di valorizzare e recuperare la città esistente e, dall’altro, quello di promuovere e rafforzare il contributo del Terzo Settore e delle Associazioni in genere, anche attraverso la creazione di servizi, risorse, luoghi e strutture apposite, in grado di coesione sociale nella città, con specifico riferimento ai quartieri più periferici, a partire proprio dal “bene comune” patrimonio ivi presente». Si aggiunge poi che «in quest’ottica Roma Capitale è fortemente interessata a promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente pubblico quale “bene comune” non utilizzato e delle aree in trasformazione come forma di politica urbana, capace di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per l’intera città ed in particolare per la rigenerazione di quartieri della periferia». Il contraltare di tanta magnanimità viene però chiarito pochi capoversi dopo, laddove si ammette che «al tempo stesso occorre considerare la redditività del patrimonio al fine di definire maggiori risorse economiche per la città, provvedendo alla migliore finalizzazione del patrimonio, nonché alla sua redditività». Si tratta – né più, né meno – dell’applicazione del principio dell’austerità espansiva all’amministrazione degli immobili pubblici; si tratta dell’obbedienza cieca al patto di stabilità; si tratta dell’ossequio alla dittatura della Corte dei Conti. Il concetto è il seguente: va bene la rigenerazione urbana e i beni comuni, va bene la coesione sociale e la sussidiarietà, e però il patrimonio pubblico è una risorsa economica che va messa a valore, messa a reddito, sfruttata.
E così il Comune può, anzi deve, agire come un qualunque palazzinaro, come un qualunque speculatore, e se per caso – per caso! – finalità sociale e finalizzazione economica entrassero in conflitto, non v’è dubbio alcuno su quale delle due logiche debba prevalere. D’altronde, si sa, c’è la crisi, le casse pubbliche languono, there is no alternative, Margaret Tatcher, Angela Merkel, e così via. Ma non c’è da stupirsi. Il ruolo nella Storia dell’italico centrosinistra (rectius: della sedicente sinistra di quel centrosinistra, ché il “centro” questi problemi non se li pone neanche più) non sembra essere che questo: portare a sintesi la politica dei beni comuni e la politica della speculazione sul patrimonio pubblico, il sociale e il contabile, il diritto alla città e il dovere di valorizzare (mettere a valore) la città stessa. E se poi – come è inevitabile – la sintesi risulta impossibile, le belle parole di sinistra (beni comuni innanzitutto) continuano a tornare utili per mascherare, imbellettare, addolcire quanto di più neoliberale sia stato agito dall’amministrazione comunale negli ultimi venticinque anni.
Tornando alla Delibera, posti questi principi, si dettano le procedure: «Il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, coordinerà tali attività, sentita la VII Commissione Assembleare Permanente con i competenti Dipartimenti ed in accordo con i Municipi, predisponendo bandi pubblici che potranno prevedere la concessione in uso agevolato per un periodo sperimentale massimo fino a sei anni, rinnovabile, degli immobili liberi (o che si renderanno liberi), a fronte della selezione di proposte progettuali di interesse pubblico e generale, proposta che dovrà contenere un piano di attività e iniziative rivolte all’intera cittadinanza e/o quartiere da realizzarsi nel periodo per cui è stata richiesta la concessione». Dichiarata nuovamente l’obbligatorietà del bando pubblico, e posto un limite temporale massimo per la concessione (6+6), nulla si dice sulla natura della concessione né – cosa più grave – sull’entità o sulla misura di un presunto uso agevolato. Ma il diavolo è nei dettagli: queste possibilità attengono unicamente agli immobili liberi o a quelli che si renderanno liberi. Che fine facciano gli immobili già in uso, o che cosa significhi il “rendersi liberi” degli immobili che non lo sono, la delibera sul Patrimonio Bene Comune non si sporca certo le mani nel dirlo: ad affrontare il tema sarà l’altra Delibera, la 140/2015, anche se non è difficile prevedere già adesso quali saranno gli esiti. Particolarmente beffardo, poi, è l’utilizzo reiterato del termine sperimentale: come se a Roma non ci fossero già centinaia di esempi virtuosi di immobili pubblici concessi con finalità sociali; come se non ci fosse una solida e multiforme esperienza metropolitana la quale, più che la necessità di una sperimentazione, racconta invece la decennale storia nobile dell’autogestione romana, fatta di consuetudini dense e di rapporti territoriali consolidati.
La delibera prevede poi una serie di ambiti differenti di operatività: A) «Spazi inutilizzati e da recuperare con interventi di manutenzione straordinaria/restauro»; B) «Spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici a carattere sociale e/o artistico-culturale da parte di Associazioni senza fini di lucro in aree centrali e nell’ambito del processo di rigenerazione della periferia»; C) «Spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria»; D) «Spazi dei contesti specifici di Edilizia Residenziale Pubblica»; E) «Progetto “Roma, Città da Coltivare”. Il recupero del patrimonio agricolo pubblico finalizzato alla agricoltura, un’occasione per i giovani».
A interessarci, in questa sede, è soprattutto il punto B. Rispetto a quest’ultimo, la premessa è la stessa già citata in precedenza, e cioè che deve restare fermo «il principio generale della redditività del bene», e cioè – la Corte dei Conti non ammette altre interpretazioni – che il bene deve fruttare alle casse del Comune tanto quanto vale. La seconda premessa è che restano efficaci «i provvedimenti già approvati dall’organo esecutivo sui criteri gestionali del patrimonio immobiliare», anche se non è dato sapere quali siano, ex multis, questi provvedimenti che restano efficaci e quali invece vengano a cadere per manifesta incompatibilità con la nuova disciplina. Segue la procedura, che ricalca quella generale già descritta: «poiché detti atti non esauriscono i bisogni e le necessità della città [sic!], Roma Capitale al fine di promuovere e sostenere progetti specifici rivolti alla cittadinanza ed in particolare nei quartieri periferici, il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione individuerà, sempre a titolo sperimentale, alcuni spazi che, tramite procedura di evidenza pubblica, potranno essere assegnati anche in uso agevolato a fronte di specifici progetti di utilizzo dell’immobile, inteso come bene strumentale per la realizzazione di attività rivolte alla città e che possano diventare un’effettiva risorsa per sviluppare socialità e cultura, nella sua accezione più vasta per la rigenerazione dei quartieri delle periferie. Le assegnazioni avverranno con procedura di evidenza pubblica destinata ad associazioni senza scopo di lucro già costituite alla data di presentazione della domanda. […] Sarà possibile il rinnovo solo dietro la presentazione e l’approvazione di un nuovo piano di attività di pari durata, allo scadere la concessione sarà oggetto di valutazione per l’eventuale prosieguo». Gli elementi fondamentali sono sempre gli stessi: procedura di evidenza pubblica, natura sperimentale, assegnazione anche in uso agevolato. Nemmeno una parola viene spesa per spiegare come funzionerebbero queste procedure di evidenza pubblica, questi bandi, e in particolare quali dovrebbero essere i criteri sulla base dei quali verrebbe valutata, da parte dell’amministrazione, la meritevolezza di un’associazione o di un progetto all’assegnazione di uno spazio.
Forse, per avere qualche delucidazione altrimenti completamente assente, ci si potrebbe riferire ai parametri che a tal proposito vengono elencati per il punto A, in un’assurda equiparazione tra gli spazi pubblici abbandonati (cioè quelli che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di recupero strutturale) e gli spazi pubblici che invece sono già agibili e che (incidentalmente) già ospitano a vario titolo attività virtuose di gruppi o associazioni. I criteri dei bandi sarebbero i seguenti: «qualità della proposta progettuale e coerenza con le finalità dell’Amministrazione; qualità del progetto di ristrutturazione/restauro ove previsto; sostenibilità e fattibilità del piano finanziario per la gestione; esperienza dei proponenti e qualità del partenariato; risultati attesi e impatto sulla città/quartiere». Questi criteri designano un unico profilo di possibile vincitore del bando: enti o associazioni pesanti, ricche, con bilanci da capogiro, in grado di sostenere finanziariamente progetti di lungo termine, in grado di stringere partenariati forti, in grado di vantare curriculum spaziali. Non può che trattarsi delle grandi corporation del Terzo Settore, delle multinazionali del sociale, dei colossi del no-profit: gli stessi, a ben vedere, che già controllano mezza Roma, gli stessi (e gli unici) che assai spesso hanno i canali “giusti” per accordarsi con chi governa già prima che il bando venga scritto. Se se ne volesse una lista, seppur parziale, basterebbe andarsi a leggere le copertine dei faldoni della Procura di Roma sull’inchiesta Mafia Capitale. Già, perché la leggenda che i bandi significhino trasparenza, che i procedimenti ad evidenza pubblica garantiscano la legalità, questa leggenda è smentita dalla storia recentissima di questa nostra metropoli, martoriata dalla corruzione mafiosa che proprio il sistema criminogeno dei bandi e degli appalti ha creato e alimentato.
Nella logica competitiva – necessariamente competitiva! – che il metodo del bando impone finiranno rase al suolo tutte le esperienze più piccole, autogestite, spesso autofinanziate, spontanee, sincere, quelle che da anni esistono e resistono sui territori, portando tignosamente avanti con dignità e successo i progetti che oggi Roma Capitale vorrebbe promuovere “in via sperimentale”. Un tessuto reticolare di tante associazioni piccole o piccolissime, basate sul volontariato, sull’attivismo e sulla militanza, che domani saranno inesistenti nei concorsi dei bandi ma che oggi sono vitali per tanti quartieri. Si tratta di realtà che già da anni usufruiscono di spazi pubblici altrimenti inutilizzati, spesso sulla scorta di delibere più antiche e più lungimiranti, e che nell’uso comune di quegli spazi pubblici hanno cercato e trovato la loro condizione di esistenza. Nessun riconoscimento politico a queste realtà viene dalla Delibera 219. Nessun criterio preferenziale nell’assegnazione degli spazi già in uso, nessun riferimento ai legami forti che nei quartieri si tessono, neppure una attestazione di esistenza. Tabula rasa: alla ricerca di un sociale da “promuovere” e “sperimentare”, Roma Capitale decide di azzerare il sociale che già c’è.
Per la lista degli spazi da mettere a bando, la delibera rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, un documento simile ad una finanziaria per Roma Capitale in cui è presente la lista dei famigerati 860 (circa) immobili «da mettere a bando» (questa la dicitura letterale della delibera, con buona pace di qualche avventuroso campione di ermeneutica giuridica che, magari per mitigare il peso di qualche responsabilità personale diretta in questo disastro, azzarderebbe ipotizzare differenze sostanziali e dunque procedurali tra i “bandi” e le “evidenze pubbliche”). Una lista che equivale ad una condanna per tutti quelli le realtà che – sorpresa! – scoprono di esservi inseriti. Ciò che è più grave è che nessuna disposizione normativa stabilisce la finalizzazione di questo elenco, e cioè quali spazi dovrebbero essere destinati a quale finalità: e così, per irreprensibile capriccio di un qualunque dirigente di un qualunque Dipartimento, uno spazio già assegnato – per esempio – ad un’associazione che si occupa di disagio psichiatrico infantile potrebbe finire messo a bando per una start-up di giovani imprenditori, senza che alcuno possa contestare alcunché. Bella merda, no?
Ora, questo nuovo corso della gestione del Patrimonio Pubblico necessita di un apposito Regolamento, che però risulta ancora in fase di redazione. Nelle more che questo Regolamento venga approvato (e che in città tornino le condizioni minime di democrazia rappresentativa per approvare alcunché), l’Amministrazione che fa? Prepara il campo, rendendo gli immobili di quell’elenco effettivamente adeguati ad essere messi a bando. Il problema è, evidentemente, quello di “rendere liberi” gli immobili che non lo sono. In italiano: sgomberi. A dettare regole e priorità ci pensa allora la seconda Delibera, la 140 del 30 aprile 2015. Oggetto: «Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione». Tra le premesse, si trovano molti degli elementi già descritti. Incidentalmente, vi si trova per la prima volta un elenco generale (cioè che vale per tutti) dei criteri che devono avere tutte le procedure di evidenza pubblica per la nuova concessione degli spazi: «pubblicità, trasparenza, concorrenzialità, efficacia ed economicità». Sono i valori del new public management neoliberale, l’applicazione delle logiche di mercato al sociale. Il testo normativo prosegue poi in una vera e propria dichiarazione di guerra contro chi abbia in concessione o in locazione immobili pubblici, descrivendo indiscriminatamente un quadro di morosità, di mancate regolarizzazioni, di utilizzazioni abusive. L’ordine è uno solo: rientrare in possesso di tutti i beni immobili, sfrattando chi li utilizza. Ripetiamo: indiscriminatamente, nel senso che in nessun modo viene presa in considerazione la natura delle attività che in quegli spazi si svolgono. L’esito è sempre lo sgombero; l’unica differenziazione viene fatta rispetto a procedure e modalità.
Infatti, la Delibera stabilisce che la priorità degli sgomberi debba partire da chi sia già destinatario di un provvedimento di rilascio per altre ragioni (punto 1), e dagli spazi con finalità commerciale, professionale o imprenditoriale (punto 2). Il punto 4, invece, si rivolge agli «utilizzatori che svolgono prevalentemente effettive funzioni, attività e/o servizi d’interesse pubblico, e che pertanto utilizzano il bene con modalità compatibili con la sua destinazione e che non risultino morosi». Per loro, l’avvio delle «procedure finalizzate al recupero della disponibilità del bene» (gli sgomberi) dovrebbero avvenire solo «successivamente rispetto a quanto previsto ai punti 1 e 2» e «d’intesa con i Dipartimenti ed i Municipi interessati». Inoltre, lo stesso punto precisa che «resta inteso che i fattori dell’interesse pubblico e dell’utilità dei servizi svolti per la collettività, saranno considerati nel definire l’attuazione temporale del piano di recupero dei beni». C’è da dire che queste magrissime consolazioni (intesa con i Municipi, piani temporali dilatati, e poco altro) non stanno venendo applicate in nessuno dei procedimenti di sgombero in corso. Infine, per dovere di cronaca, c’è da ricordare che la delibera prevede un ulteriore punto 5, relativo agli «utilizzatori quali Enti, Organismi o Associazioni che svolgono comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega o per conto di Roma Capitale, e Enti ed Organizzazioni internazionali riconosciute dall’ONU»: a loro, e solo a loro, non si applica questa nuova zelante disciplina, ma il vecchio e più garantista Regolamento sulle Concessioni del 1983. Qualche campione di ermeneutica giuridica, già citato, può sostenere che in realtà questo punto 5 potrebbe essere interpretato in maniera estensiva, in modo da includere anche gli spazi sociali e le realtà autogestite e autorganizzate di Roma, mentre purtroppo l’attuale amministrazione commissariale romana la sta interpretando in maniera restrittiva, in modo da escluderli. A quel campione sarebbe forse opportuno ricordare che una norma ben scritta è una norma che non si presta a una tale radicale divergenza interpretativa e che potevano esserci infinite altre formulazioni testuali possibili a sostegno di una posizione effettivamente garantista. A quel campione, comunque, continueremmo a dare credito se si facesse intermediario per un riconoscimento delle realtà autogestite presso le Nazioni Unite, per fugare definitivamente ogni dubbio ermeneutico.
Altre saranno le sedi per dimostrare, esperienze municipali alla mano, che un altro modo (di governare, di decidere, di amministrare il patrimonio pubblico) era ed è tuttora possibile. Un modo per riconoscere e promuovere l’uso comune degli spazi pubblici. In questa sede, basti esprimere il ricordo della ormai preistorica Delibera 26 del 1995. Si tratta, come è noto, della Delibera con cui i Centri Sociali romani conquistarono riconoscimento politico e legittimità giuridica nella loro autonomia. Durissime furono le lotte che la strapparono. Racconta chi ha memoria che l’iter della sua scrittura fu fatto, oltre che di cortei moltitudinari, assemblee di massa, blitz e manifestazioni, di funzionari e amministratori pubblici in pellegrinaggio presso ogni realtà sociale romana, per sottoporre il testo in approvazione agli interessati, per ottenere pareri, per raccogliere modifiche, per migliorare il senso e il contenuto dell’azione politica. A capo di quelle delegazioni di funzionari e amministratori pare ci fossero Walter Tocci e Roberto Giachetti. «Il presente regolamento si applica alle occupazioni senza titolo formale accertate alla data del 31 dicembre 1994 di beni immobiliari ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune di Roma, ai fini delle loro regolarizzazioni che potranno essere deliberate nei termini di cui ai successivi articoli. Il presente regolamento si applica per le nuove assegnazioni di beni immobiliari ascritti al patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Roma».