CULT
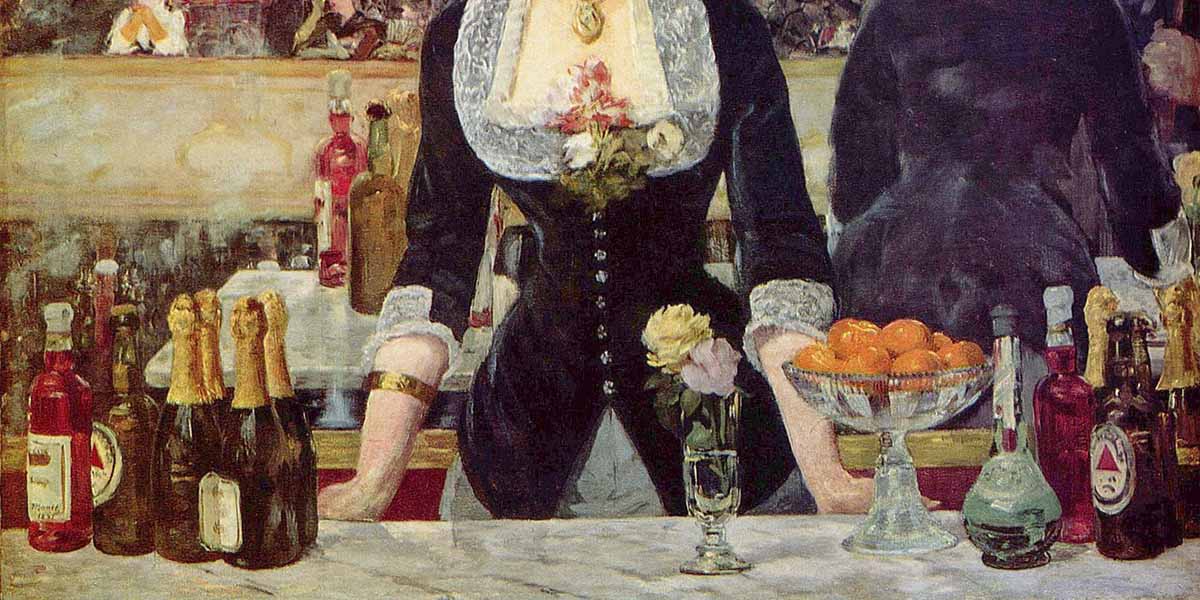
Una spia nella casa del food
Cosa fa una cameriera e come tutto il settore della ristorazione stia peggiorando quanto a retribuzioni e cultura del cibo. Dalla biografia all’attivismo delle Clap
Nelle edizioni Einaudi una serie specifica dei Quanti (collana di piccoli e-book) è dedicata al tema “Lavori” – non “lavoro”, stante la nebulizzazione e delle attività e del loro sfruttamento – e quindi al conflitto che sempre più aspro ne scaturisce. Storie assortite di vita, depressione, resistenza. A Sarah Gainsforth è toccato “Cameriera”, un mestiere tipico da lavoratore povero, che resta sul filo della sopravvivenza (o anche sotto) e viene esercitato spesso come primo impiego non specializzato e provvisorio in attesa di meglio. Tuttavia non si tratta di un azzardo esistenziale ma di un fenomeno di massa, della prima voce della filiera (commercio e turismo) più richiesta nella domanda occupazionale, ben 18%, e ovviamente consigliata a tutti gli studenti come sbocco professionale dalle circolari dell’ineffabile ministro dell’Umiliazione e del Merito, Valditara.
Chi fa la cameriera non ha tempo di scriverne, può farlo quando ha la fortuna di uscirne fuori e intraprendere un percorso più gratificante – come è il caso dell’autrice, diventata autorevole giornalista di inchiesta e sociologa dell’abitare – e allora abbiamo, per parafrasare un altro irlandese, un Portrait of the Artist as Young Woman.
Sarah vuole uscire di casa e dalla famiglia, sebbene ami entrambe, e concluso il liceo se ne va, finendo inevitabilmente a San Lorenzo e cercando lavoro nei pub. Migra come un uccello – segue, del resto, le orme del padre, che aveva vagabondato fra il riformatorio e due continenti – e però a inizio millennio così fanno in molti e il ramo turismo e ristorazione da allora non fa che crescere e le retribuzioni a scendere. D’altronde, altri lavori, a volerli, non ci sono: dopo la crisi del 2008 il manifatturiero ha perso il 23% e l’occupazione si sposta nel terziario, per metà servizi di albergo e ristorazione e lavori domestici. Tutto sottopagato, per non parlare del nero.
Nel 2021 un lavoratore su tre prende meno di 1.000 € al mese e una bella quota degli stessi sta sotto il livello del reddito di cittadinanza; il 64% degli addetti al settore alberghiero e della ristorazione è a tutti gli effetti formato da working poor, con orari di lavoro prolungati e discontinui. La situazione descritta nel libro è quindi addirittura un eden, paragonata a quanto è venuto dopo, soprattutto dopo la pandemia, che ha falcidiato il settore, massacrando il personale ma rimpinguando gli esercenti superstiti, che hanno ottenuto sconti fiscali e risarcimenti dallo stato nonché gratis dai comuni gli spazi per invasivi dehors.
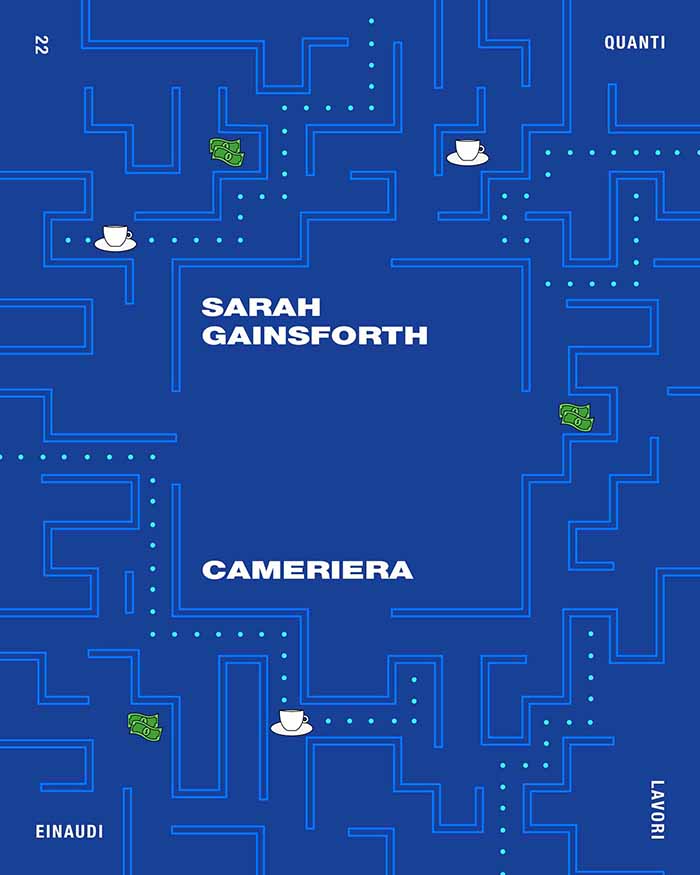
Ma torniamo ai primi 2000, all’eden della libertà assaggiata, perfino a un locale in una piazzetta pedonalizzata di Trastevere dove ci si trova bene, «ha un’anima». Il padrone è bravo e i colleghi simpatici. Un “progetto di libertà“ ed è già qualcosa.
L’alloggio è invece un problema (e lì Sarah Gainsforth si forgia quale futura sociologa della casa). Guadagna circa 800 euri a mese su tre o quattro turni a settimana e non può lamentarsi, ma se ne vanno 450 fra bollette e affitto, condividendo l’abitazione con tre ragazzi e una ragazza. Pochi mobili, pavimento a mattonelle e tante feste, cinema, biciclettate, incursioni con il treno notturno a Parigi. Prima che voli Ryan Air.
Al lavoro, però, bisogna arrivarci, tagliando tutta Roma da Sanlo a Trastevere. Il 71 non passa mai (esperienza consueta a tutti i romani e tuttora constatabile all’alba del 2023!), poi bisogna cambiare, a volte anche a Roma piove ed è un disastro, i taxi sono cari, possono mangiarsi un quarto del salario giornaliero e tornarsene in bici alle tre di notte è tutto in salita, dal livello fiume al colle Esquilino. Con i piedi gonfi dopo nove ore di lavoro.
Già, perché anche il lavoro è un eden relativo. Sarah non si rilassa certo servendo ai tavoli ma è curiosa, apprezza i dettagli. Impara con piacere a non far rumore affettando le verdure mediterranee sul tagliere o stappando le bottiglie dopo aver esibito l’etichetta all’avventore.
Soffre nelle fasi d’ozio, guardando attraverso i vetri, di lunedì, i sampietrini bagnati. Decifra e sopporta i clienti, si sente esposta, come se recitasse una parte, e vuole concentrarsi sul lavoro. Si muove con la precisione elastica di un pugile (ha letto Loïc Wacquant) e guai a interferire con il suo ritmo – «non bisogna mai e poi mai provare ad aiutarla afferrando qualcosa da un vassoio pieno». Una sola volta accetta di uscire con un cliente e le capita un aspirante psicologo comportamentista, che sfiga per una ragazza complicata. Prima che arrivino le folle si può dialogare con gli artigiani che ancora fronteggiano il locale, c’è da tenere a bada i vigili malintenzionati e impiccioni. Ryan Air non scarica ancora orde rumorose di turisti, gli studenti americani a caccia di sciottini a 1 € sono pochi e la gentrificazione spinta del quartiere è solo agli albori.
Però non è un eden, almeno non al 100%. «Fare la cameriera è un lavoro faticoso. Sfiancante. Passo nove ore in piedi, otto a servire e una di pulizie, camminando da una parte all’altra del caffè, dal bancone alla cucina, ai tavoli, alla sala interna, ogni volta sono tre gradini […] Quando arrivo a casa mi butto sul letto, le gambe in alto, appoggiate contro la parete. Mi fanno sempre male, sono dure e gonfie, mi addormento così e mi sveglio all’una indolenzita, gli occhi cerchiati e la testa vuota. Non so cosa farò nella vita, per ora sono una cameriera». Quando si ha fame di mondo, poi la durezza del reale la si descrive bene.
Gli anni sono passati, il bar è cambiato di gestione e il simpatico proprietario ha cambiato mestiere. La piazzetta del Velabro dove si affaccia la casa d’infanzia dell’autrice è blindato da cancellate Fendi e sovrastato dal Rhinoceros, con i suoi sofisticati menu virtuali. La ristorazione è ascesa a cultura del FOOD: «Cibo autentico, cibo alternativo, cibo etnico, cibo tradizionale. Ristoranti con piastrelle di smalto lucido, bistrot e pokerie prendono il posto di negozi di frutta e verdura, casalinghi, bar e alimentari. Nel 2017 le attività food presenti nella zona sito Unesco di Roma, un decimo della superficie urbana, erano il 18,5% di quelle presenti nell’intera città. L’imperativo è mangiare, consumare, ovunque, qualsiasi cosa. In mezzo al nulla spuntano parchi enogastronomici e centri commerciali, nei cortili di edifici storici si apparecchiano tavole, si montano stand, compaiono espositori di salumi e assaggini di prodotti “tipici-locali”. Non si trova più una normale pizzeria al taglio, una trattoria o un bar che non voglia offrire anche un qualche tipo di “esperienza”». E naturalmente dove c’è “esperienza” c’è “resilienza” – degli addetti, beninteso, cioè abbassamento dei salari, precarietà dilagante dell’occupazione, inasprimento delle condizioni di lavoro.
E la reazione dell’autrice, che è materialista e non romantica, è allora non la nostalgia della città di un tempo e di un mestiere abbandonato, ma l’impegno sindacale a migliorare le condizioni retributive e a potenziare e riqualificare le misure di Naspi e reddito di cittadinanza, che, seppure insufficienti, hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei precari in sé, nelle istituzioni e nel futuro, aiutandoli a rifiutare le offerte schiavistiche di lavoro – ah, non si trova più nessuno che voglia lavorare dodici ore al giorno per quattro euro all’ora, tutti fannulloni sul divano. Quando invece sono spesso gli esercenti a stare sul divano trovando personale in nero sottocosto proprio grazie al loro percepire un sussidio integrativo pubblico, RdC o cassa integrazione all’epoca Covid del solo asporto.
Si indica di conseguenza come via d’uscita l’attivismo delle Clap, le Camere del Lavoro autonomo e precario, sindacato autorganizzato che sta colmando «un vuoto, lasciato dai sindacati tradizionali, nella difesa dei diritti di lavoratori impiegati in un mercato profondamente frammentato, mirando a sindacalizzare chi lavora nei call-center, nelle pulizie, ma anche i grafici, i ricercatori e gli operatori sociali, al di là di categorie tradizionali».
Un tempo sociologi e scrittori facevano “osservazione partecipante”. Che vi si ritorni è un buon segno.
Immagine di copertina da Édouard Manet Il bar delle Folies-Bergère (1882)




