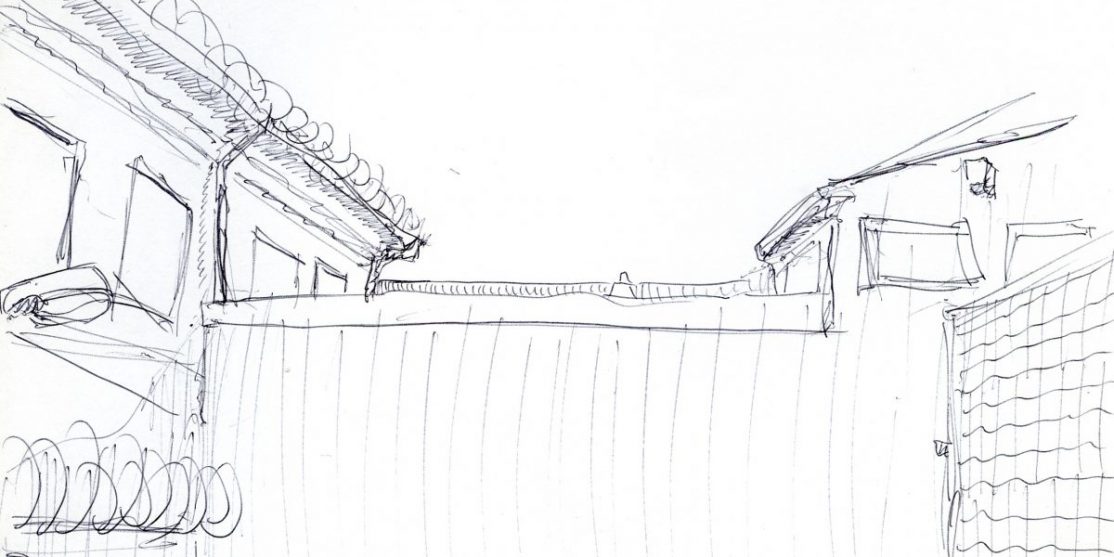ROMA

Taxiwriter 14. È ancora Trinità
Tra una corsa e l’altra alla guida del suo mezzo, Andrea Panzironi riflette, discute e osserva gli angoli di città in cui la storia ha lasciato delle tracce. Il quattordicesimo racconto per dinamopress
Quasi non riesco a guidare stamattina. La luce arriva dritta negli occhi come scagliata da un lanciatore di coltelli nascosto dietro il sole radente. E ogni cosa, ogni persona che incontro, ogni rilievo che noto, si fa dettaglio, perfettamente incastonato nel quadro iperrealista che mi scorre davanti. Persino i vicoli oscuri tra i palazzi del centro sono violati da un filo di luce che sbatte sui sanpietrini, che ora si fanno lucidi come al passaggio di un rivolo di sola luminescenza. Tre topi grassi e gaudenti si danno da fare tra i sacchi d’immondizia abbandonati dai ristoranti fuori dal retrobottega. La coppia di gabbiani bianchi e grigi che passeggia austera nei pressi li lascia fare con lo stesso piglio arrogante dei borghesi benestanti verso il popolino accattone. La natura si inquina a stare tra gli umani e ricrea le stesse distanze sociali.
Arrivo al Pantheon dove c’è un uomo in attesa di un taxi. Indossa occhiali a goccia scuri, un cappellino sportivo con visiera ed un giubbotto di pelle nera. Mi fa un cenno, accosto. Sale e mi dice l’indirizzo da raggiungere. Ha un accento tendente all’americano con una inflessione napoletana. Lo riconosco. È Terence Hill. Il mio sorriso di allarga come una fetta di mont blanc lasciata troppo tempo nel piattino. Mentre lo osservo dallo specchietto noto che l’età non ha lasciato che lievi rughe sfumate dovute ai sorrisi elargiti generosamente dal suo volto dal profilo netto e sincero. Pesco nel grande lago della mia memoria e rivedo la polvere del deserto spagnolo dove i cinematografari de noantri degli anni Sessanta e Settanta si davano da fare per ricreare le atmosfere dei più nobili deserti statunitensi. C’è Trinità sdraiato sulla lettiga di legno trascinata dal suo cavallo smagrito ed indolente e risento il suono secco e gioioso degli schiaffoni elargiti generosamente a destra e a manca dal suo amico gigante. Ora Bud non c’è più, chiamato a dare man forte agli angeli tra le nuvole e lui, Terence, si appresta a girare l’ottava serie vestito da prete.
Il cerchio sottile delle rimembranze si chiude quando visualizzo un pomeriggio di inizio primavera del ’75 dove il poster di E lo chiamavano trinità era affisso all’ingresso della sala parrocchiale gestita da un altro prete, Don Gregorio. Qui, prima della globalizzazione e dei voli a basso costo, noi ragazzini dei quartieri di periferia potevamo fare il giro del mondo attraverso le pellicole graffiate delle quarte e quinte visioni. E tra i vicoli dei lotti popolari della Garbatella, nel silenzio della controra estiva, cercavamo ingenuamente di rifare quei duelli, con pistole e fionde improvvisate, fatte di rami d’albero ed elastici a “quadrelli” e ogni tanto una donna del popolo si affacciava gridando, sporgendosi da un terrazzo del palazzetto di tufo scolpito in stile barocchetto per scacciarci a suon di parolacce, oggi dimenticate, quando accaldati ci abbeveravano al “nasone” sotto casa sua mentre degustavano un “siberiano liscio” offerto dall’azienda comunale dell’acqua pubblica.
Quelle donne, con le zinne strabordanti oltre l’apertura del grembiule sgualcito dalle faccende domestiche, i folti capelli neri di corvo legati sulla nuca e le cosce tornite da fasci di muscoli ancora pulsanti di giovinezza matriarcale che dal basso noi brufolosi spizzavano fin su alle mutande per imprimerle come marchio di fuoco sulla retina dei nostri occhi rapaci; e divenire a sera attrici insaziabili nelle proiezioni iperboliche delle nostre masturbazioni adolescenziali, consumate sotto estive leggere lenzuola bianche che, come fantasmini da cartone animato, ballonzolavano nel buio delle nostre stanze.
Arrivo a destinazione, accosto. Terence mi paga con un pezzo da dieci e un sorriso buono e sincero. «Mi perdoni, non posso non chiederglielo… – gli dico mentre esce dall’auto – don Matteo ha il cinturone con la pistola sotto la tonaca, vero?», faccio cercando la battuta. Lui mi guarda serio per poi e sorridere compiaciuto. «Certo, si vede vero? », replica . Io resto spiazzato, «ma, veramente.. », balbetto incerto. «Ricorda, chi è stato Trinità gira sempre con pistola e cinturone, anche vestito da prete», termina uscendo e chiudendo lo sportello. Lo vedo sparire col suo passo d’atleta in mezzo alla folla di turisti e grigi uomini d’affari. E per alcuni lunghi istanti gli occhi del bambino rivedono l’eroe camminare nella nuvola di polvere del deserto della fantasia di chi è stato almeno una volta cow boy. Un clacson feroce mi bussa alle spalle, rinsavisco e innesto di riflesso la marcia, l’auto balza in avanti come fosse un quadrupede brocco e scontroso, mi tocco il fianco cercando invano la pistola e il cinturone…