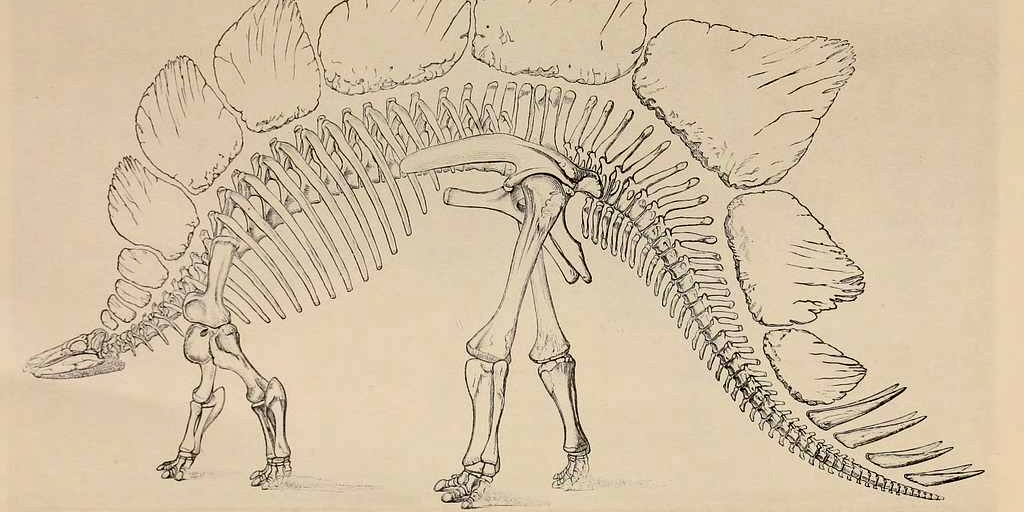OPINIONI

Riflessione su Cutro, dall’altra sponda del Mediterraneo
Un racconto dal Gambia, per riflettere sul regime dei confini e quello che ne deriva, come il naufragio vicino le sponde di Cutro, uno dei tanti che ha visto negli anni scomparire migliaia di persone nel Mediterraneo. La migrazione tratta come un problema le persone che migrano, depersonalizzandole e evitando di affrontare la disparità che c’è tra un passaporto o l’altro e le motivazioni che spingono all’espatrio
Scrivo questa breve riflessione pochi giorni prima di ripartire da Serekunda, Gambia.
Sono qui per fare ricerca sulle politiche di esternalizzazione delle frontiere UE, e ho vissuto da questo difficile (eticamente e politicamente) posizionamento la notizia e conseguenti sviluppi del naufragio al largo di Steccato di Cutro.
Come tutti sappiamo, non si tratta né del primo né dell’ultimo che vedremo, esattamente così come il dibattito politico e mediatico conseguente sembra più una variazione sul tema, una sorta di ricomposizione di elementi e repertori già esausti, in cui anche il presentismo della permacrisi assume contorni grottescamente farseschi. Nell’osservare da qui il rituale strapparsi le vesti moralizzatore di una parte dell’opinione pubblica e dello spettro politico, i balbettii imbarazzanti e le esternazioni eugenetiche dei vari rappresentanti delle istituzioni e il rimpallo di responsabilità tra Frontex e guardia costiera, quello che mi viene in mente è come coloro costruiti come migranti siano diventati oramai una risorsa da estrarre e sfruttare politicamente, una sorta di currency delle relazioni internazionali, che siano morti o siano vivi in fondo non fa molta differenza.
Qui, come in Europa la gente che cerca vie per l’Europa come extrema ratio a una serie di problemi strutturali in cui si ritrovano incastrati, è, nei discorsi “ufficiali”, alternativamente compatita, criminalizzata, stigmatizzata e vittimizzata a seconda del contesto, del clima politico e dello stato delle relazioni tra paesi UE e governo Gambiano.
I processi di alterizzazione a cui sono soggette le persone in movimento non sembrano fermarsi quindi alla sponda Nord del Mediterraneo, ma si riverberano anche nei cosiddetti “paesi di origine”, il gioco crudele del regime dei confini che t’insegue ovunque, materialmente e simbolicamente, deumanizzandoti a diverse latitudini e in diversi contesti socioculturali. Nel pensare Cutro da qui, mentre vado in giro sulle strade polverose di Serekunda grazie ai miei privilegi di bianca europea che non deve neanche farsi il visto per passare mesi a ficcanasare negli affari altrui (anche se sarebbe da definire cosa si intende per “altrui”, visto che mi occupo di politiche di esternalizzazione), ho scritto questa riflessione di getto, senza pensarci troppo. Non c’è nulla di nuovo in quello che dico, piuttosto ho pensato di usare la mia esperienza per ricordare per l’ennesima volta che i cosiddetti “migranti” sono persone, non numeri, corpi, minacce alla sovranità o merce di scambio tra stati-nazione, anche se sono trattati come tali. Visto che però i meccanismi di alterizzazione e deumanizzazione sembrano essere così caparbi e resistenti, mi sono chiesta come sia cambiata la mia percezione delle persone migranti nel tempo e quali siano state le forze che l’hanno orientata.
In questi anni sono arrivata alla banale conclusione che é dalla gioia, dalle risate, dagli scherzi e dalle prese in giro, anche dalle discussioni e dai litigi che s’impara a riconoscersi negli altri. Senza quello, i corpi sofferenti rimangono tali, altro da te, ti spaventano di dolore, ti fanno sentire al massimo fortunato o in colpa, ma niente di più.
Gli altri rimangono altri quindi meno umanamente vivi di te, la loro morte e le atrocità che hanno vissuto creano quel muro, non lo distruggono, soprattutto quando gli altri sono soggetti razializzati..
Se ho imparato qualcosa lo devo invece solo a quei momenti di leggerezza, alla musica, al ballare insieme, al mangiare dallo stesso piatto, a passarsi le bottiglie di acqua, le sigarette.
Ai momenti in cui abbiamo parlato delle nostre famiglie, delle nostre delusioni, dei desideri che abbiamo dovuto ricalibrare. Allo stare seduti in un cortile di un compound la sera, con le luci del telefono e le casse connesse a un cellulare, ad ascoltare afrobeat, reggae, hip hop, grime, mbalax.
A rimanere bloccati nel traffico in un van dove non c’è neanche spazio per respirare e riuscire a farci una battuta sopra. Fermarsi sotto un albero e farsi le foto, un passante che scambia due parole, scuotere la testa, sorridere sotto i baffi.
Mi era successo lavorando in accoglienza, l’ironia ci ha salvato dai momenti più oscuri, in cui ci sentivamo solo ingranaggi in un meccanismo mal oliato ma inesorabile, che ci spogliava della possibilità di sentirci insieme. Mi è successo venendo qui, condividendo anche per poco la vita con altri, discutere e vivere le differenze, le incomprensioni, a volte ridicole e risolvibili, altre volte apparentemente insormontabili. Mi è successo quando mi sono arrabbiata e ho pianto, le volte in cui mi sono beccata gli “you people” e ho provato a rinegoziare, mi è successo quando ho alzato la voce, o quando sono scoppiata a ridere, o quando ce ne siamo stati sotto una coperta di silenzio, protetti nei pensieri della sera. Ovviamente non c’è nulla di risolto, le ambiguità, asimmetrie, e relative connivenze, volontarie o involontarie, continuano a intrecciarsi nelle mie relazioni, ne sono, in un certo senso, le stesse condizioni di possibilità. Ci sono però momenti in cui queste si possono trascendere o sovvertire, anche solo per poco. Sono spazi in cui l’antagonismo strutturale di cui hanno parlato Saidiyia Hartman e Christina Sharpe sembra meno determinante, qualcosa di cui si può riconoscere le matrici passate e presenti, senza però farsene inghiottire, ma piuttosto con cui ci si può coinvolgere, ci si può interpellare. Penso che non ci siano tante altre soluzioni se non appellarsi proprio a questi momenti.
La prima volta che ho visto Fuocoammare sono uscita dal cinema tutta annodata di rabbia dentro, senza riuscire a parlare. Non per quello che avevo visto, il barcone con i corpi senza vita ammassati sotto coperta, la cinepresa che ne sfiora i profili con la luce che filtra dalle tavole di legno. O forse mi sono arrabbiata per questo, ma non per l’indignazione o per la pietà. Mi sono arrabbiata perché quelli che erano stati mostrati erano appunto corpi, sacchi di organi che erano stati abitati forse da qualcuno ma quel qualcuno non era lì, era stato cancellato dal campo lungo su una distesa di morte. Mi sono arrabbiata perché ho pensato che quei corpi potessero essere di Selim che mi chiamava “fino” perché secondo lui ero troppo magra. Oppure di Tijan con cui litigavo di politica e che mi faceva il verso quando parlavo, oppure ancora di Alagie, che si metteva la camicia quando facevamo le preparazioni alla commissione, o di Ibrahim con cui ci scambiavamo le playlist e che mi diceva che la mia macchina faceva schifo.
Quando ho sentito le storie delle persone con cui lavoro ora, giovani Gambiani che sono “volontariamente” rimpatriati dopo mesi nei centri di detenzione libici, non è stato il racconto delle condizioni in cui vivevano nel centro di detenzione, i turni in piedi per dormire la notte, l’essere lasciati a volte anche a morire con le proprie malattie e ferite, a cui ho continuato a pensare per giorni. È stata invece la risata liberatoria in cui siamo scoppiati quando mi hanno raccontato dell’applauso che facevano a chi riusciva a farsi spazio tra i corpi e raggiungere l’unico bagno presente per centinaia di persone, oppure il guizzo ribelle di usare l’ipocrita spazzolino distribuito da UNHCR per scrivere “Gambian zone” sul muro del centro. È il racconto delle battle musicali tra paesi con le bottiglie di plastica al posto del microfono la sera, e di tale “cameraman” che le riprendeva con una telecamera fatta sempre di bottiglie. È Alieu che organizza la lettura del Corano a orari prestabiliti, Mariama e Binta che s’inorgogliscono parlando della volta in cui hanno fatto a botte con le nigeriane per guadagnarsi il rispetto necessario ad accaparrarsi una razione di cibo.
Si può capire, provare ad avvicinarsi, più che nel racconto del dolore, nella capacità di ricavarsi uno spazio, per quanto risicato e angusto, per farsi una risata, cantare una canzone che conosci, per dire non ho capito, prova a rispiegarmi, non sono d’accordo, che cazzo dici, si è vero, una volta è successo anche a me. Ci si riconosce nella capacità di lottare, di avere coraggio, di reinventarsi, di creare con niente un modo per esserci, ricordarsi di sé, nonostante tutto.
Solo dopo questo, quella morte, quella sofferenza, ti sembrano inammissibili, incompatibili con la tua stessa presenza nel mondo. Solo dopo senti che non puoi appartenere silenziosamente a uno Stato in cui non solo si lascia che questo accada, ma che coopera per renderlo possibile e per utilizzarlo come strumento di deterrenza. Solo dopo cerchi delle risposte, complicate, contraddittorie, multiple e incomplete per capire perché succede e come non farlo succedere più.
La sofferenza degli altri non ci tocca veramente perché non ci appartiene se non c’è riconoscimento. Il mio augurio, anche se può sembrare paradossale e imperdonabilmente ingenuo, visto lo stato delle cose, è quello che ci vengano date opportunità per riconoscerci nella complicità di uno scherzo, nel gioco, nella grazia e nella gioia, perché l’alternativa è quella di riconoscerci nella sofferenza, che però non potrà essere allora solo degli “altri”, ma anche nostra.
Immagine di copertina da Openverse di psicologiaclinica