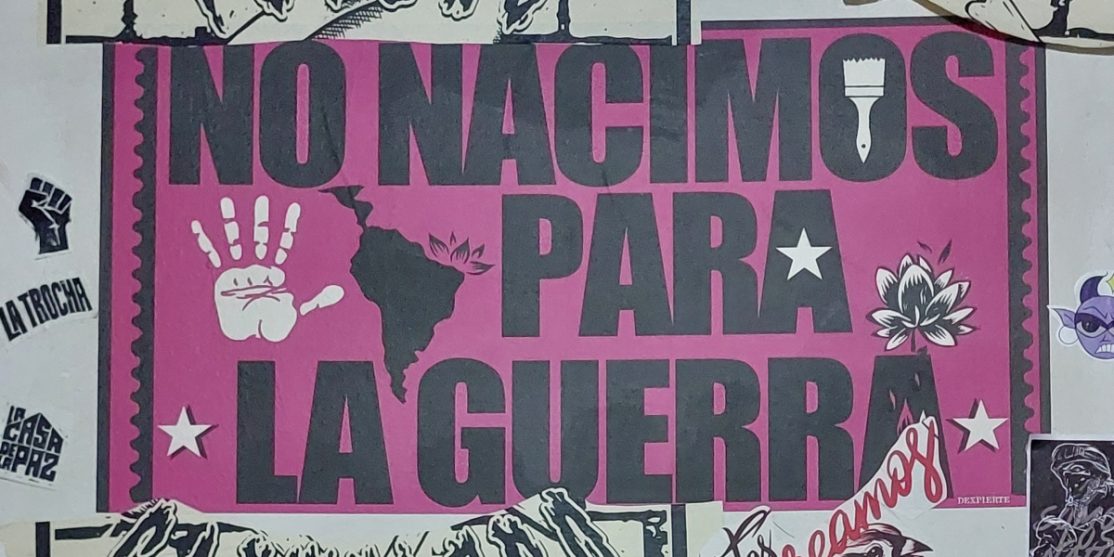Ogni dolore ti porta un po’ più in là
Un giorno devi andare è un film di Giorgio Diritti con Jasmin Trinca.
E’ il silenzio a circondare il dolore di Augusta.
Quello costruitole intorno dal proprio compagno che, colpevolizzandola per non essere riuscita a portare a termine una gravidanza e non poter avere figli, la lascia. Quello di un padre musicista che, morendo, interrompe quel “parlare”, fatto anche di note, che li legava tra loro. Quello di una madre, e di una nonna, incapaci di trovare le parole per cercare di capire il suo dolore. Quello di una città, siamo nella Valle di Non in Trentino, stretta tra le montagne a fare da sfondo a “comunità” tutte risolte all’interno di spazi “istituzionali”: l’eremo, l’ospedale, il teatro, la casa dove anche una conversazione via Skipe, pur attesa, mostra la difficoltà di tirar fuori e controllare le parole.
Augusta trova così naturale, quando tutto sembra schiacciarla precipitandole addosso, di spostare il proprio corpo oltre l’orizzonte geografico e i riferimenti che l’hanno fino ad allora accompagnata. Ma, ancora una volta, anche se si muove sulle rotte lungo le terre là dove il mondo finisce (ma dove ha avuto inizio), a mancare è nuovamente la parola. O, meglio anche qui, continua ad essere circondata da quelle – possono essere anche poche- che decidiamo di farci precipitare addosso per non tirar fuori le tante che sarebbe il caso di urlare.
Così eccola lungo il Rio Negro, in Amazzonia, accompagnare Franca, una suora trentina missionaria e amica della madre, che percorre lunghi tratti di quel fiume, largo come un mare, decisa a “fare del bene”. Franca è una che parla, ma non ascolta. A bordo di un battello, dal profetico nome Itinerante, da ormai quattro anni, giorno dopo giorno, svolge un viaggio dal carattere “combinatorio”: evangelizzare e controllare la concorrenza di sette che quelle comunità raggiungono attraverso le tele prediche. Lei ha un metodo tutto suo: rafforza le parole del catechismo con la consegna ai piccoli indios di infiniti bambinelli (tra poco sarà Natale) in alabastro a segnare, con un oggetto, il loro essere parte di una storia universale e, così, a “tenere la contabilità”del proprio lavoro.
Troppo poco per chi, come Augusta, ricerca una risposta al proprio dolore.
Lei vuole “essere terra nella terra”. La barca non può andare oltre il lambire le rive. Fuori bordo c’è Manaus; forse l’altrove che cerca. Sceglie di vivere lì. Tra le centinaia di baracche montate su palafitte che fanno da parterre all’espansione e alla trasformazione di quella città, posta all’intersezione del Rio Negro con il possente Rio delle Amazzoni, in uno dei gioielli del BRIC- Brasile.
Una favela dove le baracche sono auto-costruite una addosso all’altra cannibalizzando navi, barche e battelli che su quella sporca spiaggia vanno ad arenarsi. Un enorme cantiere che produce e riproduce la favela. Qui Augusta scopre d’essere in una comunità. Così non e’nella provincia trentina. Qui la vita è collettiva; tante le parole. Nessuno è solo; la vita, addirittura, viene raccontata e progettata in diretta da uno speaker che parla dei problemi della favela tra una radiocronaca di una partita di calcio e l’altra che ininterrottamente si svolgono sull’unico spiazzo libero miracolosamente sottratto alle case sospeso sull’acqua.
Simile, più che ad una piazza, ad un grande orecchio capace di catturare ogni voce di chi quel posto abita per immediatamente rilanciarla. Soprattutto ora che c’è da prendere una decisione vitale: cedere, o meno, alle lusinghe dell’amministrazione che vuole fare di quella distesa di legno e lamiera, ma direttamente affacciata sul fiume, il nuovo waterfront. Venir liquidati con un pugno di reais e deportati in scatolette di cemento quale contributo personale alla “lucidatura” del paese per il prossimo appuntamento del mondiale calcistico e a quello olimpico.
Augusta accolta in quelle famiglie, chiamata “principessa” sembra però non capire il dolore che questa scelta impone ai suoi ospiti. Per lei quella è la città ideale. Come un pifferaio magico suonando gli strumenti musicali del padre inviati dall’Italia – unico atto d’amore di una madre annichilita per tutto il film- vuole dirigere la banda dei bambini. Vuole dirigere tutto. Mette su un gruppo di lavoro per tirare a lucido la lucente attrezzatura di una palestra della città alta , senza accettare nessuna mediazione. Non capisce che le parole di questa lingua, che ora padroneggia, nel loro essere gentili e leggere racchiudono dei codici, dei comportamenti, che non possono essere trascurati.
Come aveva fatto la suora con i bambinelli, lei farà altrettanto distribuendo, dal centro di un autobus, le misere paghe quotidiane a chi ha coinvolto in questo lavoro. Anche in questo caso una questione di contabilità. Si deve fare così e continuare a farlo. Quando una parte di quel popolo sceglierà di non seguirla eccola pronta a mettere su la soluzione: trova ancora forza lavoro. Donne questa volta, così gli attrezzi per fare belli i corpi dei ricchi, potranno continuare ad essere lucidati a puntino.
La comunità spaccata è più che debole e disarmata preda di traffici e quando un nuovo tremendo dolore attraverserà il mondo delle palafitte (la vendita di un bambino) Augusta rinuncia del tutto alla parola addentrandosi sempre di più lungo i meandri del fiume, fino a fare della lunga lingua di sabbia bianca, dove tirerà su la sua nuova casa di teli e rami, il luogo dove poter trovare nel gioco silenzioso con un bambino, capitato lì come una delle tante cose che porta il fiume, un momento di felicità. Risate, movimenti del corpo, gesti che rimandano a futuri incontri. Ancora silenzio di parole.
Senza quelle parole che, abbandonando Augusta, si ritroveranno sulla bocca di quella madre india che, per sopravvivere al dolore della scomparsa del figlio, seguirà Franca, la suora, nel suo rientro nell’eremo del trentino. Sarà lei a ritrovare, di fronte un corpo che abbandona la vita, le parole di una preghiera laica; a ringraziare proprio quel corpo per aver attraversato quella parte del mondo che i suoi piedi leggeri hanno avuto in sorte.
Un doppio andare verso e da dove il mondo sembra finire. Una rotta, in questo periodo, abbastanza trafficata.
Se Francesco presenta se stesso e la sua funzione come necessità di ripensare alla povertà per parlare del e al mondo, Augusta ( una bravissima Jasmine Trinca ) sa bene che non può essere, come il Francesco di Giotto nel sogno di Innocenzo III, lei a sostenere la grande architettura istituzionale. Per lei la città/casa, il suo guscio,deve essere prima abbattuta per poi essere ricostruita. Le favelas del mondo non sono solo in Amazzonia; è mischiando tra loro le ricchezze dei pochi alle sconfinate povertà dei molti che le metropoli trovano la propria forza e le forme di comando. Perdersi nella natura potrà essere una soluzione temporanea; la Chiesa è pronta a progettare e realizzare un “resort” di lusso per pii pellegrini che vogliono vedere la povertà da vicino.
Conta poco trovare o non trovare la fede. Forse ed è questo il senso del film il dolore come il sogno ti spinge sempre un po’ più in là, sta a noi non pensare che dolori e sogni appartengano solo ad ognuno di noi. Cercarsi è anche riconoscersi e, soprattutto,fare.
Ancora una volta il bel cinema di Giorgio Diritti.