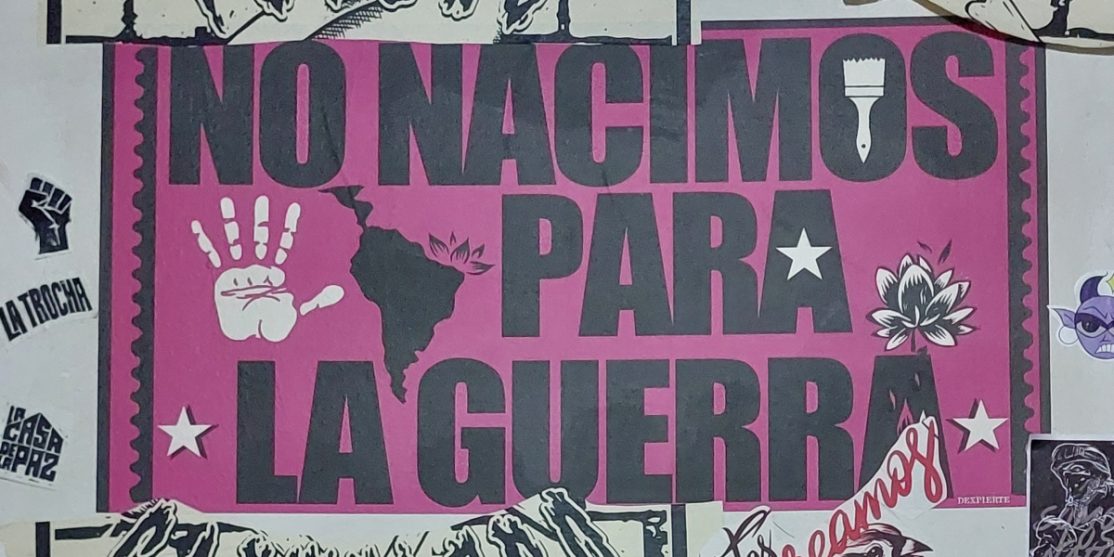MONDO
La violenza torna sempre a casa: intervista ad Arun Kundnani

Il terrorismo non si combatte con la guerra, ma con politiche anti-razziste e anti-capitaliste.
Arun Kudnani, autore di The Muslims are coming!, ci spiega perché.
A seguito degli attacchi di Parigi, quali sono le tragiche e più logiche conseguenze di una guerra senza confini fisici? In questa intervista, lo studioso, che si occupa di terrorismo e politiche di contrasto all’estremismo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, spiega e critica le ramificazioni della guerra al terrore, partendo dalla retorica – liberale o conservatrice – utilizzata da intellettuali e commentatori, e arrivando alle teorie sul radicalismo che hanno alimentato i programmi antiterrorismo in Occidente. Secondo Kundnani, l’unica vera alternativa al jihadismo è rappresentata da una politica anti-razzista, anti-imperialista e anti-capitalista.
Il mondo intero è adesso una zona di guerra? E come si relaziona questa idea con la retorica della guerra al terrore?
La promessa della guerra al terrore era che noi saremmo andati ad ammazzarli “laggiù” così che loro non ci avrebbero ucciso “quaggiù”: la violenza di massa in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Yemen e Somalia – è stata compiuta in nome della pace in Occidente. “L’autorizzazione a utilizzare la forza militare”, approvata dal Parlamento americano dopo l’undici settembre, aveva già identificato nell’intero globo il campo di battaglia per la guerra al terrore; e Obama continua a farsi forte di ciò per conferire una parvenza di legalità al suo programma di uccisione tramite droni. E questa non è altro che l’antica formula coloniale in cui i valori liberali della madrepatria si sostengono sull’autoritarismo celato nelle periferie – dove le esecuzioni extragiudiziali sono una routine normalizzata.
Sappiamo tutti che la guerra al terrorismo miete più vittime civili di quanto non faccia il terrorismo stesso, ma lo tolleriamo in quanto ad essere uccisi sono i “loro” civili in posti che ci sembrano molto lontani da noi. Eppure la storia coloniale ci insegna che la violenza, sotto varie sembianze, ritorna sempre a casa: che sia in forma di rifugiati che cercano riparo, oppure tramite la reintroduzione di pratiche autoritarie proprie dei contesti coloniali, o ancora nelle vesti, appunto, di terrorismo. Gli stessi schemi si ripetono oggi sotto nuove forme.
Per i cittadini musulmani che vivono in Occidente, queste dinamiche comportano un fardello enorme: essi sono ridotti all’etichetta di moderati o estremisti, musulmani buoni o cattivi. La domanda che aleggia su di loro chiede se si separeranno da tutto ciò che li lega alle zone teatro di violenza o se canalizzeranno quella violenza all’interno dell’Occidente. Questa domanda però non viene posta in maniera diretta, e anzi si insinua tra le maglie della questione culturale: “accetti i valori occidentali?”
Questa impostazione influenza inesorabilmente l’espressione pubblica musulmana, poiché rende sospetto chiunque rifiuti di sottoporsi a rituali di lealtà verso la cultura occidentale. Nel frattempo, l’ISIS pone questi musulmani in una zona grigia tra l’imperialismo occidentale e la riaffermazione del califfato.
Ne consegue, da ambo le parti, un intensificarsi dei discorsi che incitano alla militarizzazione: i jihadisti si fanno forti dei discorsi dei leader occidentali per ribadire l’esistenza di una guerra contro l’Islam, e i leader occidentali legittimano la guerra parlando di “lotta generazionale” tra i valori occidentali e l’estremismo islamico. Ciò che sorprende oggi è che la retorica logora dell’aggressione militare – la “guerra spietata” di Holland – viene riciclata ancora una volta, nonostante gli evidenti fallimenti degli ultimi quattordici anni.
Da dove provenivano gli attentatori di Parigi? Le teorie del radicalismo possono spiegare ciò che li ha spinti?
Nel loro tentativo di comprendere la violenza jihadista, le teorie del radicalismo sviluppate da esperti, agenzie di intelligence e accademici collegati all’apparato di sicurezza nazionale tendono a partire da presupposti sbagliati. Innanzitutto, danno per scontata una profonda differenza tra la violenza di matrice islamica e quella propria di altre forze politiche: la storia della violenza politica nel ventesimo secolo, specialmente nei contesti coloniali, viene perciò dimenticata in partenza e la lezione che ci ha impartito ignorata. In seconda istanza, ritengono che il fattore chiave che spinge alcune persone a diventare terroristi sia una qualche forma di ideologia religiosa islamica; alcuni analisti concedono che anche il cosiddetto “torto percepito”, o delle crisi emotive, possano essere fattori scatenanti; ma è in ogni caso l’ideologia ad essere considerata la causa principale del terrorismo.
Tuttavia le evidenze empiriche non supportano nessuno dei due assunti – lo testimoniano i volontari europei arruolatisi nell’ISIS e arrivati in Siria con in mano copie de L’Islam per tonti (Islam for dummies), o la presunta mente degli attacchi parigini, Abdelhamid Abaaoud, che è stato visto bere whisky e fare uso di cannabis.
Eppure le teorie sul radicalismo sono ufficialmente accettate e divulgate, perché forniscono una base logica da cui partire per organizzare lo stato di polizia (per le forze dell’ordine e le agenzie di intelligence è più facile scovare ideologi che terroristi) e perché negano, in maniera conveniente, il ciclo di violenza in cui siamo entrati.
Ciò che le teorie sull’estremismo ignorano è che la violenza nella guerra al terrore è bilaterale: se i neo volontari dell’ISIS sono disposti ad usare la violenza, così lo sono anche i nostri stessi governi. Ci piace pensare che la nostra sia una violenza difensiva, normale e razionale, mentre la loro sia fanatica, aggressiva e anomala. Eppure anche noi bombardiamo giornalisti, bambini e ospedali. Un’analisi completa dell’estremismo deve tenere in conto del fatto che anche noi ci spingiamo verso di esso, giacché siamo sempre più disposti a utilizzare la violenza in una gamma di contesti sempre più ampia – dalla tortura, agli attacchi con droni, alle guerre per procura.
Ciò che spinge le nuove reclute verso l’ISIS non è tanto l’ideologia religiosa, quanto l’immagine di una guerra tra l’Occidente e l’Islam. È un cliché che racconta di due identità monolitiche impegnate in una battaglia globale: la verità e la giustizia da una parte; la menzogna, la depravazione e la corruzione dall’altra.
Queste reclute non sono corrotte da un’ideologia, ma dalla fine dell’ideologia: sono cresciute nell’era della “Fine della Storia” di Francis Fukuyama, della mancanza di alternative alla globalizzazione capitalista. Non conoscono la critica, ma solo teorie del complotto, e sono mossi da un sentimento apocalittico piuttosto che dalla lotta popolare. Ciononostante, per la mancanza di reali contenuti politici, la retorica della guerra globale contro l’Occidente suona ai suoi adepti come una risposta alla violenza dovuta al razzismo, alla povertà e all’impero.
Come di può descrivere la reazione ai fatti di Parigi da parte degli intellettuali occidentali?
Nel mio libro The Muslims are Coming! ho sottolineato che tra i politici, gli studiosi e gli ideologi della guerra al terrore, si sono fatti strada due ampi approcci volti a spiegare l’estremismo islamico: c’è quello conservatore che giudica la cultura islamica come intrinsecamente violenta e definita essenzialmente dai suoi testi fondamentali, e quello liberale che sostiene come il nemico sia una distorsione totalitaria dell’Islam, emersa nel ventesimo secolo.
A un livello più profondo, questi modi di pensare operano insieme con implicita solidarietà, dando vita a un discorso flessibile sul “problema musulmano” che è adattabile a ogni situazione.
La reazione intellettuale agli attacchi di Parigi ha seguito questi schemi. La caratteristica dominante è una vanagloria che descrive l’ISIS come il polo opposto a qualunque nostro valore: per i liberali l’ISIS è intolleranza, razzismo e oppressione della donna; per i conservatori è il nemico ideale, fanatico, non occidentale e barbaro. In questo modo, l’ISIS è ridotto a essere “l’altro” assoluto, che ci permette di costruire un’immagine positiva di noi stessi.
Il video, divenuto virale, in cui il comico John Oliver denuncia l’ISIS dopo gli attacchi di Parigi è in questo senso significativo. Nelle sue parole, i jihadisti non hanno alcuna possibilità in una battaglia culturale contro la Francia. “Porta pure la tua ideologia fallimentare. Loro porteranno Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, il vino pregiato, Camus e il camembert”. Eppure è stato proprio Sartre a capire che ragionare in termini binari sull’identità culturale serve a mascherare i nessi causali che legano la civilizzazione alla barbarie. “Non c’è niente di più coerente di un umanesimo razzista” scriveva, “in quanto l’uomo europeo è potuto diventare tale solo attraverso la creazione di schiavi e mostri”.
Ciò significa che il modo più appropriato di rispondere all’ISIS è quello di considerarlo un sintomo del “normale” funzionamento del sistema globale moderno, piuttosto che un elemento estraneo che corrompe il sistema dall’esterno, o che nasce da un passato pre-moderno. L’ uso dei social media, il rifiuto dei confini nazionali del ventesimo secolo, così come la forte connessione con l’economia petrolifera, tutti questi elementi dimostrano che l’ISIS è figlio della globalizzazione.
L’ISIS è certamente un mostro, ma un mostro che noi stessi abbiamo creato. È nato nel caos e nella carneficina conseguente l’invasione dell’Iraq del 2003. La sua ideologia settaria e i suoi finanziamenti provengono dalle élite regnanti in Arabia Saudita e nel Golfo, gli stessi che nella regione sono i più stretti alleati dell’Occidente dopo Israele. Anche la Russia e l’Iran hanno giocato un importante ruolo sostenendo il regime di Bashar al-Assad – responsabile di molte più morti civili rispetto all’ISIS – e prolungando così quella guerra in Siria che permette all’ISIS di prosperare. Al tempo stesso, i gruppi che si sono rivelati più efficaci nella lotta all’ISIS, ossia le milizie curde, sono considerati terroristi dai governi occidentali – perché rappresentano una minaccia per la Turchia, nostro alleato.
Quale dovrebbe essere la risposta più appropriata da parte dell’Europa?
Ovviamente l’ideologia e le pratiche di governo dell’ISIS devono essere messe in risalto e denunciate ad ogni opportunità – per l’oppressione della donna, per la messa in schiavitù dei minori, per l’odio della libertà e così via. Ma fare ciò partendo dalla presa di posizione di un conflitto globale tra i valori liberali e l’estremismo islamico, porta solo al vicolo cieco di una politica identitaria militarizzata.
Non dobbiamo lasciarci intimidire al punto di smettere di criticare i palesi doppi standard e le contraddizioni della guerra al terrore. Ma questo non è sufficiente. La sinistra dovrebbe mostrarsi più audace e affermare che solo una politica anti-razzista, anti-imperialista e anti-capitalista può rappresentare una valida alternativa al jihadismo; che un maggiore radicalismo, nel senso genuino della parola, è la soluzione e non il problema; che il terrorismo sguazza in ambienti dove i movimenti di massa che inneggiano al progresso sociale sono stati sconfitti.
Walter Benjamin affermava che dietro ogni fascismo c’è una rivoluzione fallita. Lo stesso è vero per il terrorismo: l’ISIS esiste perché le rivoluzioni arabe del 2011 hanno fallito.
Dobbiamo perciò difendere gli spazi della politica radicale, in nome del diritto a sognare un mondo differente. Le strategie anti-terrorismo, e in particolare le politiche anti-radicalismo, come il programma di prevenzione britannico, erodono questi spazi. Dobbiamo inoltre porre fine ai bombardamenti aerei, che intensificano soltanto il ciclo di violenza e danno credito all’ISIS quando parla di una guerra dell’Occidente contro l’Islam; e smettere di sostenere i regimi che hanno permesso all’ISIS di crescere – specialmente l’élite saudita, che rappresenta l’influenza più reazionaria della regione.
Infine, i rifugiati devono essere difesi, non solo in quanto vittime, ma perché portano con sé la consapevolezza dei nostri fallimenti passati. Dobbiamo permettere loro di insegnarci chi siamo.
* Questo è un pezzo apparso su OpenDemocracy, tradotto da Margherita D’Arnaldo e Carlo Boccaccino e ripubblicato da abbattoimuri