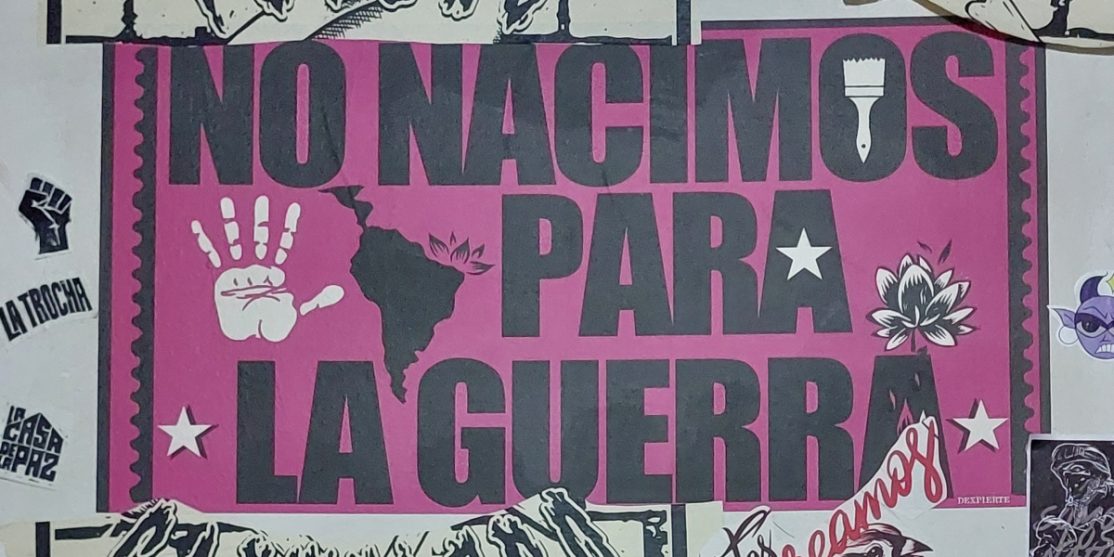La Tribù delle Formiche
Formiche, precari e sogno cinese.
È dal 2009 che in Cina si discute della “tribù delle formiche”: in quell’anno infatti è apparso il primo reportage sul tema, scritto dal giovanissimo sociologo Lian Si, allora appena ventinovenne, e dalla sua équipe di ricercatori. Il libro divenne immediatamente un bestseller, con 10 ristampe soltanto nel 2009, mentre nel 2010 il termine yizu (tribù delle formiche, appunto) fu inserito fra le «dieci parole dell’anno». Ma di che “tribù” si tratta? Secondo Lian Si, si definiscono “formiche” i giovani laureati fra i 22 ed i 30 anni, dotati di un alto grado di istruzione e di un reddito mediocre, che vivono in comunità nelle periferie delle grandi metropoli cinesi.
Nei sobborghi di Pechino, Shanghai o Chongqing, lì dove la città e la campagna si fondono in unico paesaggio lunare, un posto letto costa appena 400 rmb al mese (50 euro ca.); la struttura del quartiere in un certo modo replica quella del dormitorio del college, in cui questi ex-studenti universitari hanno trascorso almeno quattro anni della loro vita. La protratta condivisione degli spazi e la vita gregaria, tuttavia, non sempre generano un senso di appartenenza allo stesso gruppo sociale. Ognuno di loro sta cercando lavoro, oppure cerca di resistere nel posto di lavoro che ha già trovato. C’è chi fa il cameriere e chi vive attaccato alla cornetta di un call center; la ragazza che al supermercato ci strattona per la manica, insistendo per farci provare un tè dimagrante al ginseng o una nuova marca di patatine al gusto di arrosto di maiale, potrebbe essere laureata in inglese o in economia e commercio. Anche il ragazzo che con gentilezza e un certo impaccio ci illustra tutte le funzioni dell’ultimo modello di iPhone è forse istruito quanto o più di noi. In media guadagnano appena 2.000 rmb al mese (250 euro, al cambio attuale), ossia poco più di un terzo dello stipendio mensile minimo della nuova middle class urbana, il quale ormai rasenta i 6.000 rmb, secondo i dati del 2010 diramati dall’Accademia delle Scienze Sociali. Un contadino migrante che si reca in città a lavorare, spesso in nero, come operaio edile può ottenere una retribuzione migliore rispetto a una “formica”. Inoltre, raramente l’impiego trovato da questi neolaureati è fisso. Cercano lavoro, lo trovano, lo perdono, lo cambiano di continuo. E allora, sono precari anche loro, esattamente come lo siamo noi?
Sì e no. Sì, nel senso che la loro condizione materiale ed esistenziale per molti versi è il portato di una tendenza globale, e non solo cinese. Tornerò su questo punto. D’altro canto però, se Lian Si ha coniato il termine di tribù delle formiche, anziché ricorrere al concetto più internazionale di precario, una ragione ci dev’essere: le alacri e minuscole formiche, «forti della loro debolezzaı, da un lato infatti appartengono a un mondo che ci è noto (direi sin troppo), dall’altro fa da sfondo alle loro vicende la storia singolare della Cina di oggi e di ieri, dalla fine degli anni ’90 in poi. Intanto, va tenuto presente il dato anagrafico: le “formiche” sono nate negli anni ’80 e ’90, sono quindi figli unici e sono i figli del denghismo e dell’era di Riforma e Apertura (gaige kaifang), inaugurata nel ’78. Quasi mai nascono nei grandi centri urbani ove poi compiono gli studi: di solito provengono dalle zone rurali o dalle città di seconda e terza fascia delle regioni dell’entroterra. Per aspera ad astra, seguendo l’esempio millenario dei letterati della Cina tradizionale, hanno visto nella dedizione allo studio la loro unica speranza di riscatto sociale; come scrive Lian Si citando un’espressione classica, il dotto di umili origini, tramite il sistema degli esami imperiali (keju), poteva accedere al mandarinato, facendo come «il pesciolino che varca le porte del dragone». Perciò, la tanto sospirata lettera d’ammissione all’università, quando finalmente arriva, viene accolta come il coronamento di un sogno perseguito per anni, non solo dalla futura “formica”, ma pure dalla sua famiglia. L’approdo nella grande città rappresenta un salto di livello e di conseguenza questi giovani non vogliono più andarsene, nemmeno dopo la laurea: a Pechino, a Shanghai, si dice che «tutto è possibile» e «si sente battere il cuore del mondo».

In un articolo scritto ad hoc per i lettori italiani, che uscirà questo aprile sulla rivista «Equilibri», Lian Si scrive:
«Hanno deciso di stabilirsi in questa grande città, ma il fatto di trovarsi qui è appena un inizio. L’evolversi dei processi richiede tempo e i risultati sono imprevedibili: non possono far altro che assecondare il destino, benché siano in lotta con esso.
Ci sono tanti modi per definire il destino: “opportunità”, “fortuna”, “volontà del Cielo. Il destino però ha anche un altro nome: si chiama “epoca”.
Il padre della letteratura cinese moderna, Lu Xun, ha scritto che la speranza può trovarsi ovunque, ma allo stesso tempo non sta in alcun luogo; essa è come il solco di una strada: in origine non c’è nulla sul terreno, però se molti uomini vi camminano sopra, ecco che allora si forma un sentiero.
Già tantissimi studenti neolaureati hanno calcato le strade dei quartieri di periferia. Sebbene questi luoghi facciano pur sempre parte di Pechino, la capitale della Cina, e sebbene non distino poi molto dalla cittadella universitaria, sono tuttavia privi delle necessarie infrastrutture, la sicurezza è carente e l’ambiente è insalubre. Chi ci abita si alza all’alba e rincasa al tramonto, di giorno si reca al lavoro oppure va a cercare un lavoro. Trovare un’occupazione è arduo e il salario lascia comunque a desiderare».
Potrebbero tornare dalle loro famiglie, trovando magari un posto di lavoro stabile nella propria città natale, e invece decidono di restare; anzi, in molti casi sanno che la via del ritorno gli è interdetta.
La ormai trentenne Yang Shanshan, ad esempio, è una veterana di Xiaoyuehe, uno dei quartieri di Pechino ove risiedono circa 50.000 “formiche” e ove il sociologo Lian Si ha iniziato la sua inchiesta. Oggi è impiegata presso una piccola ditta privata che le passa 1.200 rmb al mese, uno stipendio misero se rapportato al costo della vita nella capitale. Al telefono col padre le capita di scoppiare in lacrime, dice di voler ritornare al suo villaggio nello Hunan, ma il padre non glielo permette, perché ai suoi occhi il fatto stesso di vivere a Pechino rappresenta il massimo successo ottenuto da sua figlia: lì e soltanto lì lei può godere degli agi della “modernità” e poi chissà, forse un giorno sposerà un uomo con una posizione, non un contadino. Viceversa, i genitori di Deng Kun lo attendono a casa per la Festa di Primavera (il Capodanno cinese), però lui non ha il coraggio di tornare dai suoi a mani vuote e di dover confessare di essere ancora disoccupato, poiché significherebbe «perdere la faccia» (mianzi), che per un cinese ha un valore inestimabile.
Con ogni evidenza, Yang Shanshan e Deng Kun, così come molti dei loro coetanei freschi di laurea e sottoccupati, hanno acquistato un biglietto di sola andata per Pechino, Shanghai o Canton; hanno viaggiato sullo stesso convoglio che ogni giorno trasporta migliaia di braccianti, i quali una volta arrivati in città finiscono a lavorare nei cantieri edili: da questo punto di vista un unico destino accomuna i giovani letterati poveri e la popolazione migrante. Il sociologo Lian Si opera un netto distinguo fra le “formiche” e i nongmingong, i migranti, i paria del miracolo cinese, che il ceto medio urbano disprezza in quanto contadini bifolchi (il mantra che invariabilmente li contrassegna è tamen de suzhi hen di, «hanno un infimo spessore umano e culturale»), anche se paradossalmente sono proprio loro ad aver edificato, mattone dopo mattone e lavorando giorno e notte, le ipermoderne architetture delle megalopoli cinesi. Benché Lian Si non scivoli nel trito luogo comune sullo “spessore umano”, comunque evidenzia lo scarto culturale fra nongmingong e “formiche”, il quale indubbiamente sussiste: difatti, è raro che un migrante abbia avuto la possibilità di andare all’università. Sussiste pure un evidente scarto numerico: i giovani neolaureati, ormai presenti in ogni grande e medio centro urbano, si distribuiscono in “tribù” da 100 o 150.000 unità e vivono in quartieri da 40 o 50.000 persone, per un totale di circa 3 milioni di individui, mentre l’esercito salariale di riserva proveniente dalle zone rurali ammonta a quasi 253 milioni di persone, stando alle stime 2011 dell’Ufficio Nazionale di Statistica. Ciò detto, malgrado le vistose disparità di status e di numero, mi pare che non vari molto l’esodo, materiale e simbolico, da ovest a est, dalle campagne alle città e dalla povertà reale al sogno della conquista del benessere – un sogno che in genere non si avvera, se non in pochi casi o parzialmente.
Lo chiamano il Chinese dream, però andando all’osso, nella sua struttura profonda, ha poco o nulla di specificamente cinese, almeno a mio avviso. E qui riprendo il punto che sinora ho lasciato in sospeso, ossia la comunanza fra la condizione di “formica” e la nostra di precari nell’era del finanzcapitalismo.

Nel 1999 il governo della Repubblica Popolare ha varato la manovra di «ampliamento delle ammissioni all’università» (daxue kuozhao): si è rimosso il numero chiuso o meglio se ne è alzata la soglia, provocando un incremento esponenziale delle lauree sin dal 2003, anno in cui è uscita dal college la prima leva di giovani ammessi grazie a questa riforma. Se ancora nel 2004 hanno conseguito il titolo meno di 3 milioni di studenti, appena cinque anni dopo, nel 2009, il loro numero sale a più di 6 milioni e mezzo, ben più del doppio. La manovra è stata pensata per facilitare l’accesso agli elitari istituti universitari e democratizzare l’istruzione superiore, ma non ha tenuto sufficientemente conto di una questione fondamentale: la società è in grado di assorbire tutti quei laureati? Oggi non a caso gli apparati di governo e l’università stessa consigliano agli studenti di non ambire a chissà quale stipendio e di non scartare a priori le posizioni lavorative di basso livello (in una parola: non siate choosy!). Al contempo però si proclama che l’espansione del ceto medio cinese, favorita dalla crescita economica, avanza al ritmo serrato dell’1% annuo – il che tradotto in soldoni significa: «c’è posto anche per te (forse) nel grande sogno della Cina».
Per quel che ne capisco e per quanto possa contare il mio parere, difendo a spada tratta la manovra del ’99, che ha spalancato i cancelli dei campus a tanti che potevano continuare a restarne fuori, quando invece hanno il pieno diritto di entrare. Nondimeno, vanno rilevate le sue intrinseche contraddizioni. La suddetta manovra, così come il passaggio all’istruzione di massa in genere, in Cina, in Europa o in Italia, non piove dal cielo né è avulsa dal contesto in cui avviene. Se il contesto più ampio è quello di una società di mercato – o di una economia di piano che un trentennio di riforme ha trasformato in un’economia di mercato, come nel caso cinese – l’apertura delle università non può che rispondere alle esigenze di questo tipo di società e dunque la democratizzazione della scuola facilmente si mescolerà con il processo di mercatizzazione, sino a confondersi del tutto con questo. So che coi lettori di questo sito sfondo una porta aperta e molto probabilmente non vi sto dicendo nulla che non sappiate già da un pezzo, tuttavia la comparazione con l’Asia magari può tornare utile. La spina dorsale delle società di mercato sono i ceti medi, dotati di un certo grado di competenze e di capacità di consumo, i quali oggi vengono spinti a nutrirsi più di informazione e alta tecnologia che di pane e riso; dal punto di vista degli apparati ideologici di stato, tutti veniamo interpellati a far parte di questa frangia benestante e residente in città. Tutti ci dovremo disciogliere in questo continuum di comfort, high tech e lavoro specializzato, senza più distinzioni di genere, età e classe. D’altra parte però la crescita non è infinita e l’espansione della middle class, idealmente illimitata e ideologicamente necessaria, ha dei confini persino fisici. Pochi giorni fa, l’indice che rileva la concentrazione di polveri sottili (PM10) nell’aria di Pechino era schizzato a 895 (da noi in Italia si entra in allarme se solo sfiora i 100). Immaginiamo cosa accadrebbe se domattina quei 3 milioni di “formiche”, insieme a quegli altri 253 milioni di migranti, si recassero al lavoro in macchina. È solo un esempio fra i molti che si possono fare a proposito delle falle del presente modello di sviluppo, sì e no sostenibile quando si tratta di paesini di taglia minima, tipo Singapore, ma che produce contraddizioni a valanga non appena si passa a nazioni di taglia forte, come l’India o la Cina. Il benessere insomma non è per tutti, come dimostra l’attuale coefficiente di Gini cinese, pari o superiore a quello statunitense: le prime due potenze mondiali soffrono di una polarizzazione sociale che difficilmente può passare per un semplice effetto collaterale ed è infatti connaturata al sistema e alla finitudine del pianeta (vedasi ad esempio l’illuminante articolo di Angela Pascucci).

Tutto ciò ci riguarda da vicino, perché, fatte le debite proporzioni, non siamo affatto immuni alle falle testé descritte; da un lato infatti, ci vengono richiesti una laurea, un master, la padronanza di almeno una lingua straniera e possibilmente un’esperienza all’estero, dall’altro «beh, ti accontenti poi di quel che trovi», dal momento che il nostro ceto medio avvizzisce e da sé come per magia si estingue, più velocemente di quanto accada allo Stato dopo l’avvento del socialismo, secondo la buona vecchia vulgata marxista.
C’è poi un altro aspetto che merita di essere analizzato non solo dal punto di vista cinese, ma anche da una prospettiva più globale: il viaggio delle “formiche” dal loro natio borgo selvaggio verso i grandi centri urbani della costa avviene non soltanto nello spazio, ma in un certo senso anche nel tempo: se inscritto nella cornice della storia lineare e progressiva che ci viene inculcata sin dalle elementari, quell’esodo riproduce su scala ridotta il passaggio d’una più vasta umanità dalla società tradizionale a quella moderna, o dalle tenebre del Medioevo ai Lumi, o ancora dei regimi dispotici alla democrazia. La città è quindi l’approdo ultimo e obbligato. Lo sviluppo è l’unico sogno possibile, Dio parla attraverso la storia mondiale di Hegel. Non vorrei essere fraintesa: non intendo criticare le “formiche” perché sognano il benessere o perché pensano che la vita nelle metropoli costiere sia il massimo a cui ambire: chi scrive ha abbandonato ormai dieci anni fa la dolce provincia italica per trasferirsi a Pechino e perciò fa un po’ fatica a emettere algidi giudizi calati dall’alto. Tuttavia mi chiedo se quel treno su cui salgono non potrebbe portarle (e portarci) altrove, se la “modernità” – uno splendido concetto, inattaccabile nella sua neutralità perfetta – sia davvero tutto ciò che ci è dato e se le diseguaglianze che essa comporta debbano essere accettate con stoica rassegnazione e freddo cinismo, magari invocando le solite retoriche del merito («non siamo tutti uguali e se sei un fallito è colpa tua»). A scanso di equivoci: non si tratta nemmeno di idealizzare la vita agreste e le antiche tradizioni, nella fattispecie quelle della società patriarcale confuciana, coi suoi piedi fasciati, i matrimoni combinati, l’indifferenza dei mariti e la crudeltà delle suocere: non esiste alcuna età aurorale e incontaminata a cui tornare e inoltre il rimpianto degli “antichi tempi” è sempre un po’ destro e fascistoide. Al contrario, dico che andrebbe messa in discussione la “tenebra feudale” che si annida nel nostro presente e lo rende tanto più “moderno” e confortevole (ma solo per pochi).
Ma sto ampliando troppo l’orizzonte e da questa prospettiva globale rischiamo di non scorgere più le piccole “formiche”, che pur essendo gli insetti più intelligenti e dotati di know how, sono anche i più minuti e invisibili. È con la storia di uno di loro che vorrei chiudere il mio tentativo di analisi: è sempre scritta da Lian Si e viene riportata all’interno del testo che comparirà su «Equilibri»:
«Negli stessi giorni ma in un altro luogo, io e la “formica” Song Yongliang stavamo festeggiando insieme il Capodanno. Lui è nato nel 1983 e nel 2008 si è laureato in russo all’università di Heihe nello Heilongjiang, una scuola simile a molte altre in Cina. Quando ci siamo conosciuti, lui aveva già vissuto in cinque città diverse cambiando lavoro per ben sette volte, prima di trasferirsi in pianta stabile a Pechino. La notte della vigilia, io e Yongliang eravamo seduti l’uno di fronte all’altro, davanti a una bella tavola imbandita, mentre si udivano gli scoppi assordanti dei petardi fuori in strada. Ho chiesto a Yongliang di esprimere un desiderio per l’anno nuovo: lui ha chinato il capo senza dire nulla per un po’, lasciandomi intendere che stava pensando al suo desiderio più grande. Poi ha alzato la testa, mi ha guardato dritto negli occhi e dopo un istante ha soggiunto: “Nell’anno nuovo, la mattina vorrei potermi alzare vedendo la luce del sole”. In un anno trascorso a Pechino, lui e la sua ragazza avevano sempre abitato in una stanzetta di 10 metri quadri scarsi in un seminterrato: nella capitale della seconda economia mondiale, la luce del sole può diventare la massima aspirazione di un giovane”.
Per chi fosse interessato ad approfondire il tema, segnaliamo, oltre il succitato articolo, il libro di Paolo Do, forse il massimo esperto italiano ed europeo di “formiche” cinesi, Il tallone del drago, DeriveApprodi, e il libro di Angela Pascucci, in uscita questo mese per le Edizioni dell’Asino, Oggi in Cina. Le «formiche» in cammino, in cui è contenuta un’intervista a Lian Si.