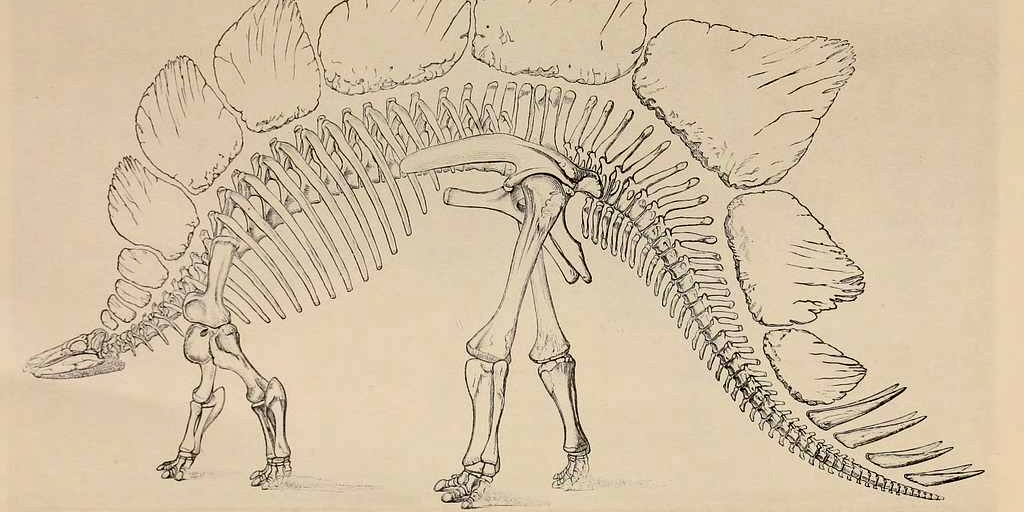ITALIA

«Far cadere la barriere dell’informazione». Intervista ad Anna Pizzo
Il mediattivismo a Genova nasce sull’onda lunga di esperienze politiche che si sviluppavano in quegli anni, come lo zapatismo, che ha rotto gli argini quando è esplosa la protesta di Seattle, nel ’99. Le scarpe dell’informazione tradizionale erano diventate troppo strette
Il movimento alterglobalista, da Seattle a Genova, si è caratterizzato per un utilizzo nuovo della comunicazione e per la nascita di molti media indipendenti. Carta nasce esattamente in quel periodo e rappresenta una sorta di ponte tra una tradizione, a sua volta eretica, di giornalismo di sinistra e una modalità di informazione indipendente e diffusa. Anna Pizzo, tra i fondatori di quell’esperienza, ci racconta la genesi di Carta e il modo in cui si è inserita nel panorama mediatico e politico “in subbuglio” di allora.
Da dove nasce l’esigenza di dare vita a un giornale di nuovo tipo?
“Se una radio è libera, ma libera veramente / piace ancor di più perché libera la mente», cantava Eugenio Finardi nel 1975. Ed è stato proprio così alla metà degli anni ’70, con la nascita e la diffusione delle radio libere, oltre che con i quotidiani dei movimenti nati dal ’68 (il manifesto, Lotta continua, Quotidiano dei lavoratori). Oltre 25 anni dopo, si trattò di comunicare liberamente, cioè fuori dai binari del profitto e della politica, per mezzo del web che aveva la stessa agilità delle radio ma una maggiore immediatezza e soprattutto l’interattività.
Cadevano le barriere tra informatore e informato, tutti potevano essere a un tempo l’una cosa e l’altra. L’esempio più radicale è stata senz’altro la rete di Indymedia, di cui parlerò a proposito di Genova. E, a suo modo, un altro buon esempio è stato “Carta”, nato come mensile cartaceo nel dicembre del ’98 (per alcuni mesi come supplemento del manifesto e poi in edicola autonomamente), diventato settimanale alla vigilia del G8 di Genova.
La testata rivelò subito le sue intenzioni: siamo un giornale, quindi siamo “carta”. Ma da subito saremo anche un sito e poi forse anche una radio e poi chissà. Questo ci dicevamo Gigi Sullo ed io un giorno d’estate sul traghetto che ci portava in Sardegna. Ma possiamo anche essere un ponte tra il meglio finora prodotto dalle diverse sinistre (comunista, ambientalista, sociale, femminista…) e qualcosa di nuovo che si respira nell’aria.
Un esempio, poco più di un aneddoto: poco prima delle giornate di Genova: io, che facevo parte del Genoa Social Forum e avevo l’incarico di coordinare il media center, chiesi al Manifesto, che avevamo da un paio d’anni lasciato dopo oltre un ventennio di “onorata carriera”, se voleva avere lì una propria postazione. Mi risposero di no perché i giornalisti sono coloro che riferiscono i fatti e non “militanti” e men che meno “mediattivisti”. Eppure il nostro scopo dichiarato, nel fare Carta, era proprio quello di fare da cerniera tra la sinistra tradizionale e i nuovi movimenti.
Ecco perché Carta non poteva più stare dentro quel paio di scarpe strette, per belle che fossero. Ed ecco perché è riuscita a nascere grazie ad alcune onde lunghe sulle quali ha fatto il surf per lungo tempo: è volata sull’onda dello zapatismo andando per anni dentro la foresta Lacandona, parlando, domandando, camminando. E ha rotto gli argini quando è esplosa la protesta di Seattle, nel ’99, perché quei ragazzi vestiti da carote e ravanelli erano riusciti a svelare, con immediatezza e semplicità, una cosa complicata e mostruosa: gli effetti devastanti del neoliberismo.
Pochi mesi prima, sempre nel ’98, c’erano stati, in Italia, due segnali, forse poco appariscenti, ma destinati a costruire nuova consapevolezza diffusa: a Trieste contro la nascita del primo centro di detenzione per migranti e a Genova contro la decisione della commissione europea di autorizzare la Monsanto Europe a immettere in commercio mais ogm Mon810. E poi ancora le proteste additate come egoismi localistici (una per tutte, la battaglia dei No Tav) e ancora il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, gennaio 2001, che riuscì a imporre agli 8 “grandi” della terra lo sguardo “dal basso” dove le cose migliori nascono senza che quelli che guardano tutto solo dall’alto se ne accorgano.

(foto di Gabrio Mucchi)
Quali sono le caratteristiche di discontinuità di Carta e degli altri media indipendenti?
La prima discontinuità è proprio nel rovesciare lo sguardo e accorgersi, come scrive Arundhati Roy, delle piccole cose. La seconda è nell’abbattere le liturgie di un mestiere, quello del giornalista, che sarebbe molto bello se troppo spesso non fosse in vendita al miglior offerente. Una delle più odiose liturgie è la “proprietà” della notizia, la indisponibilità a condividerla, la fame dello scoop che tanti danni ha prodotto e continuerà a produrre. A Genova noi di Carta condividevamo un piano, diverse aule, della scuola Pertini, sede del media center, con il quotidiano Liberazione e alcuni settimanali online, e non c’era notizia che non diventasse oggetto di discussione e di verifica, come la morte di “un giovane spagnolo” in Piazza Alimonda, che poi era Carlo Giuliani. Perché, come diceva qualcuno inascoltato, “l’unione fa la forza”. E noi, per qualche anno, di forza ne abbiamo avuta molta.
La terza discontinuità consiste nel non avere nessuna certezza, se non la responsabilità nei confronti del nostro giornale: tutto va messo a verifica e tutto può cambiare. Ad esempio ci applicammo a usare un linguaggio che non fosse quello stereotipo di sinistra, per non dare nulla per scontato, perché i nostri lettori erano molto spesso giovani, un’altra generazione, e i nuovi discorsi (la difesa dell’acqua e della terra, ad esempio) dovevano essere espressi con un nuovo vocabolario.
La quarta è non aver avuto padroni e, con il senno di poi ora posso dirlo, il nostro errore è stato aver voluto entrare a far parte del circuito dei giornali “assistiti” dal governo (legge per l’editoria), non capendo che anche quello era un padrone e che il rischio mortale era di finire per fare il giornale per avere quei finanziamenti, e non viceversa. È stato forse necessario ma è stato sbagliato perché ha intaccato la nostra natura errante fatta di centinaia, migliaia di persone, che con il loro contributo (e con le nostre liquidazioni) ci hanno permesso di nascere: raccogliemmo, solo per partire, cinquecento contributi da mezzo milione (di lire, era il ’99). L’aver girato l’Italia in lungo e in largo per farci conoscere è stata la ricchezza di “Carta” la sua più autentica vocazione.
A Genova, come in tutti i controvertici e i Forum sociali, nascono i “media center”. Che ruolo ha avuto, nello specifico, il media center a Genova? E perché fu attaccato così duramente dalla polizia?
La provincia e il comune di Genova assegnarono al Genoa Social Forum, non senza una estenuante trattativa, due scuole, una di fonte all’altra: la Pertini e la Diaz. Nella prima si sarebbe installato il vero e proprio centro media, con i computer, anch’essi prestati dalle istituzioni, e con i banchi e le sedioline delle classi elementari dove siamo stati per giorni e giorni ridicolmente accartocciati.
la scuola Pertini ospitava al piano terra la sala stampa, improvvisate cabine di registrazione delle radio libere e una palestra/infermeria, che nei giorni dell’aggressione si riempì di persone insanguinate e ferite. Al primo piano le stanza di coordinamento per l’attività legale, sanitaria, e gli uffici di comunicazione del GSF. Al secondo Radio Gap e altre testate del movimento, come il mio giornale, Carta, o Liberazione, giornale di Rifondazione. Al terzo piano Indymedia. Durante tutta la settimana decine di mediattivisti, soprattutto di Indymedia, lavorarono per connettere la rete e costruire un apparato perfettamente funzionante.
Le postazioni per noi giornalisti del Genoa Social Forum erano assegnate con parsimonia ed equità: ciascuno aveva il proprio pass, anche se uscire dal media center con quel cartoncino appeso al collo voleva dire trasformarsi in bersaglio. Tutti i giornalisti avevano anche la responsabilità dei luoghi. Carta aveva preso parte, fin dal febbraio, alle riunioni preparatorie e quindi era abbastanza scontato che si assumesse una funzione di controllo. E poiché il patto che il Genoa Social Forum stabilì con le istituzioni genovesi prevedeva, tra l’altro, anche l’assunzione di responsabilità sui luoghi e i materiali che comune e provincia mettevano a disposizione, ci voleva qualcuno che garantisse che sarebbero stati resi così come venivano affidati. Firmai io.

(Foto tratta dal Libro Bianco sul G8 di Genova, 2002)
La scuola Diaz era il centro di coordinamento del Genoa Social Forum ed era adibito anche all’ospitalità. Una mattina, con i funzionari della provincia, facemmo il sopralluogo della Pertini e della Diaz, in via Cesare Battisti. Era il giugno 2001. Nella Diaz c’erano lavori di ristrutturazione, all’interno, perciò in uno stanzino trovammo picconi, martelli e pale. Chiesi se non sarebbe stato opportuno rimuoverli per evitare eventuali “fraintendimenti” nel caso qualcuno potesse pensare che a portarli eravamo stati noi. Mi risposero come se avessi detto una enormità: “Non si preoccupi, signora. Li chiudiamo bene in questo ripostiglio e le chiavi le teniamo noi”.
La notte del 21 luglio, un paio di ore dopo la “macelleria messicana” dentro la scuola, dove dormivano 93 persone, entrai anche io e andai subito a vedere se la porta dello sgabuzzino fosse ancora chiusa, e lo era. Dodici ore dopo, a mezzogiorno del 22 luglio, nel corso della conferenza stampa in questura, sul tavolo apparecchiato dai “responsabili dell’ordine pubblico” c’erano anche i picconi e i martelli della Diaz, mostrati come armi improprie (oltre che le due molotov portate lì dai poliziotti).
Ho raccontato questo episodio perché anche quello, come le centinaia di altre menzogne accumulate nel corso di quelle giornate, sono un esempio di comunicazione “deviata”, quella che da più parti hanno tentato di accreditare nel corso dei numerosi processi ai quali anche io ho preso parte in qualità di “testimone informata dei fatti”. Ma nessun processo c’è stato per l’omicidio di Carlo Giuliani perché il carabiniere ausiliario Mario Placanica, che venne indagato per omicidio, fu poi prosciolto dalla giustizia italiana e da quella europea avendo agito per “legittima difesa”.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale la famiglia Giuliani aveva fatto ricorso, ha accolto la ricostruzione italiana in merito ai fatti specifici della morte, ma ha criticato la gestione dei sistemi di sicurezza attorno al vertice. La stessa Corte ha infine assolto lo Stato Italiano con sentenza definitiva nel 2011. A venti anni dalla morte di Carlo, quello sulle cause del suo assassinio, come molti altri, resta un inganno senza risposta. Anzi, alcuni dei burattinai di allora siedono oggi ai vertici dei più importanti e imbarazzanti posti di potere.
Ma molti di questi inganni sono stati messi a nudo grazie soprattutto alle migliaia di persone che con telefonini, registratori, fotocamere, cineprese e soprattutto occhi e orecchie e si sono sparpagliati per Genova convinti di testimoniare la rivincita dei “6 miliardi” contro gli “8 Grandi della terra”, e invece hanno trovato solo violenza cieca e barbarie.
Tutto quello che hanno raccolto è finito nelle prove prodotte nei diversi tribunali dove si sono tenuti i processi e non solo. Molto di quel materiale ha dato luogo a un altro piccolo ma durevole atto simbolico: Il Libro Bianco del Genoa Social Forum. La straordinarietà del simbolico consiste nell’essere riusciti a far collaborare diverse testate giornalistiche per la produzione di un dossier che ancora oggi è possibile acquistare. L’Unità, il manifesto, Liberazione, Manifestolibri e Carta si sono uniti in un comune progetto: chi aveva documentazione l’ha messa a disposizione, chi era stato a Genova diventava testimone e, grazie alla paziente cucitura dell’allora amministratore dell’Unità, Giorgio Poidomani, un altro ibrido è uscito dal cilindro di fabbricatori di giornali piccoli ma piuttosto “pesanti” diventando “il” documento del Genoa Social Forum.
C’è da dire che di quella cinquina restano in vita solo il manifesto e Manifestolibri, segno che una concreta utopia, che avrebbe potuto rovesciare le carte della comunicazione, si è quasi del tutto chiusa. E c’è un altro fondamentale documento che va visto e rivisto: si tratta de La Trappola, il documentario fatto e prodotto dal Comitato Carlo Giuliani e curato da Bruno Luverà, allora inviato del Tg1. Utilizzando solo registrazioni di testimonianze ai processi e immagini scattate da chiunque, ha narrato quanto accadde in quei giorni, dei cosiddetti torti e delle ragioni che non è vero che “non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell’uno e dell’altra”, come scrive Alessandro Manzoni.
Quanto alla scuola Pertini, adibita a media center, venne devastata subito dopo la Diaz con un raid rapido e ben mirato ad alcuni obiettivi, in particolare alle stanze del Glf (Genoa Legal Forum), dove sfondarono anche i computer.
Una menzione a parte merita Indymedia e, in particolare, Blicero, autore del miracolo del cablaggio della Pertini. Personaggio inquieto e al tempo stesso ruvido, Blicero non faceva salire nessuno di noi al terzo piano perché quello era il regno di Indy. Di lui posso dire che, anche se non lo sa, è stato un vero amico perché ha dato senza chiedere.

(Foto tratta dal Libro Bianco sul G8 di Genova, 2002)
Come vedi lo stato di salute dell’informazione indipendente oggi?
Al momento, calma piatta. Ci siete voi di Dinamopress, ci sono altri media online molto ben fatti, alcuni dei quali vado a spulciare quasi quotidianamente, ma per il resto non ci sono gli ingredienti fondamentali di quella maionese né di una nuova pietanza: non c’è la curiosità, la generosità, l’intelligenza profonda, lo sguardo dal basso che scava dentro le cose né cooperazione, o c’è ben poco di tutto questo. Non c’è il conflitto. Non c’è la rivolta. Senza quegli ingredienti la maionese impazzisce.
Se invece mi chiedete se servirebbe oggi, con un anno e mezzo di pandemia alle spalle e con una polveriera in fermento in metà del mondo, la mia risposta è sì. Tanto che, sgomenti e travolti dalla diffusione della Covid-19 in Italia, nel febbraio del 2020, qualcuno cominciò a pensare che qualcosa dovevamo fare, che sarebbe stato necessario reagire.
Il 9 marzo il governo annuncia il lockdown che in italiano si traduce con confinamento. Da quel momento in poi i violini sui balconi, e le ragazze a giocare a tennis dalle terrazze, le musiche, le bellaciao, tutto sembrava dire che non ci saremmo rassegnati. Avevamo pensato a tutto, interpellato i nostri fraterni amici del mondo di qua e di quello di là, avevamo il progetto, perfino la testata. Ma in 69 giorni, da quel 9 marzo e fino al 18 maggio, è passata una gigantesca schiacciasassi che ha spento le voci, la musica, la voglia di reagire. E quella di inventare. Almeno finora.
Foto di copertina di Gabrio Mucchi