approfondimenti
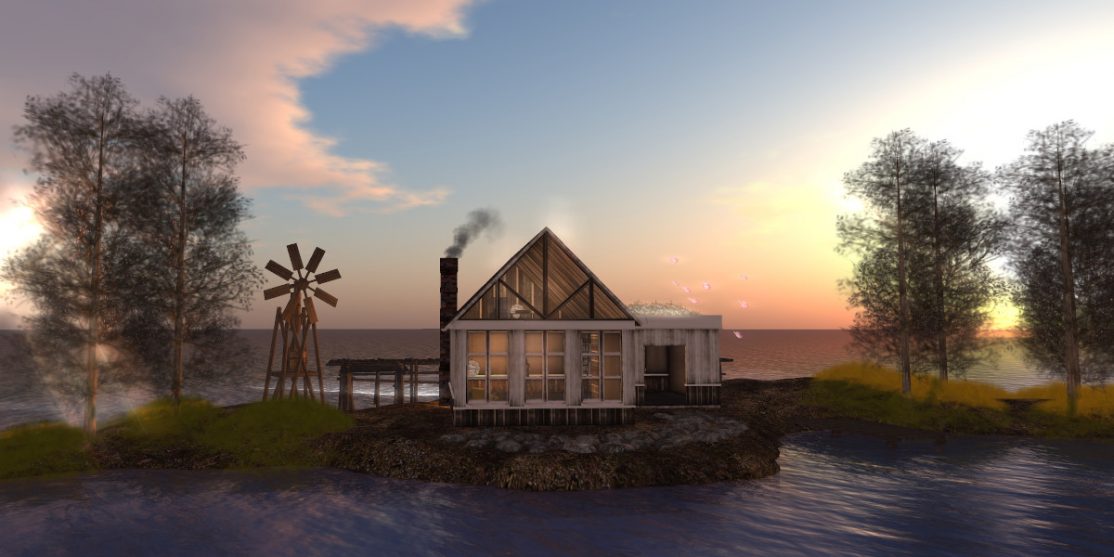
OPINIONI
Città e modernità: un crepuscolo solo supposto?
Estetizzazione della rendita versus politicizzazione del dimorare, in un intrigante testo di Emanuele Coccia sulla felicità domestica: forse, però, siamo di fronte a un’ennesima versione della fine della storia di stampo neo-liberale
Esistono le case, le città, gli alberi, il tempo e lo spazio fra gli oggetti di questo mondo e poi esistono case, città, alberi, tempo e spazio (non meno consistenti) nel mondo metafisico. I primi sono oggetto di esperienza ordinaria pubblica (Erfahrung), i secondi di esperienza vissuta privata (Erlebnis). Si ricavano idee interessanti dall’una e dall’altra sfera, basta intendersi e distinguere – l’intelletto comune si nutre di fantasmi immaginativi di entrambe le categorie.
Così, per esempio, finiscono per confluire in una comune Erfahrung tanto la nota alternativa effettuale tavoletta del water su/ giù che affligge ogni coppia eterosessuale quanto la considerazione metafisica che in ogni casa il bagno sia «l’espressione e l’incarnazione di una differenza irriducibile. Meglio di un desiderio ostinato di estraneità», il luogo dominato dai liquidi, dai flussi tossici da eliminare e da quelli rigenerativi, «l’unica stanza in cui è normale chiudersi a chiave, e anche l’unica in cui si corre sempre il rischio di rimanere chiusi» – così infatti sostiene (e concordiamo) Emanuele Coccia, Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità, Einaudi 2021, pp. 35-37), concludendo con afflato forse eccessivo che liberare il genere e le case dalla logica di reclusione del bagno è oggi più importante che liberarsi dal lavoro alienato (p. 40).
Niente da dire sulla mescolanza dei livelli argomentativi e narrativi – oltre tutto Coccia scrive molto meglio di un Baricco qualsiasi e alcune sue pagine sui terrori da corridoio e sui misteri della gemellarità sono davvero esemplari.
Nondimanco, qualcosa di fondo non convince in questo screziato caleidoscopio domestico, che pure in molti dettagli resta illuminante. Sarà vero che il nostro abitare nel mondo si realizza solo nella e attraverso la casa, mentre la forma-città, cui la filosofia finora si è legata, sta deperendo (e con la polis la politica) e il suo solo abitante integrale, il cittadino assoluto, è il clochard, il senza tetto, la vita vulnerabile? Coccia estende zia Margaret, secondo cui non esiste la società ma solo gli individui, sostenendo che la città è svuotata a favore delle case, che nelle case (e nei vestiti che ne sono “estrusioni mobili”, p. 51) si realizzano amore e felicità, mentre ricercarla nella città ci espone soltanto a un senso di colpa filosofico.

I mezzi di comunicazione di massa e i social hanno portato la sfera pubblica dentro le abitazioni facendo della vita psichica e della comunità «un romanzo collettivo a cielo aperto» (p. 84) e con lo smart working anche il lavoro si sgancia dalla dimensione urbana, desertifica i quartieri dei servizi e satura i domicili privati: non più città globali, ma si impone l’apertura degli appartamenti per farli coincidere con la Terra, farli diventare macchine psicomorfe e psicomimetiche.
Fare casa è dire io. Rovesciando Benjamin l’intérieur borghese cancella la dimora pubblica delle masse e ogni esperienza, privatizzata, prende i colori dell’Erlebnis, compresa la fondamentale pratica del risveglio, singolare, magari transindividuale, ma mai collettivo. Ritorniamo nelle stanze ovattate dell’asmatico Proust, da cui Benjamin aveva genialmente cercato di strappare i suoi contemporanei.
Ovvio che clochard, ospiti di campi nomadi e occupanti abusivi non siano entusiasti di questo rovesciamento – e forse neppure intellettuali esperti di traslochi al pari di Coccia, diciamo Balzac e Dostoevskij, troppo affezionati a luoghi di interscambio tipo Palais-Royal o piazza del Fieno. La vita materiale – e la sua rappresentazione letteraria – fuoriescono dalla casa e allo stesso tempo la configurano secondo vincoli esterni: la collocazione urbanistica, la classificazione catastale (parliamo di A2 non di castelli), la rendita fondiaria, il fuori del commercio, del gioco, dei trasporti e delle attività in relazione.
Già in Simmel l’impersonalità dei flussi è complementare al ritaglio di uno spazio interiore cinto dalle mura di casa ed espresso dal gusto della facciata e dai tratti dell’individualità eccentrica. Senza S-Bahn niente esperienza della solitudine, senza circolazione monetaria niente Rembrandt. È bastata la forzata reclusione da Covid-19 a invertire la tendenza? No, non credo. Al lockdown ha risposto l’assembramento, il contagio (nel bene e nel male) ha sfondato il perimetro dei muri domestici. Lo smart working ha ristrutturato parte della città ma non sostituisce affatto tutto il lavoro d’’ufficio, tanto meno la fabbrica e la logistica.
Sto in smart e non mi avveleno più con i ticket restaurant, ma viene il rider a casa a portarmi la pizza o il cartoccio cino-giapponese. Resta vero che «lo spazio si fa luogo» nella casa solo nella misura in cui essa resta rapportata a un esterno da cui si separa e con cui interagisce.
Non c’è home senza homeless – entrambi i termini vengono qualificati dalla struttura di classe della società e della città. Siamo tutti coinvolti, perfino (e tanto più) nel confinamento. L’idea – assai suggestiva e più sobriamente esplorata nella Trasparenza delle immagini e nella Vita delle piante – di una mescolanza con forme di vita non umana e perfino di agambeniana “vita qualunque” ha un senso diverso se lo spazio ritagliato nella casa – il “buco di incoerenza” nella struttura del pianeta, la sua area di extraterritorialità – è scaturigine di un agire o è semplice invaso per arredamento arboreo.

Una metafisica del Bosco Verticale, quale articolata nel capitolo Boschi e giardini, ricco di intuizioni mirabili, rischia di scivolare in una dimensione camp più che dandy e kitsch, trascinato dalla facile deriva dei progetti di Boeri sul piano dei mobili da cucina con albero di limoni incorporato, delle primule covidiche e dei borghi ritrovati. L’eguaglianza delle specie si realizza meglio nel pubblico dei parchi che nel costosissimo privato di Isola. Le grandi compensazioni borghesi ottocentesche offerte alle diseguaglianze di classe – Central Park o Buttes-Chaumont – conservano tuttora una traccia di quelle contraddizioni che ingannevolmente volevano occultare.
La bella immagine della cucina come «palestra della mescolanza, in cui le frontiere fra le cose e le persone sono sospese e l’opposizione fra umano e non umani viene capovolta in una fusione festosa» è tale dal punto di vista degli umani, del coltello e del frullatore, forse meno dal punto di vista delle carote, dei vitelli e dei maiali, senza di cui «è impossibile pensare le città» (p. 118).
Non sono vegetariano, ma provo a mettermi nell’altra posizione. L’assimilazione del diverso mediante conoscenza in analogia con il processo di nutrimento e digestione è già classico nella tradizione greca, ma sarebbe interessante vederlo dal punto di vista del cibo.
Nelle conclusioni (pp. 123 ss.) Coccia ribadisce che la casa «ha incluso così tanto mondo e così tanto “pianeta” da non lasciare più alcuno spazio residuo», cancellando ogni differenza fra locale e globale e segnando «la fine della modernità intesa come l’illusione di creare e produrre uno spazio alternativo alla casa […] trasformando la produzione di ricchezza in un affare pubblico, politico. Il ritorno del lavoro nella casa è solo uno dei primi sintomi della fine del moderno». Essere cosmopoliti oggi – si scrive con qualche esagerazione – significa che «i continenti e le nazioni sono stanze di un unico enorme appartamento», mentre svanisce la vita in città come «una festa a cielo aperto».
Ci troviamo, insomma in un’altra versione della “fine della storia” che il neoliberalismo rilancia dal 1989, secondo la non propria originale e alquanto comoda ipotesi che finora c’è stata storia e adesso non c’è più. Per neoliberalismo intendiamo qui la riproposizione di un concetto allargato della proprietà-lavoro del vecchio Locke, che già ai suoi tempi innovava radicalmente le categorie della proprietà antica e feudale.
La proprietà–smart working (e la casa in cui si concretizza) sussume «mescolanza delle classi, mescolanza delle identità, mescolanza dei popoli e mescolanza delle culture» – forse anche delle specie. Con un salto simile a quello in cui il diritto romano è stato introdotto ex novo in Cina per qualificare la “proprietà socialista”, la metafisica della mescolanza estetizza il dimorare domiciliare e spoliticizza il tessuto urbano. Oddio, a volte c’è poco da rimpiangere nelle politiche cittadine: meglio il Des Esseintes di Huysmans, verrebbe da dire, che il decoro urbano con i suoi zelanti retaker.

Doch dichterisch – pieno di meriti eppure poeticamente dimora l’uomo su questa terra, scriveva il Giacobino nell’Alta Torre, e tanto l’affaccendarsi costruttivo quanto il supplemento di senso valgono per la singola dimora e per la città di cui intravediamo il campanile «in lieblicher Bläue». Noi temiamo che, se l’oîkos inghiotte la polis e dissolve la politica, si rischi più l’avvento di un’economia estesa che di un’ecologia inter-specifica. La promozione dei mutui abitativi nel PNRR 2021, come nella bolla del 2008, non sarà troppo friendly per le altre specie.
L’introversione domiciliare dice la crisi della politica e dell’urbanistica, ma probabilmente la aggrava. Più che di una fine della città abbiamo a che fare con una degradazione della stessa per subordinazione alla finanziarizzazione della rendita nel passaggio dal “palazzinaro” allo “sviluppatore”, cioè della forma terrena della casa metafisica e dei suoi costi sociali.
Tutte le immagini da commons.wikimedia.org
