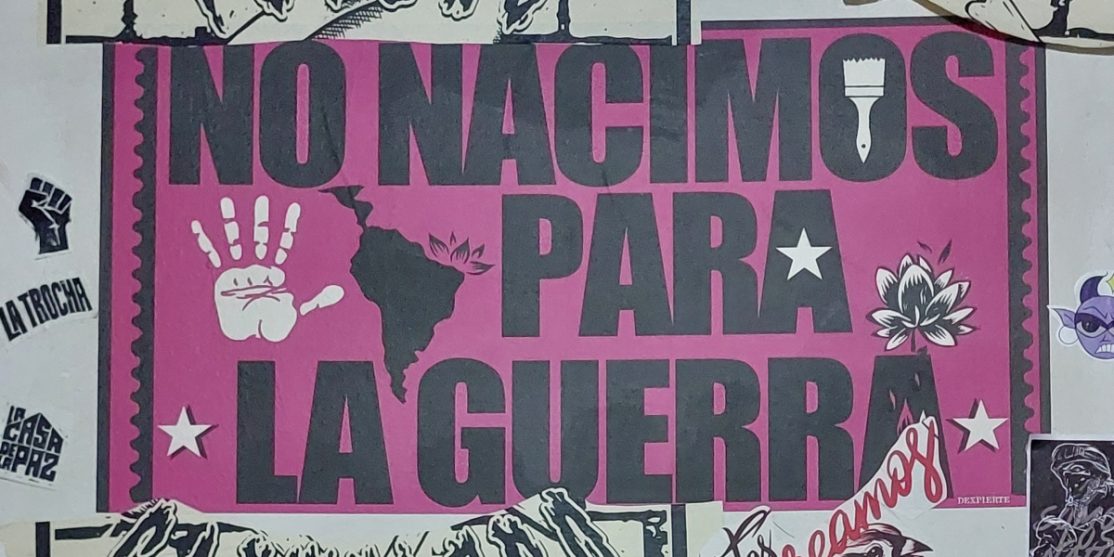MONDO
Boston, le lotte per la casa nei quartieri afroamericani e latinos

Il problema della casa negli USA, dopo la crisi e l’aumento delle disugaglianze. Strategie e dispositivi di resistenza praticati nella città di Boston.
Al nostro primo incontro, Lisa Owens e Denise Matthews mi consegnano una cartellina piena di fotocopie. Su un foglio sono elencati tutti i modi in cui i volontari possono collaborare con l’associazione, secondo il tempo di cui dispongono e il tipo di aiuto che possono offrire. Abituato ai movimenti politici del sud Europa, City Life mi è sembrata da subito molto strutturata, tanto da dubitare che si trattasse di una rete di protesta contro gli sfratti e non di una Ong che assiste le vittime della crisi finanziaria. Negli Usa, a partire dal 2008, almeno dieci milioni di persone sono rimaste senza casa, un nordamericano su venti. Ma essendo concentrate in quartieri e città specifici, la stampa ha potuto ignorarle, così che molti appartenenti alla classe media o alta non conoscono nemmeno una di queste persone.
A Boston, dove si concentrano alcune delle università più importanti del mondo e le sedi delle corporazioni finanziarie che muovono i fili dell’economia globale, la disparità sociale è aumentata in forma impressionante; oggi Boston è la città dove la differenze tra ricchi e poveri sono maggiori che in qualunque altra città degli Stati Uniti. I quartieri poveri sono abitati da latinos e afroamericani; è per questa ragione che, dalla sua fondazione negli anni Settanta, l’associazione ha adottato un nome bilingue – City Life/Vida Urbana.
CLVU riceve finanziamenti da varie fondazioni, con le quali paga un salario ai componenti della giunta direttiva e, in alcune occasioni, riesce anche a rilevare le case degli sfrattati. Una struttura organizzativa insolita, se vista da una prospettiva europea. In ogni caso, gli attivisti hanno molto chiari gli obiettivi dell’associazione, come mi dimostra Lisa, che conclude il nostro incontro con questa frase: «Noi lavoriamo a partire dalla lotta per la casa; ma la nostra lotta è contro il capitalismo».
La settimana dopo, quando partecipo a uno degli incontri settimanali, mi rendo conto che si tratta di qualcosa di molto sperimentale, ma anche molto efficace. Le riunioni del martedì si svolgono in un’antica fabbrica riconvertita in centro civico, nel quartiere di Jamaica Plain, una zona storicamente abitata da afroamericani e caraibici, ora molto gentrificata. Circa quaranta persone di differenti provenienze partecipano alla riunione, che inizia con la proiezione del video di uno sgombero evitato in un’altra zona della città. Alla fine del video, Steve Meachan, uno dei leader dell’associazione, si alza in piedi davanti all’assemblea. Ma invece di cominciare un discorso, si mette un cappello e comincia a fregarsi le mani. «Sono uno speculatore immobiliare – esclama, con voce da cattivo –. Questo quartiere fa al caso mio, penso che guadagnerò molti soldi da queste parti. Farò un patto con il Comune per riqualificare la zona e manderò via la gente che ci abita». Tutti rispondono, lo insultano ridendo, lo prendono in giro. Qualcuno traduce in castigliano a bassa voce. E lui continua: «E questa gente che protesta, questi che hanno messo su un comitato, ma che vogliono? Gli manderemo la polizia, pagheremo i giornalisti per farli insultare…». Resto affascinato: quando ho visto fare teatro in una riunione politica in Europa?
Le riunioni del mercoledì si svolgono nel sottoscala di una chiesa evangelica a East Boston – altro quartiere molto colpito dagli sgomberi. Nei mesi che ho partecipato alle attività, venti famiglie salvadoregne della zona erano rimaste senza casa. Il proprietario della palazzina in cui abitavano – un bad landowner – aveva interrotto la manutenzione dell’edificio per indurre gli inquilini ad andarsene. Quando crollò una parete esterna, le famiglie furono evacuate e il proprietario gli pagò un hotel per alcuni mesi. Ma all’inizio dell’inverno sarebbero finite per strada, se il pastore evangelico non gli avesse proposto di accamparsi nella chiesa; così, a partire da dicembre, alle riunioni partecipavano anche queste cinquanta persone, tra le quali molti bimbi – tutti latinos, cattolici, però molto ammirati per l’impegno del pastore ed entusiasti per l’appoggio degli attivisti. Il 25 novembre City Life ha organizzato una fiaccolata notturna fino all’edificio che le famiglie avevano dovuto abbandonare, con uno striscione che diceva: “Zona libera da sgomberi”. Poi il corteo ha proseguito verso un altro edificio in pericolo: la vecchia chiesa cattolica, costruita quando East Boston era un quartiere italoamericano. Lo stesso proprietario che aveva mandato via le famiglie salvadoregne aveva comprato questa chiesa per demolirla e farci appartamenti. Il pastore evangelico apriva la fiaccolata accanto ad Andrés Del Castillo, attivista di City Life di origine colombiana. Davanti alla chiesa, i manifestanti chiedevano ad alta voce: «Com’è possibile che quest’uomo abbia soldi per comprare una chiesa e non per rialloggiare le famiglie che ha mandato per strada?». C’era qualcosa di rituale nella processione, più che in una manifestazione qualsiasi; forse per la presenza del pastore, o per il senso di comunità che si cercava di trasmettere agli sfrattati.
Nella festa annuale di City Life mi sono reso conto che la religione gioca una parte importante in questa battaglia contro gli sgomberi, che gli attivisti considerano una battaglia per i diritti civili (non dimentichiamo che Martin Luther King e Malcolm X erano leader religiosi). La festa era in un teatro; dopo la cena, gratuita, la gente saliva sul palco per parlare. Molti di questi interventi – soprattutto quando si trattava di anziani afroamericani che erano riusciti a fermare gli sgomberi grazie a City Life – erano vere e proprie performance, sotto forma di witness, la “testimonianza” delle messe evangeliche. Il pubblico rispondeva «Oh yeah» a ogni passaggio, e alcuni cantavano, improvvisando, esattamente come nelle funzioni battiste. Così la potenza collettiva, l’emozione condivisa che si sviluppa grazie alla forma del rituale evangelico, si metteva al servizio di una protesta contro il capitalismo.
Altri rituali, in City Life, assomigliano più al teatro, alla satira, ma non sono meno importanti. Quando c’è un nuovo arrivato, i leader lo chiamano davanti all’assemblea a raccontare la sua storia. Mentre parla, la gente approva: “Oh yeah! Welcome!”. Alla fine gli danno una spada e uno scudo di cartone e gli spiegano, metà sul serio metà per scherzo: “Queste sono le nostre armi simboliche. La spada rappresenta le manifestazioni di protesta; lo scudo sono le nostre azioni legali per difendere gli abitanti”. Come in una parodia di investitura medievale, un vecchio attivista mette la spada sulla spalla del nuovo membro per farlo entrare nell’esercito che lotta per il diritto alla casa.
Una volta entrate in City Life, le persone colpite dagli sgomberi diventano attivisti. Dave, per esempio, è un iraniano tra i più attivi nella zona di East Boston. Non parla spagnolo, ma è cresciuto con gli italiani e nei suoi discorsi infila sempre qualche parola italiana. Dave organizza le squadre per andare a distribuire volantini. City Life ha identificato alcuni edifici di proprietari in odore di speculazione, come la grande corporazione immobiliare Fanny Mae & Freddie Mac, sovvenzionata dal governo federale, che continua a mettere sotto pressione i suoi inquilini più poveri perché lascino le case. Gli attivisti bussano alle porte di questi inquilini per spiegargli che in breve tempo potrebbero avere problemi con la casa. Questa è la spada. Poi c’è lo scudo: nelle riunioni si informa sulla campagna che si sta promuovendo insieme ad altre organizzazioni per far approvare la legge sugli sgomberi per giusta causa, che dovrebbe proibire gli sgomberi ingiustificati, cioè motivati dalla volontà di speculare. «Alcuni consiglieri ci hanno assicurato che daranno battaglia per approvare questa legge», spiega Dave durante l’assemblea.
La presenza di un movimento del genere a Boston – città elitista, conservatrice e puritana – è sorprendente. Ci sono studenti di diritto di Harvard o del MIT che offrono assistenza legale gratuita alle persone colpite dagli sgomberi; ma, per il resto, il mondo di City Life e quello delle grandi università si ignorano mutuamente. Harvard e il MIT sono a Cambridge, dove gli studenti pagano fino a duemila dollari per una stanza e non hanno l’interesse né il tempo per conoscere Dorchester o Roxbury – periferie in cui la miseria delle condizioni di vita non rientra nella nostra idea degli Stati Uniti come paese ricco. Per arrivare a Jamaica Plain e East Boston bisogna attraversare un fiume e una frattura sociale; spesso, nemmeno gli studenti o i professori di urbanistica o antropologia urbana di Harvard si spingono fin là. La storia degli sfratti a Boston non ricorre nei corsi di altissimo livello che si insegnano in queste università, dove c’è gente che conosce perfettamente le diseguaglianze a Rio o a Tokio. Pochi sanno che negli anni Cinquanta il centro di Boston conobbe uno dei più violenti processi di demolizione ed espulsione della popolazione urbana: con il pretesto della riqualificazione si fece tabula rasa di un terzo del centro storico, il quartiere del West End, per costruire il Massachusetts General Hospital e una serie di grattacieli. Decine di migliaia di persone, figli di immigrati italiani, irlandesi e di altre provenienze, dovettero lasciare le proprie abitazioni. Eppure sono le stesse università, con la costante necessità di dormitori per gli studenti stranieri, che continuano ad alimentare questo processo. La prestigiosa scuola di musica Berklee ha concluso da poco un patto con la chiesa Christian Science, che possiede molte case nel quartiere di Fenway, nel centro della città, per mandare via gli inquilini e affittare, a un prezzo molto più alto, agli studenti. City Life a dicembre ha organizzato un funerale simbolico per il quartiere. Alla manifestazione partecipava anche qualche musicista di Berklee, suonando mentre gli abitanti portavano il feretro del loro vecchio quartiere. «I nostri nemici sono le università, non gli studenti», spiegava uno degli attivisti durante la riunione. «Oh yeah», rispondevano gli altri. (stefano portelli / traduzione di -lr)
Articolo pubblicato su diagonalperiodico
Tradotto in italiano e ripubblicato da napolimonitor