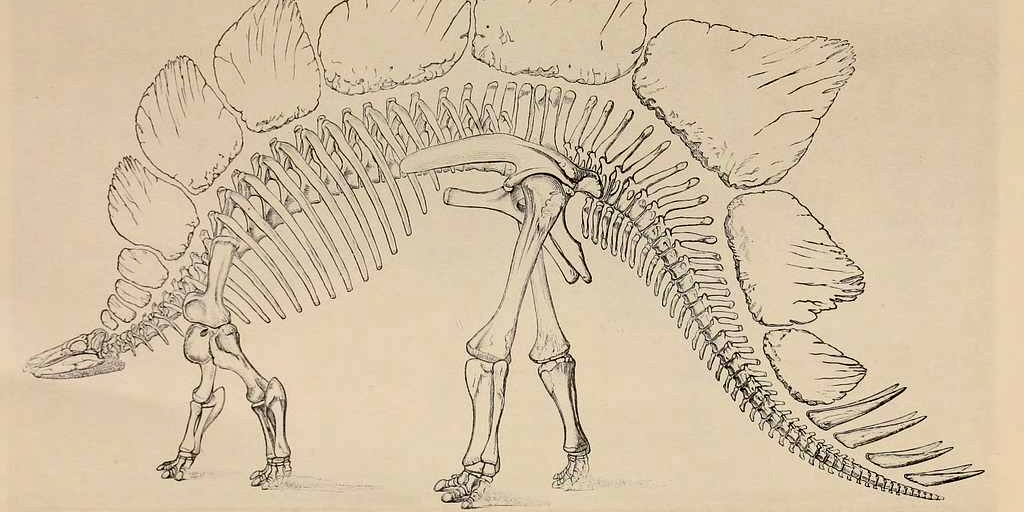CULT

Camus, la peste e l’angoscia dell’umano
Una riflessione sulla figura del dottor Rieux ne “La peste” di Albert Camus: l’occasione per ripensare alla luce dell’emergenza attuale le ragioni ultime delle azioni individuali, in un mondo dove non ci sono “né eroi, né santi”
Se la peste fosse solo un problema sanitario e si risolvesse unicamente con risposte di tipo tecnico per evitare che il contagio si diffonda e per arginare la mortalità dell’epidemia, se fosse solo la ricerca di farmaci curativi e la somministrazione di vaccini, se anche trasformasse la città in un grande ospedale o in un lazzaretto a cielo aperto, se fosse una malattia da trattare e un protocollo da seguire probabilmente non sarebbe la peste.
La peste della città di Orano e tutte le altre pestilenze della storia, quelle del presente e anche quelle del futuro, sono tali non solo perché si presentano sotto forma di bubboni e di affezioni polmonari e respiratorie ma sono soprattutto tali per le domande che con esse si accompagnano.
La malattia è già di per sé un grande interrogativo dell’uomo e quando questa diventa collettiva, quando essa si abbatte su una comunità numerosa di individui, come appunto fa la peste e ogni peste, le domande si fanno più grandi, la ricerca dei perché ancora più affannosa e soprattutto si afferma la consapevolezza tacita che nessuna risposta potrà mai soddisfare le vibrazioni infinite del chiedere e dell’interrogare e che ritenersi soddisfatti da una qualsiasi replica è quasi come fare una scelta, un’adesione, una sorta di persuasione di fronte all’esperienza della prova e del dolore che forse non può che lasciare insoddisfatti.
Bernard Rieux, il medico della peste di Orano, è convinto di questo, lo percepisce chiaramente, perciò non si schiera. Il contagio non è per lui l’occasione per teorizzare qualcosa quanto piuttosto applicazione e dedizione ai bisogni degli uomini.
Nel corso della storia egli si confronterà con altre opzioni, quella della fede oppure della santità e dell’eroismo, che volta a volta i protagonisti della vicenda gli presenteranno. Eppure lui dichiarerà sempre onestamente di non «saperne niente» e opterà per una dimensione costantemente orizzontale, a favore dei vinti e degli svantaggiati. Egli si fa, per così dire, sacerdote di una religione dell’uomo, dell’uomo indifeso di fronte all’irruzione dell’assurdo nella sua vita, dell’uomo che soccombe miseramente al suo limite da forte e vigoroso che era. Nel caso della morte di Jean Tarrou, un suo compagno nella lotta alla pestilenza nelle «formazioni sanitarie», Bernard Rieux non può non fare il confronto amaro tra il passato, anche recentissimo, e il presente, tra l’energia dell’amico «che prendeva a piene mani il volante dell’automobile per guidarla» e il suo corpo morto, disteso sul letto «senza moto». Perciò il dottor Rieux ha da proporre al mondo soltanto la sua missione e il suo impegno:
«Non so quello che mi aspetta né quello che accadrà, dopo. Per il momento ci sono dei malati e bisogna guarirli».
Egli non esita a riconoscere la fatica e lo sforzo che fa a confessare una fede in Dio («Forse val meglio per Dio che non si creda in lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il cielo dove lui tace»), come pure ammette le sue difficoltà a condividere qualsiasi attivismo eroico, anch’esso, a suo giudizio, una forma di esaltazione, a cui si sentiva di opporre un operare nell’ombra e un sentire mediano, fatto «di sentimenti che non sono ostentatamente malvagi né entusiasmanti alla sfacciata maniera di uno spettacolo».

Alla base del suo agire c’è soprattutto una morale pratica; i valori in cui crede sono quelli dell’onestà: «È un’idea che può far ridere, ma la sola maniera di lottare contro la peste è l’onestà. […] Cosa sia in genere, non lo so; ma nel mio caso, so che consiste nel fare il mio mestiere», della correttezza, della lealtà…
Sono le virtù dell’uomo che stringe legami con altri uomini, che lavora su un terreno dove non c’è posto per la trascendenza, non foss’altro perché ammetterla renderebbe ancora più scandalosa la presenza del male e del dolore sulla terra e inammissibile una loro giustificazione.
Questo sempre e in ogni caso. Ma è ancora più vero se si tratta del dolore innocente dei tanti piccoli che l’epidemia uccideva. Perciò a padre Paneloux, il prete gesuita che nel romanzo sostiene con argomenti forti le ragioni della fede anche di fronte al non-senso e all’assurdo, che gli dice: «Forse dobbiamo amare quello che non possiamo capire», il dottor Rieux seccamente ribatte: «No, padre, io mi faccio un’altra idea dell’amore e mi rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati». L’opposizione è netta, tanto che il medico non riesce ad accettare neanche la complicità linguistica che il religioso gli offre, e cioè di lavorare entrambi «per la salvezza dell’uomo». È un passaggio molto delicato del dramma che i due hanno in comune e stanno vivendo, dove le parole hanno un peso notevole e ognuna si riferisce a una sfera e a una storia diversa, perciò la precisazione del sanitario è quanto mai necessaria per esprimere il suo personale punto di vista e la nettezza della propria posizione:
«La salvezza (salut) dell’uomo è un’espressione troppo grande per me. Io non vado così lontano. La sua salute (santé) mi interessa, prima di tutto la sua salute».
Un’altra particolare angolazione da cui guardare al male e al contagio è quella offerta da Jean Tarrou, un non-credente che aveva fatto dell’attivismo nella lotta contro ogni forma di discriminazione e ingiustizia la ragione della sua vita e il morbo di Orano gli offre certamente l’occasione per mettere in pratica questi ideali. Per lui la “peste” è qualsiasi tipo di iniquità e di sofferenza inflitta all’uomo. A partire da ciò egli non esita ad ammettere «di aver sofferto di peste molto prima di conoscere questa malattia» e che l’epidemia del sopruso, della sopraffazione «ognuno la porta in sé e nessuno al mondo né è immune». Perciò a partire dalla consapevolezza che “sulla terra ci sono soltanto flagelli e vittime”, egli così esprime la convinzione della sua scelta di vita:
«Bisogna, per quanto è possibile, rifiutarsi di essere con il flagello».
Tuttavia, così come aveva respinto l’idea di padre Paneleux di una santità che arriva a fare “il salto” e ad ammettere che dietro l’incomprensibile e assurdo di quell’ora c’era ancora la volontà di Dio, il dottor Rieux guarda con sospetto anche alla concezione eroica dell’amico dell’impegno “politico” di fronte alla malattia. Rispetto alle due opzioni che rappresentano e gli prospettano i due suoi interlocutori egli testardamente torna a ribadire il suo semplice punto di vista: nessuna trascendenza e nessuna esaltazione, nessun andare oltre, come etimologicamente è indicato nelle due parole, ma piuttosto fermarsi entro i limiti dell’umano e stare quanto più possibile nella sua immanenza. È questo il suo mandato di medico della peste che lo fa sentire «più solidale con i vinti che con i santi».

«Essere un uomo, questo mi interessa»: è la conclusione a cui arriva. L’umanesimo di Camus è anche l’umanesimo del dottor Rieux.
Il narratore sembra parafrasare Terenzio («Homo sum, humani nihil a me alienum puto») quando scrive che non vi era «nessuna angoscia dei suoi concittadini che lui non abbia condivisa, nessuna situazione che non sia stata anche la sua».
L’unica variante rispetto al detto dell’autore latino è il termine “angoscia” al posto di “umano”. Ma la peste giustificava ampiamente una tale sostituzione. Anzi l’umanità del medico risiede proprio nel sapere stare vicino all’angoscia dei suoi malati; questo sembra essere il proprio del suo lavoro più che la sua bravura, la sua competenza, la sua capacità clinica. Se queste abilità infatti rappresentano il “cosa” della professione, quella virtù indica invece il “come” di essa. Di fronte al contagio grave egli sa infatti di dover stare con «il partito della vittima» e condividere con essa il territorio vastissimo «della sofferenza e dell’esilio». La posizione della sola scienza non poteva tenere; era necessario prima di tutto un atto d’amore e di condivisione lungo un confine fatto di tante sconfitte e di poche vittorie… Fedele al suo compito, consapevole dei limiti della sua azione, condannato dal male all’impotenza, il dottor Rieux segue «la legge dei cuori onesti», la regola di chi si impegna e basta, di chi lavora senza fare tante domande e senza nessuna luce.
La sua è la posizione più scomoda, quella di chi non si fa illusioni e che trova solo nella umanità sua e nell’umanità altrui le ragioni della propria missione: né eroi né santi questo il suo motto.
Guarire e curare è importante, ma più importante ancora è la testimonianza a favore dell’impegno e della persona malata e forse l’unica consolazione che può trarre dall’esperienza dolorosa delle peste è solo quel raggio di fiducia nel genere umano che gli permette di scorgere che «negli uomini ci sono più cose da ammirare che da disprezzare».
In copertina: Edward Gay, Broad Acres