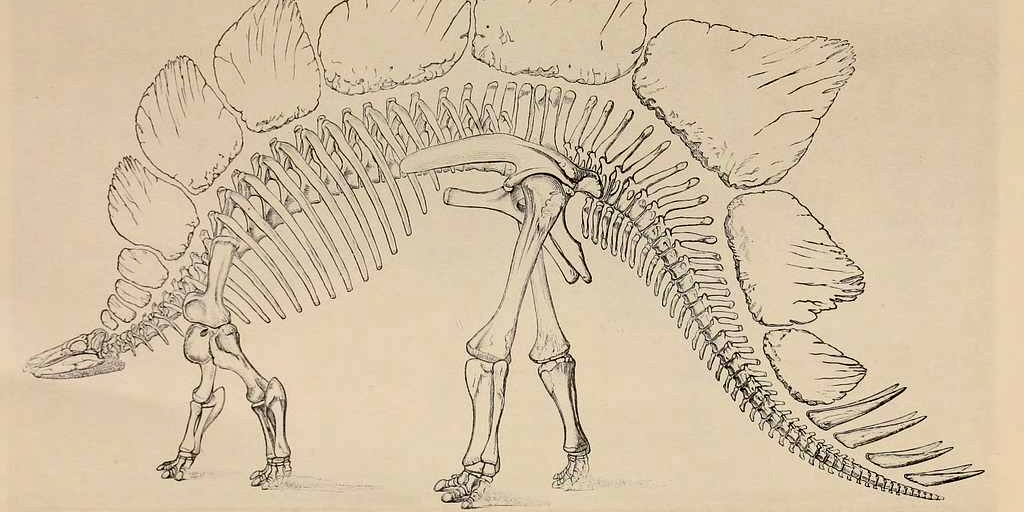EUROPA

“Salvare vite in mare non è una professione”. Intervista a Kathrin e Sasha, attivisti della Iuventa
Abbiamo incontrato e intervistato Kathrin e Sasha due membri dell’equipaggio della Iuventa, nave della ONG tedesca Jugend rettet sotto sequestro dal 3 agosto 2017 alla prima del film Iuventa a Roma il 25 settembre. Kathrin e Sasha si sono incontrati a Lesbo nell’ambito di un progetto di save and rescue. Kathrin a partecipato con la ONG CADUS a un progetto a Kobane in Rojava e a diversi progetti di border kitchen al confine tra Croazia e Slovenia e tra Macedonia e Grecia ed è stata presente per molto tempo a Idomeni e Samos. Sasha, di professione paramedico e nel 2015 è partito in missione con Sea Watch nel Mediterraneo e ha partecipato a diversi progetti con la ONG CADUS.
Quando e come vi siete uniti alla ONG Jugend rettet? Come ha reagito la società tedesca a una NGO fondata da giovani determinati ad andare a salvare vite nel Mediterraneo Centrale?
Kathrin: Nell’aprile 2016 ero a Lesbo all’interno di un progetto di CADUS e Sea Watch, dove ho incontrato Sasha e siamo partiti per le prime missioni di salvataggio. Era appena stato firmato l’accordo UE-Turchia e gli sbarchi in Grecia erano diminuiti. Dopo la cancellazione del progetto di CADUS-Sea Watch ci siamo imbarcati sulla Iuventa. L’ONG era già stata fondata, aveva già fatto crowdfunding ed acquistato la nave per le missioni di ricerca e salvataggio. Sasha ha partecipato dalla prima missione, e io dalla terza in poi. Penso che in fase di pianificazione e finanziamento e durante le prime missioni Jugend rettet godesse di ampi consensi nella società: erano quelli che avevano smesso di stare guardare per passare finalmente all’azione. Questa percezione però è cambiata nel corso della vicenda Iuventa e con la criminalizzazione delle ONG.
Sasha: Finito il progetto, sono entrato in contatto con Jugend rettet, un gruppo di giovani tra i 18 e i 23 anni che aveva fondato un’organizzazione. Inizialmente, l’obiettivo politico era fare sensibilizzazione semplicemente un annuncio: sarebbero salpati di persona per il Mediterraneo centrale. Era una provocazione: i giovani, i figli dell’Europa, per così dire, sarebbero partiti per fare quello che avrebbero dovuto fare gli Stati e le guardie costiere. Hanno avuto successo, sia nel sensibilizzare la società tedesca, sia col crowdfunding e si sono ritrovati con una nave. Arrivati a Malta hanno cominciato a cercare un equipaggio per la missione, persone con l’esperienza necessaria per pianificare e dirigere le missioni di salvataggio, persone qualificate, un capitano, dottori, meccanici. Ma non cercavano professionisti, perché salvare vite in mare, in questo ambito, non è una professione. È sempre stato chiaro a tutti noi che il progetto aveva anche una dimensione politica, che non era soltanto umanitario, ma era legato al lavoro politico sulla terraferma.
Jugend rettet non riteneva né che il proprio progetto fosse la soluzione al problema né che conducesse alla professionalizzazione. Come si è sviluppata l’operazione e quali erano i suoi obiettivi politici?
Kathrin: Ci è sempre stato chiaro che salvare vite in mare non fosse la soluzione. Ma andava fatto. Ed era altrettanto importante riportare notizie di prima mano su cosa stava accadendo, perché se non ci fossimo stati noi nessuno l’avrebbe fatto. Siamo stati noi a portare i giornalisti sul posto e siamo stati noi, insieme ad altre organizzazione, come Sea Watch e MSF, che abbiamo messo sotto i riflettori la situazione nel Mediterraneo centrale, facendone un caso mediatico. Per noi questa era una parte fondamentale del lavoro politico, perché crediamo che solo attraverso questo tipo di pressione da parte dell’opinione pubblica si possa, nel tempo, arrivare a risolvere il problema. All’interno dell’ONG abbiamo discusso a lungo sul livello di professionalizzazione da raggiungere e ci sono state molte resistenze. Da una parte ci siamo resi conto dello sforzo che richiedevano le operazioni e sapevamo di dover sull’equipaggiamento e sulle competenze. Dall’altra però non eravamo e non volevamo diventare professionisti. Non volevamo assumerci una responsabilità che è degli Stati.
Sasha: Non volevamo diventare professionisti, ma eravamo coscienti dell’importanza fondamentale dell’azione diretta in mare, come di quella della collaborazione con le altre realtà che a terra lottavano per trovare soluzioni. Abbiamo sempre saputo di operare in una situazione di emergenza, ma volevamo che le persone salvate avessero poi la possibilità di lottare autonomamente, anche entrando in contatto con tutti gli altri, con il nostro movimento a terra per così dire.
Come si strutturava il vostro lavoro e come è cambiato nel tempo? Come sono cambiate le relazioni con le autorità italiane?
Kathrin: All’inizio la collaborazione con le autorità italiane andava molto bene. Comunicavamo con regolarità e la guardia costiera italiana ci informava sulla posizione delle imbarcazioni in pericolo, sulle partenze e sul numero di persone a bordo. Si occupavano anche dei trasporti. Non abbiamo deciso neanche un’unica volta di trasferire arbitrariamente persone dalla Iuventa a un’altra imbarcazione. Chiunque abbia lasciato la Iuventa lo ha fatto su ordine del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC) di Roma. Ricordo la missione dell’aprile 2016: avevamo appena salvato e imbarcato delle persone e, per la prima volta, ci fu ordinato di trasferirne la maggior parte su un’altra nave tenendo a bordo solo 5, che avremmo dovuto portare a Lampedusa personalmente.
Abbiamo cominciato a discutere con l’MRCC, non capendo perché avremmo dovuto lasciare la zona Sar. Date le condizioni meteo sapevamo, e lo sapeva anche l’MRCC, che ci aspettavano giorni impegnativi e che sarebbero servite tutte le navi disponibili. Alla fine abbiamo accettato di andare a Lampedusa. All’alba abbiamo ricevuto la prima chiamata di emergenza via radio: prima una, poi due, tre, sette navi in pericolo. Sul posto erano presenti solo Sea Watch e la Von Hestia (Save the children), che chiedevano il nostro aiuto. Abbiamo immediatamente informato l’MRCC, peraltro già contattato da Sea Watch. La guardia costiera ha continuato a dirci di andare a Lampedusa perché avevano tutto sotto controllo. Eravamo molto combattuti sul da farsi: dovevamo tornare indietro per non venir meno al nostro dovere? Secondo la legge internazionale e il diritto del mare in questi casi vige l’obbligo di assistenza. D’altro canto il centro responsabile per il coordinamento dei salvataggi nell’area ci ordinava di ignorare le richieste di aiuto. Per non sacrificare il nostro rapporto con loro, siamo scesi a un compromesso: 3 di noi, me compresa, avrebbero seguito Sea Watch su una piccola imbarcazione di salvataggio, mentre la Iuventa si dirigeva verso Lampedusa. Quella notte le emergenze sono state talmente tante che le persone hanno dovuto passare la notte sulle scialuppe di salvataggio. Il giorno dopo, con le navi tutte piene, sono arrivate altre 21 imbarcazioni. Eravamo del tutto sopraffatti. Quel giorno, il giorno in cui l’MRCC aveva richiamato la Iuventa a Lampedusa, sono morte più di 1000 persone. Quello è stato il punto di svolta e ora sappiamo che proprio in quei giorni è stata messa una cimice sulla Iuventa. Ci hanno richiamato per aprire il dossier su di noi invece di gestire la zona SAR e i salvataggi.
Sasha: Stavano giocando al gatto con il topo. Quando ci siamo rifiutati di dirigerci verso Lampedusa,hanno minacciato conseguenze legali. Poi abbiamo raggiunto un compromesso: il trasbordo sarebbe avvenuto a metà strada. Non aveva senso, ma abbiamo accettato lo stesso. Ma nel punto concordato non c’era nessuno ad aspettarci e siamo stati costretti a proseguire verso Lampedusa. Nelle missioni successive siamo stati richiamati in porto altre 3 volte e abbiamo subito interrogatori di 10-12 ore, con le autorità che ci chiedevano delle missioni, dei finanziamenti, dell’organizzazione, e dove prendessimo le informazioni sulle imbarcazioni. Le cose stavano cambiando. Adesso sappiamo che dal settembre 2016 era cominciata una campagna contro le ONG, avviata da Francesca Totolo. C’era anche un think-tank olandese, Gefira, che produceva materiale sulle ONG che operavano nella zona SAR e, in particolare, sul progetto Iuventa e su di noi personalmente. Hanno anche inventato il termine “taxi del mare”, che poi è finito nelle dichiarazioni ufficiali di Frontex e delle autorità italiane.
Com’è la situazione adesso, dopo il sequestro della Iuventa? Quali conseguenze ha avuto la criminalizzazione delle ONG?
Kathrin: Le autorità ci hanno confiscato la barca, i telefoni, i computer. Un anno dopo hanno aperto un’inchiesta contro 10 membri dell’equipaggio della Iuventa e 2 membri di altre organizzazioni. La cosa interessante è che all’inizio le accuse erano 3: collusione col crimine organizzato e i trafficanti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e possesso di armi da fuoco. La nave è stata perquisita alla ricerca di armi, che ovviamente non sono state trovate. Come già detto, abbiamo sempre collaborato con le autorità italiane. Non abbiamo mai deciso noi dove portare coloro che salvavamo, sono sempre state le autorità italiane, che agivano secondo la convenzione di Ginevra, il diritto internazionale e il diritto del mare, a dirci di portarli in Italia. Abbiamo salvato delle vite, e l’abbiamo fatto sotto il loro comando. Farcene una colpa sembra quanto meno una contraddizione.
Sasha: Se andiamo a processo rischiamo fino a 20 anni di prigione, più una multa salatissima, che potrebbe arrivare a 15.000 euro per ogni persona giunta illegalmente in Italia. Ne abbiamo salvate 14.000, fa 210 milioni. Politicamente è una cosa molto pericolosa, perché equivale a dire che il semplice fatto di aiutare le persone è da considerare un crimine. Questo avrebbe un impatto enorme su tutto il settore umanitario come su ogni tentativo di aiutare i migranti in viaggio o alle frontiere di terra, nonché i cosiddetti clandestini nelle città. Dovranno inventarsi qualcosa, perché se ci giudicheranno soltanto sulla base delle nostre azioni dovranno dire che, siccome le persone che salviamo entrano illegalmente in Italia, salvare vite umane va considerato un crimine.
L’Aquarius è l’ultima nave rimasta nel Mediterraneo centrale e i porti italiani stanno chiudendo. Cosa dovremmo fare in mare e sulla terraferma?
Sasha: Abbiamo sempre detto chiaramente che non vogliamo consegnare nessuno ad autorità che riportano le persone in Nordafrica. Ma è proprio questa la soluzione alla quale lavora alacremente il parlamento europeo. Pensiamo al caso Hirsi: nel 2008, la marina italiana ha salvato una nave riportandone a Tripoli i passeggeri. Nel 2012, la corte europea dei diritti umani ha stabilito che questo tipo di respingimenti non è consentito. Ed è proprio per questo che sono i paesi terzi a dover fare il lavoro sporco: non possiamo sporcarcele noi le mani. Dobbiamo opporci a questo genere di soluzioni, non possiamo farle passare sotto silenzio. Dobbiamo aprire i porti.
Kathrin: Ci si prospetta una sfida importante. Non possiamo andare personalmente a salvare la gente. Senza navi non ci sono né giornalisti né informazioni: il rischio è che la questione finisca nel dimenticatoio. Dobbiamo continuare a combattere per chi non ha voce, per chi annega senza essere visto. In Germania ci sono state molte manifestazioni. Contro le politiche europee sono scese in piazza tra le 30 e le 50.000 persone. Vogliamo che sempre più persone si interessino alla questione e mantengano alta la pressione sulla classe politica. Specialmente in Germania le persone scendono in piazza numerose perché hanno paura che la storia si ripeta. Siamo già arrivati al punto in cui il sistema giudiziario viene utilizzato per implementare gli obiettivi di una politica fascista. Noi siamo scomodi per il governo italiano e per l’UE. La nostra cultura celebra i “Fluchthelfer”, coloro che hanno aiutato i perseguitati a fuggire durante la seconda guerra mondiale o a scappare da Berlino Est a Berlino Ovest. Nella società tedesca queste persone non sono considerate né criminali né trafficanti, benché facessero proprio questo: contrabbandare esseri umani attraverso il confine. Ma lo facevano per ragioni politiche, per l’umanità. Per cui è molto controverso criminalizzare non solo i migranti costretti a fuggire dai loro paesi ma anche chi offre loro aiuto. Il nostro ruolo nella storia è cambiato: in passato erano i tedeschi a dover fuggire e ora sono gli altri a venire in Germania.
Sasha: La percezione della società civile sembra tornare positiva: in Germania ci sono grandi manifestazioni contro questa criminalizzazione e contro la chiusura dei porti. Ma nella storia il modo in cui è percepito chi aiuta le persone in fuga è cambiata spesso. Dobbiamo imparare a riconoscere il fascismo. Dietro I cambiamenti politici di cui siamo testimoni c’è un movimento fascista e il movimento antifascista deve risvegliarsi. Dobbiamo chiederci in quale direzione vogliamo che vada la società. Ovviamente, dal punto di vista dei salvataggi in mare, la soluzione sono le navi. Vogliamo un sistema di salvataggio professionale e appropriato, ma non pensiamo che l’Italia lancerà una nuova operazione Mare Nostrum. Crediamo che Malta non farà nulla, come al solito. In Spagna invece si sta sviluppando un movimento molto ampio, quindi magari qualcosa cambierà, ma è presto per dirlo. Nel frattempo la gente muore, i porti sono chiusi e il Marocco spara ai migranti. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo essere presenti. E ancora una volta per finanziare le barche e andare per mare non possiamo contare che sui nostri mezzi. Succederà, ne sono certo. Siamo pieni di idee.
Tutte le info sulla proiezione alla Sapienza