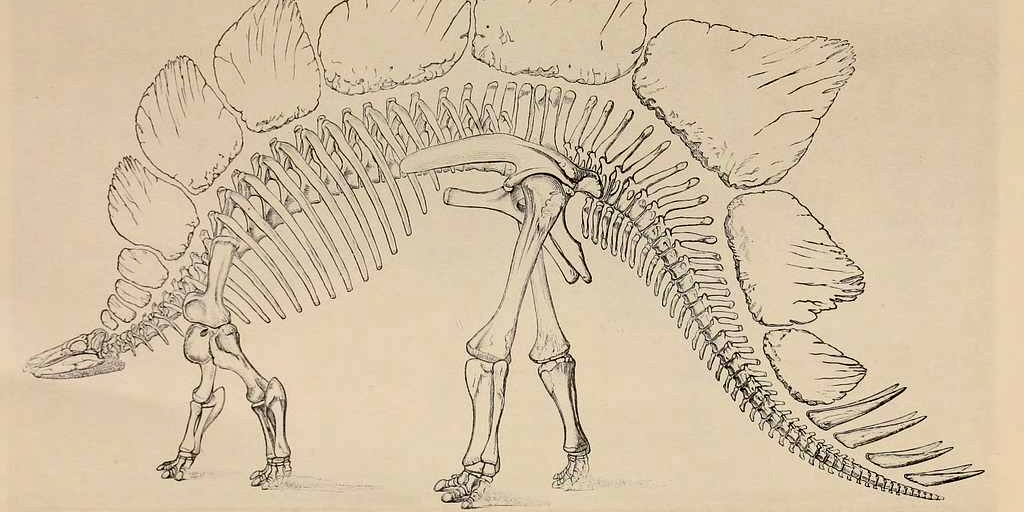ITALIA

Salario minimo: una battaglia da non abbandonare
L’approvazione della mozione che nega il salario minimo in Italia avrà delle conseguenze. Considerata la situazione occupazionale e economica italiana è lecito chiedersi se il salario minimo è come indica il governo un provvedimento assistenziale o se si tratta di garanzia di diritto
Come ormai noto, il 30 novembre 2022, la Camera ha approvato una mozione di maggioranza che impegna il Governo a non introdurre alcuna forma di salario minimo in Italia. Per comprendere pienamente la portata di tale dibattito e le conseguenze che ne potrebbero derivare dalla scelta presa dal Governo, mi limito a citare alcuni dati utili a comprenderne il contesto del mercato del lavoro italiano.
Nel nostro paese una buona parte degli occupati guadagna oggi meno che in passato e vive in una situazione di estrema precarietà.Per essere ancora più precisi: secondo le stime del CNEL il c.d. lavoro povero a partire dal 2015 ha interessato oltre 3 milioni di individui e pone circa 2,2 milioni di famiglie in condizioni di rischio povertà, nonostante almeno un componente del nucleo risulti occupato.
Secondo l’Istat ad inizio 2021, il tasso di disoccupazione generale era pari al 10,2%, mentre la disoccupazione giovanile (15-24 anni) era pari al 31,6%.
Inoltre, oggi il salario medio italiano è di 12.400 euro più basso di quello tedesco. L’Italia è tra i pochissimi paesi in Europa in cui i salari medi nel 2019 sono inferiori a quelli del 2007 e dove più di 5 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano meno di 10.000 euro annui, ponendosi così sotto la soglia di povertà seppur avendo un impiego.
Il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione recita: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese».
Alla luce dei dati citati sopra e del dettato costituzionale, risulta inequivocabile, quanto sia necessario introdurre questa misura nel nostro ordinamento giuridico e, sulla base di tale esigenza, negli ultimi cinque anni sono state varate varie proposte di legge in merito e inoltre in ambito in ambito europeo, è stata approvata la direttiva UE 2022/2041 che impegna gli stati europei a introdurre il salario minimo entro due anni.
Oggi, alla luce della mozione approvata dalla maggioranza di governo, tali possibili provvedimenti, sono diventati di fatto carta straccia, cestinando la questione del salario e rinviandola ai “posteri”.
Le ragioni per cui è stato di fatto bocciata la possibile introduzione di una misura di salario minimo nel nostro paese, esplicitate nella mozione 1/00030, si possono riassumere così:
- Il salario minimo inciderebbe non solo sui livelli retributivi, ma anche sul costo del lavoro;
- La contrattazione collettiva copre l’85% dei lavoratori e lavoratrici;
- L’introduzione del salario minimo metterebbe a repentaglio la contrattazione collettiva, favorendo (non si capisce come), l’emergere dei CCNL c.d. “pirata”;
- Il salario minimo, al pari del reddito di cittadinanza, viene considerata come una misura assistenziale;
- L’introduzione del salario minimo, potrebbe avere un effetto inflazionistico sul mercato.
Queste sono le ragioni per cui, secondo il Governo, il salario minimo non va introdotto in Italia.
A una rapida analisi di tali ragioni, emerge chiaramente come tale mozione assuma proprio il valore di documento programmatico di indirizzo politico, una vera e propria dichiarazione di interessi di “classe”, quella padronale s’intende.
Da questa prospettiva, il salario minimo è sempre stato visto come una vera e propria minaccia per gli interessi di natura padronale, qualora fosse realizzato, sarebbe in grado di aprire una piccola, ma significativa breccia tra i meccanismi di accumulazione economica di quest’ultimi (in particolare per il padronato italiano, da sempre portato a garantirsi margini di profitto erodendo risorse dai salari, dalle ore di lavoro non retribuite, dall’utilizzo di alcuni istituti welfaristici al posto degli istituti retributivi che trovano la propria fonte nel Contratto collettivo nazionale).
Una misura da sempre osteggiata, sin dal dibattito avvenuto in seno all’Assemblea costituente.
Ad esempio, il deputato Aladino Bibolotti propose che, al primo comma dell’art. 32, poi divenuto art. 36, fosse aggiunta la seguente previsione: «Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge» e così argomentò a sostegno della proposta: «a me pare (…) che questo inserimento nell’articolo 32 conferisca all’articolo stesso una consistenza ed una concretezza tali da tranquillizzare le famiglie dei lavoratori, nel senso che, compiuto il loro dovere sociale di partecipare al processo della produzione, essi non potranno essere mai più oggetto di quello sfruttamento inumano e senza limiti che oggi, in determinate circostanze e in determinati rapporti di forze, sarebbe ancora giuridicamente possibile».
L’emendamento non fu approvato. I Costituenti scelsero di non prendere posizione sulle modalità attraverso cui assicurarela giusta retribuzione. Non fu introdotta una riserva di legge sul salario minimo, che avrebbe affidato al legislatore il compito di stabilire la soglia di proporzionalità e sufficienza; non fu neanche stabilita una riserva in materia retributiva a favore della contrattazione collettiva. Quindi,nel contesto di mancata attuazione dell’art. 39, seconda parte, Cost., è stato demandato alla giurisprudenza del giudice del lavoro e della Corte di cassazione l’elaborazione della definizione della giusta retribuzione.
Dunque, anche in questa occasione, i rappresentanti datoriali, possono, momentaneamente, tirare un sospiro di sollievo e pensare al “pericolo” scampato.
Tuttavia, dal “nostro” punto di vista, ancora più convintamente dobbiamo provare ad aprire una questione. È evidente lo stato di panico che emerge dal documento varato dalla maggioranza di governo in relazione alla conseguenze che ne potrebbero derivare dall’introduzione di tale misura nel nostro paese.
Infatti, provando a leggere le ragioni che hanno portato la maggioranza a bocciare l’ipotesi di salario minimo da un’altra prospettiva, emerge invece il perché tale misura è funzionale per un riequilibrio dei rapporti di forza tra componenti datoriali e quelle dei lavoratori, introducendo non solo la possibilità di un avanzamento economico delle classi subalterne, ma anche una capacità di organizzazione sul piano del conflitto e della rappresentatività.
Potremmo riassumere tali ragioni in questi termini:
- Il salario minimo potrebbe permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di avere aumenti salariali adeguati alla qualità e quantità di lavoro prestato (in sintonia con l’art. 36 della Costituzione);
- Tale misura potrebbe essere applicata anche al di fuori dei rapporti di lavoro formalmente subordinati, garantendo anche al lavoro autonomo occasionale e monocommittente di avere una paga degna (avvicinando inoltre i punti di contatto tra le due figure lavorative subordinate e autonome);
- L’introduzione del salario minimo potrebbe mettere in discussione il monopolio della contrattazione collettiva delle OO.SS. confederali, favorendo forme di sindacalismo sociale e conflittuale;
- Il salario minimo connesso al reddito di cittadinanza, diventerebbe un dispositivo organizzativo e di rifiuto del lavoro impoverito e precario;
- L’introduzione del salario minimo aprirebbe un dibattito sul meccanismo dell’indicizzazione dei salari come misura di contrasto all’inflazione.
Per tutte queste ragioni, è fondamentale rilanciare il dibattito sul salario, affiancato alla difesa del reddito di cittadinanza, costruendo comitati e alleanze tra le diverse figure del lavoro precario e impoverito, con chi al momento un lavoro non ce l’ha, oppure lo ha rifiutato proprio perché sottopagato e indegno.
Immagini di copertina della manifestazione del 22 ottobre a Bologna, di Marta D’Avanzo