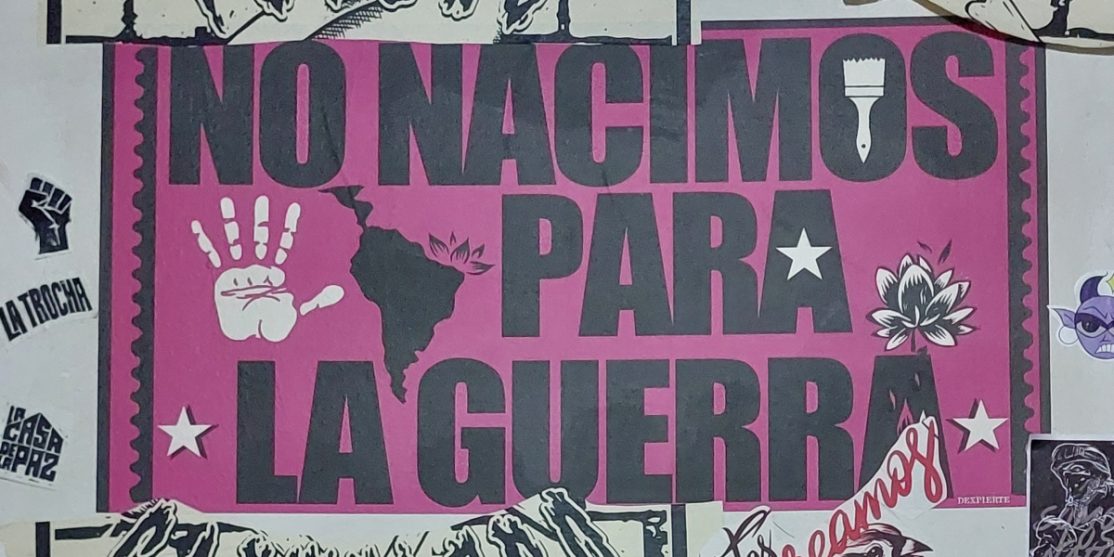EUROPA

Palestine Speaks. Cosa significa essere palestinese in Germania
A seguito della violenta repressione a Berlino durante il giorno della Nakba, Berlin Migrant Strikers ha organizzato un’intervista che indaga l’identità palestinese al di fuori della terra di Palestina. Tra chi è nato in Europa e chi è “indefinito”. Tra razzismo e resistenza. Tra nuove e vecchie generazioni contro l’apartheid
Palestina Speaks era tra gli organizzatori del flashmob violentemente represso a Berlino il 15 maggio. Abbiamo organizzato questa intervista per parlare del gruppo e di cosa significa essere palestinese in Germania.
Puoi parlarci di Palestine Speaks?
Palestine Speaks (PS) è un gruppo fondato nel 2019 da palestinesi che vivono in Germania, coscienti della frammentazione della comunità palestinese per via della repressione che subiamo. Non è facile parlare di Palestina in Germania. In quell’anno in particolare il Bundestag (Parlamento) aveva votato una risoluzione per togliere risorse finanziarie e spazi pubblici a movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).
Noi palestinesi ci siamo resi conto che bisognava fare qualcosa. L’idea alla base di PS è concentrarsi sulla repressione che subiamo in Germania, denunciarla pubblicamente, rendendo più’ visibili le nostre voci.
La tua famiglia viene da Gaza ma tu sei nata nella Germania occidentale. Molti palestinesi vivono la stessa esperienza: alcuni sono nati in Europa, altri sono arrivati qui come rifugiati. In che modo questa miscela influenza il gruppo?
Crescere in un campo in Libano, in Siria, a Gaza o in Cisgiordania è qualcosa che modella la tua esperienza. Anche se esiste una forte alleanza su determinati valori e idee, queste diverse esperienze influenzano le nostre visioni del futuro. A volte è impegnativo, a volte è stimolante perché impariamo gli uni dagli altri. Ad esempio le persone che vengono dalla Siria o dai territori occupati conoscono molte tattiche per mobilitarsi in strada e muoversi in un sistema repressivo. Per noi cresciuti e socializzati qui in Germania è qualcosa di importante.


Com’è stato crescere come palestinese in Germania? Nel giorno della Nakba a Berlino è stato lampante il livello di repressione nelle strade, ma sappiamo che c’è una repressione ben più nascosta che puoi sperimentare sin da bambino, ad esempio nel sistema scolastico tedesco.
A scuola impari a conoscere la Palestina attraverso il conflitto israeliano o dalle esperienze degli ebrei in Germania. Ma la Palestina esisteva anche prima. Quando ti viene chiesto da dove vieni – e ti viene sempre chiesto anche se sei nata qui, dato che non sei una tedesca bianca! – e rispondi: «Palestina», arriva la domanda: «Ma tu accetti Israele come Stato?»
La mia identità è stata quindi sempre in relazione con Israele. Sono cresciuta con questa costante interiorizzazione della narrativa dominante, con questo linguaggio prudente: «No, certo, non ho niente contro Israele». Negli anni il linguaggio è cambiato. Qualche anno fa non si sarebbe parlato di Israele come di un Stato di apartheid, nemmeno all’interno di molti gruppi palestinesi in Germania.
È stato difficile prenderne coscienza per creare poi una propria narrativa. E questo per me è stato possibile solo quando sono entrata in contatto stretto con altr* attivist* palestinesi. È stata un’esperienza di empowerment.
Hai la sensazione che la repressione nei confronti dei palestinesi sia aumentata rispetto al passato?
La repressione è diventata più visibile, non sono sicura sia aumentata. E se è più visibile è anche un segno che noi diventiamo più visibili e forti. Ma c’è sempre stata, in forme diverse.
Negli anni ’60 e ‘70 la diaspora palestinese in Germania era un centro di resistenza e di mobilitazione, con i suoi media e giornali, diverse forme di attivismo, con le sue organizzazioni – operaie, femminili ecc. – sotto l’egida dell’OLP e con una forte connessione con la sinistra tedesca. Poi questa resistenza fu inquadrata nella cornice del terrorismo di sinistra e cominciò il periodo di repressione.
Il processo di frammentazione è successivamente aumentato con l’istituzione dell’Autorità palestinese e la creazione dell’idea dei Territori palestinesi, che hanno spostato il fuoco e la mobilitazione lontano dalla diaspora. E con l’11 settembre, la repressione ha preso la forma della lotta al terrorismo islamico.

Ci sono poi altre forme di repressione. Non troverai ad esempio statistiche su quanti palestinesi vivono in Germania, sono categorizzati come «indefiniti» o contati come provenienti dai Paesi in cui si sono trasferiti, come il Libano o la Siria. Non poter contare le persone è un modo per renderle invisibili.
C’è poi la criminalizzazione degli spazi. Neukölln per esempio (quartiere a maggioranza araba e turca) è inquadrata come area in cui regnano clan criminali arabi, una forma razzista che criminalizza a prescindere le persone che ci vivono. Non è direttamente una forma di repressione contro la popolazione palestinese, ma una in cui le persone subiscono quotidianamente la violenza e la repressione della polizia. Il razzismo anti-palestinese interseca anche altre forme di razzismo, quello anti-musulmano e anti-arabo.
Com’è l’interazione con i gruppi della sinistra tedesca?
Da diversi decenni nella scena della sinistra tedesca sono emersi i cosidetti Antideutsche (sinistra antiautoritara pro-Israele) probabilmente gli attori più visibili e aggressivi che si mobilitano contro i palestinesi. Anche i partiti tradizionali della sinistra, sia a Berlino che a livello federale, inseriscono la questione palestinese nella cornice “antisemita”, così dominante all’interno del sistema politico tedesco. Ovviamente ci sono tanti gruppi diversi all’interno della sinistra ed è difficile generalizzare, ma rimane il fatto che è molto difficile costruire alleanze all’interno delle strutture tedesche dominanti.
La maggior parte della solidarietà proviene dai gruppi della sinistra migrante, specialmente qui a Berlino. Il che è qualcosa di positivo, perché troviamo intersezioni nelle forme di repressione diverse eppure simili a cui siamo soggetti – penso ai gruppi curdi, per esempio.
PS ha una posizione più intersezionale e internazionalista, più progressista rispetto ad altri gruppi palestinesi di oggi.
Sì, ma volte è difficile affermare che siamo internazionaliste o intersezionaliste, femministe o queer: è un processo di decostruzione di quelle gerarchie di potere che sono ancora basate sul genere e c’è ancora molto lavoro interno da fare.





Ma è già qualcosa rispetto a dire: «Prima liberiamo la Palestina e poi parliamo di femminismo». Ora i due punti procedono insieme.
La nostra posizione è che non c’è Palestina libera senza persone FLINTA (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und agender) libere. Non possiamo avere un sistema libero avendo delle gerarchie in gioco. Diversi tipi di liberazione devono andare di pari passo.
Qual è il legame tra le vecchie e nuove generazioni di palestinesi?
Non è facile generalizzare. Le generazioni più vecchie hanno più spesso forti legami con diverse frazioni dell’OLP e hanno una maggiore accettazione dell’Autorità Palestinese. Su questo c’è un conflitto soprattutto con le giovani generazioni cresciute in Palestina, che vedono l’Autorità Palestinese come un’estensione dell’occupazione e dell’oppressione. È una posizione critica che anche io ho imparato attraverso le loro esperienze.
Allo stesso tempo però dobbiamo riconoscere alle generazioni più vecchie i lunghi anni di lotta in un sistema repressivo, così che questo conflitto generazionale è anche qualcosa da cui possiamo imparare gli uni dagli altri e che dovremmo sfidare.
Come vi rapportate con le richieste dei palestinesi in Palestina?
Non crediamo nella narrativa della soluzione a due stati. Non vogliamo avere uno stato di apartheid, ma allo stesso tempo il futuro è qualcosa difficile da immaginare. Esistono molteplici idee e ci vorranno anche decenni per avere un processo in cui potremmo costruire delle soluzioni.
Anche all’interno di PS, che alla fine è un piccolo gruppo, siamo molto allineati su alcune posizioni, ma ci sono poi differenze quando arriviamo a parlare di come dovrebbero essere realizzate.
Oltre a questo, noi che non viviamo in Palestina abbiamo sempre un’idea costruita del nostro Paese, a volte romanticizzata. Ecco perché a volte è più facile per me concentrarmi sul contesto in Germania. Viviamo qui ed è qui che dobbiamo aumentare la consapevolezza e costruire alleanze.
Negli anni ’60 o ’70 era forse molto più facile, c’erano ideologie dominanti e posizioni più nette. D’altra parte penso che non avere una posizione dominante sia anche positivo, così da evitare di emarginare qualcuno. Dobbiamo imparare a lottare senza rischiare la frammentazione e i conflitti.
Il processo di “decolonizzazione” della Palestina è spesso ridotto a un’opposizione tra palestinesi e israeliani. Ma non dovrebbe invece essere inteso come un processo comune, in cui anche gli israeliani devono decolonizzare se stessi?
Esattamente. Da qui la nostra alleanza con Jüdisches Bund e Jüdische Stimme (gruppi di attivisti anti-sionisti di origine ebraica). È un processo che dobbiamo affrontare collettivamente con persone consapevoli della loro posizione. Dovremmo lavorare insieme per vedere la decolonizzazione non in chiave di separazione ma creando una narrazione comune. Dovremmo evitare le contrapposizioni in cui talvolta ci è capitato di cadere.

L’obiettivo principale è liberare la Palestina e decolonizzare sia la Palestina che Israele. Ma quali sono i passi per raggiungerlo?
La Palestina non è solo in Palestina: i palestinesi sono dispersi in tutto il mondo, in aree geografiche molto diverse. Quindi la decolonizzazione della Palestina non avviene solo in Palestina, ma ad ogni latitudine: anche qui e in tutti gli altri luoghi in cui i palestinesi sono enormemente repressi, emarginati e resi non visibili. Il primo passo è rendere più visibile la questione della Palestina e dei palestinesi. Penso che qualcosa stia cambiando, qui in Germania è una prova della nostra resistenza.
Avete richieste specifiche alla Germania?
Chiediamo alla Germania di non essere complice con lo stato di apartheid. Lo abbiamo visto chiaramente nel modo in cui ha represso le manifestazioni durante i giorni della Nakba. Tanti video testimoniano come il modo in cui le forze di sicurezza israeliane reprimono le lotte palestinesi sia lo stesso della polizia tedesca.
È un sistema interconnesso che non è possibile separare. Per questo anche lotta è interconnessa: i nostri discorsi sono influenzati dall’esperienza palestinese in Palestina, pur potendoci alla fine concentrare solo nel contesto in cui viviamo. Questo è il luogo dove puoi combattere. Impariamo dalla resistenza in Palestina come resistere all’oppressione qui.
Tutte le immagini di @Magda