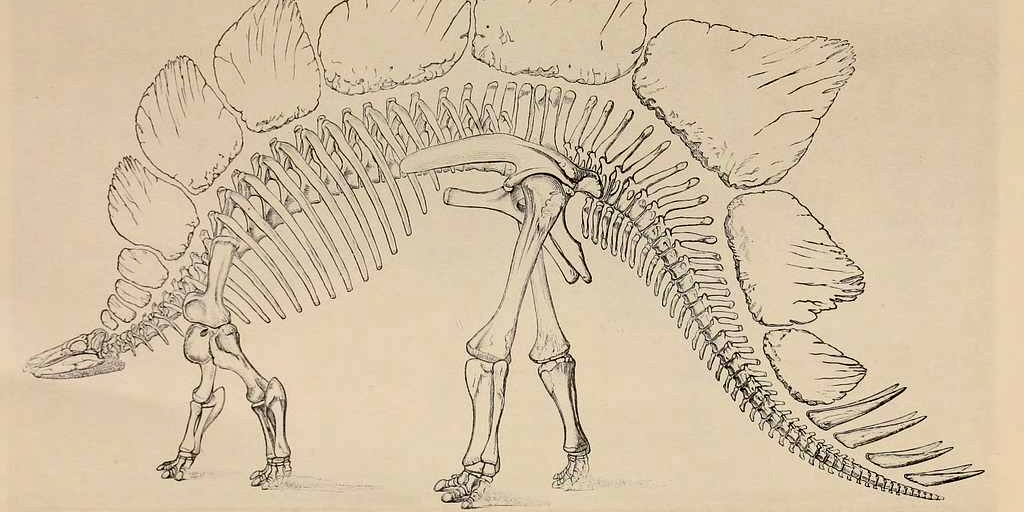MONDO

“Le persone devono sapere che i loro privilegi sono causa di sofferenza per molti popoli”
La colombiana Francia Márquez, leader sociale e paladina infaticabile dei diritti umani e della difesa dell’ambiente, è un esempio di lotta, ma anche del prezzo che deve pagare in Colombia chi si ribella: lo spostamento forzato o la morte. Ci spiega come nel suo paese continuano ad assassinare chi si oppone al saccheggio perpetrato dalle multinazionali. Il suo discorso, che nasce dalla schiavitù sofferta dai suoi antenati, segnala come la pace in Colombia non sia ancora arrivata.
La vincitrice del Premio Goldman – conosciuto anche come il Nobel per l’Ambiente –, donna afro e discendente di persone schiavizzate, condivide esperienze con la diaspora colombiana di Barcellona. Ascoltano in silenzio. Márquez è stata insignita con questo premio per la lotta contra l’estrazione mineraria illegale in Colombia. Anche la honduregna Berta Cáceres e il messicano Isindro Baldenegro hanno ricevuto questo riconoscimento, rispettivamente per la lotta contro il progetto idroelettrico Agua Zarza e il disboscamento irregolare della Sierra Madre Occidentale (Messico). Entrambi sono stati assassinati.
A migliaia di chilometri dal parche – così la popolazione colombiana chiama il gruppo di amici -, gli attentati ai leader sociali sono all’ordine del giorno. A due anni dallo storico accordo di pace tra le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia), il paese sta seppellendo i primi morti di quello che potrebbe diventare un nuovo genocidio nel paese
Perché vogliono farla finita con voi? Chi ci sta dietro questo massacro?
I miei antenati sono stati schiavizzati per poter realizzare il modello economico dello sviluppo. Se parliamo di commercio internazionale, la prima commercializzazione che c’è stata è quella delle persone. Li mercificarono, togliendoli il loro dono di essere umani e li trasformarono in cose. Oggi esiste lo stesso modello economico, pero basato sull’economia estrattivista che estrae risorse naturali dai territori in cui viviamo. Ormai non possono trasformarci in cose, ma ci scartano comunque. Per noi, questi territori non sono fonte di una ricchezza da accumulare, ma di vita per le prossime generazioni e ci opponiamo all’entrata delle multinazionali e al saccheggio. Per questo ci uccidono. In Colombia non stanno uccidendo le persone perché sì, ma perché difendiamo i diritti umani e attrverso questi difendiamo i diritti comuni. Il diritto a mangiare, a vivere in ambiente sano, all’acqua. A vivere tranquilli. Uccidono o costringono all’esiliano le persone perché fronteggiano un modello economico legato alla morte – l’estrazione mineraria per esempio – che, se uno guarda bene, è sempre lo stesso modello economico che abbiamo conosciuto nella storia. Punto. Mi hanno dichiarato obiettivo militare per essermi opposta all’entrata delle multinazionali nel mio territorio. Noi abitiamo quella zona dal 1636, quando deportarono i nostri antenati dall’Africa e, ora che abbiamo costruito una comunità e stabilito relazioni nel luogo, siamo diventati un ostacolo per lo sviluppo. L’Europa e il mondo devono ripensare le proprie forme di vita. Le persone devono smettere di consumare tanto, e devono sapere che i loro privilegi esistono grazie alla sofferenza di molti popoli simili al nostro. Quello che sta succedendo oggi con la migrazione africana non è gratuito: l’Africa è stata saccheggiata e violentata. Inoltre uno può chiedersi: da dove vengono le armi che in Africa fanno che la gente continui ad uccidersi? Quali sono le industrie che le controllano per fare in modo che le persone continuino a uccidersi? Quali industrie saccheggiano i territori e fanno soffrire la fame alle persone? Questi paesi che si dicono sviluppati devono cambiare la loro forma di vedere la vita, perché altrimenti noi continueremo a a morire e loro a godere dei loro privilegi che, a volte, non si rendono neanche conto di avere.
Non è la prima volta che l’Europa commette un genocidio in nome dello sviluppo. Lei dice che il conflitto in Colombia non riguarda solo gli ultimi 60 anni, ma che dobbiamo tornare indietro all’epoca in cui gli spagnoli invasero l’America Latina.
Questo conflitto ha subito un processo di degrado, però non può essere separato del conflitto storico. Per il popolo afrodiscendente, il conflitto non ha avuto inizio sessanta anni fa. Dalla colonizzazione, da quando ci deportarono dall’Africa all’America, abbiamo vissuto nella violenza. L’invasione spagnola ed europea dell’America, in un certo senso, generò le condizioni per cui in seguito le persone hanno deciso di cominciare l’insorgenza armata: la concentrazione della propietà della terra, la disuguaglianza, il razzismo strutturale… queste situazioni non sono recenti, cominciarono durante l’epoca coloniale. Si registrano le statistiche dei líderes sociales morti quest’anno, dimenticandosi di quelli degli anni precedenti. Questo mi sembra terribile. Si sta dimenticando, perdendo questa memoria. È successa la stessa cosa con la violenza storica: la violenza che importa è quella degli ultimi sessanta anni, però la violenza che viviamo come popoli etnici, afro-colombiani e indigeni, non importa a nessuno. Oggi si parla di misure di compensazione, di riparazione, per le vittime del conflitto armato però, come popolo afro-discendente e popolo indigeno, come potremo avere questa compensazione?
Come deve essere fatta questa compensazione?
Il primo passo da farsi è che questi paesi smettano di saccheggiare i nostri popoli. Mostrare una volontà di riparazione implica, per lo meno, smettere di distruggere i nostri territori. Sono le pressioni economiche che stanno uccidendo la nostra gente. Non immagino una compensazione economica in cui mi dànno dei soldi e finisce così. La riparazione deve ridarci la dignità che abbiamo perso come persone, perché ci hanno tolto il riconoscimento di essere umani. Deve essere la dignità umana, la vita degna, permetterci di vivere in condizioni degne nei territori nei quali siamo arrivati. Una riparazione degna deve permetterci di vivere in libertà come popoli afro-discendenti, come popoli indigeni. Permetterci di esercitare la nostra propria democrazia e non una democrazia imposta basata sul discorso dello sviluppo.
Il suo attivismo cominciò quando aveva solo 15 anni, per difendere il fiumi Ovejas. Si ottenne che il governo di allora non deviò il fiume verso la diga di Salvajina, cosa che avrebbe avuto un forte impatto sulla gente ed il medio ambiente. Cosa la portò a dire “fino a qui”?
Noi traevamo molti benefici dal fiume. Era tutto per noi e, da un momento all’altro, è stata costruita una diga. Unión Fenosa, una azienda spagnola, era la proprietaria della diga e voleva dirottare il fiume verso l’altra diga, la Salvajina, per aumentare la sua capacità produttiva. La comunità si oppose e io ho fatto parte di questa lotta. Salvajina ci aveva già procurato forti impatti ambientali, culturali, economici, di salute… e la gente disse di no. Così, semplicemente. Facevamo opere teatrali durante le riunioni e mi sono formata lì, riconoscendomi come una donna afro-discendente. Poco a poco ho acquistato fiducia e ho cominciato a partecipare ai processi organizzativi e comunitari. Nel 2014, con un gruppo di donne ci siamo mobilitate per denunciare come l’estrazione illegale stava distruggendo il nostro territorio, come l’estrazione costituzionale (vedi nota del testo originale), intesa come quella che il governo ha promosso senza nessuna previa consultazione durante il conflitto armato, concedendo diritti a terzi e negandoci il nostro diritto ancestrale sul territorio. Siamo partite in quindici e arrivammo in ottanta a Bogotá. Ci costituimmo in una organizzazione, la Mobilitazione di Donne Nere per la Cura della Vita e dei Territori Ancestrali.
Come donne abbiamo usato il nostro amore materno, lo stesso che usiamo per curare i nostri figli, utilizzandolo per curare il nostro territorio per le prossime generazioni. Oggi faccio parte del Processo delle Comunità Nere nazionale, una delle organizzazioni più grandi del paese che ha aiutato a creare la legge 70 del 1993, promuovendo il diritto alla consulta e al consenso precedente, libero e informato che, come popolo afro-discendente, dobbiamo avere ogni volta che un progetto o una legge ci possa danneggiare.
La lotta del 2014 portò con sé anche minacce di morte e lei dovette abbandonare la propria terra. Immagino che è impossibile riassumere o spiegare a parole gli effetti psicologici o affettivi che ha sofferto per questo spostamento…
Sono molti: sono cose che ti cambiano la vita. Si finisce a volte per abbandonare perfino la felicità, fino a smettere di vivere i propri sogni. Come persona, si finisce per mettere tutto nella lotta. Quando divenni una desplazada, sentivo come se il mondo mi stesse cascando addosso, che la mia vita ormai non aveva senso e che stava per finire tutto. Dovevo continuare a lottare per i miei due figli e per una comunità che stava vivendo un rischio. Non è un lavoro individuale di Francia, è un lavoro collettivo che è passato da generazione in generazione. A volta ho sofferto molte frustrazioni pensando che non ce l’avrei fatta, però ci sono stati altri momenti in cui ho avuto molta ispirazione e mi sono detto:” Si, bisogna continuare”. Mantenere la speranza è stato importante per me. Io amo la lotta. Credo nella giustizia per l’umanità, il territorio e il pianeta. Il mio appella va alla necessità di applicarla e di lottare per essa. Come esseri umani, siamo stati molto egoisti. Abbiamo distrutto il pianeta: la nostra casa. Bisogna ripensare a tutto c’ho.
Anche molti colombiane e colombiani che fanno parte della diaspora soffrono effetti psicologici e affettivi molto forti -soprattutto quelli che sul piano istituzionale sono considerati come illegali-. In questi giorni a Barcellona ha potuto parlare con alcune/i di loro. Come si possono tessere reti con in mezzo una distanza così grande?
Bisogna lavorare nell’educazione per la libertà, per l’autonomia e per la vita perché quella di oggi è una educazione per la morte. Quanta gente studia per mettersi al servizio della morte, delle multinazionali, violentando i diritti delle comunità? Discutiamo anche della condizione economica delle persone: come ripensare lo sviluppo per permettere che ci siano economie alternative. Abbiamo creato una strategia di articolazione iniziale, per cominciare, almeno, a comunicare.
Come desplazada a causa del conflitto armato, sei stata invitata a L’Avana per dialogare con i negoziatori del governo di Juan Manuel Santos e le FARC. Attualmente, fa parte del Consiglio Nazionale per la Pace e la Convivenza che è incaricato di vigilare sulla riconciliazione nel paese. Con quasi 400 líderes e lideresas sociales assassinati negli ultimi due anni, cosa sta non sta funzionando negli accordi?
La pace non è arrivata nei territori dove c’era violenza. Bisogna essere chiari rispetto al fatto che gli accordi de L’Avana si firmarono per la fine del conflitto armato come un passo importante per la pace, però non sono la pace in sé. La pace implica trasformazione sociale, chiudere le brecce della disuguaglianza e della iniquità, finirla con il razzismo strutturale. Implica finirla con queste modello di morte che ha fatto che alcune persone presero le armi. Se non si finisce con le ragioni per le quali si generò il conflitto armato, difficilmente raggiungeremo un processo di pace. Ora, le trattativa di dialogo con l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), perché il nuovo governo di ultradestra si sta opponendo. Ha vinto il governo che disse no alla pace e che non si sta impegnando nel rispettare gli accordi presi. Cosa significa ciò? Il ritorno della violenza nei territori. Ed è molto preoccupante perché, soprattutto al livello internazionale si dice che in Colombia sono stati siglati gli accordi di pace e che tutto va bene; ma la pace non è un foglio di carta. La pace è la fine di questa violenza e delle cause che la generano. Sono stata al parlamento basco e ne ho parlato con la presidentessa e mi disse «sul serio? Non c’è la pace in Colombia? Io pensavo che ormai vivevate in pace». Mi è sembrato ridicolo perché la pace non si fa con la firma d’un accordo, la pace implica azioni concrete. E sono queste azioni che il governo sta facendo fallire.
Se gli accordi non garantiscono la pace nei territori né la fine della violenza sulle comunità, chi può garantire la vita di queste persone?
Siete voi che dovete fare in modo che il governo si assuma la concretizzazione degli accordi e che generi condizioni di trasformazione che permettano di avanzare verso una pace reale. Abbiamo bisogna della pace per vivere tranquilli, non per continuare a generare povertà e esproprio delle terre. La comunità internazionale può giocare un ruolo importante: riconoscendo che la pace si consolida solo attraverso la giustizia sociale e in garanzie reali per le comunità. Bisogna anche sostenere gli accordi de L’Avana: è un passo molto importante che nei nostri territori ci sia un attore armato in meno .
Anche la Spagna di questo silenzio internazionale condannato da Márquez. Dal suo arrivo nella Casa Nariño (residenza presidenziale della Repubblica Colombiana) ad agosto, due rappresentanti politici molto distanti tra loro – per lo meno in apparenza – come Pedro Sánchez e José María Aznar sono andati a visitare il nuovo presidente colombiano Ivan Duque. Entrambi vedono in lui un garante per la pace. Niente è più lontano dalla realtà. Dal suo arrivo, gli assassinii contro i líderes y lideresas sociales sono aumentati vertiginosamente (soprattutto nel Cauca, territorio d’appartenenza di Márquez) e il suo mentore, Alvaro Uribe, fu a capo della campagna per il no agli accordi del 2016. Da molto tempo il nome di Uribe viene messo in relazione con il paramilitarismo, il narcotraffico, gli assassinii selettivi, i falsos positivos e la corruzione. Le ultime elezioni presidenziali in Colombia, le prime dopo la firma degli accordi di pace, hanno visto il ritorno dell’uribismo al potere. Per Márquez è stata la prima partecipazioni nella politica istituzionale. Dice che non ha mai creduto molto in se stessa e che non vedeva l’interesse nel convertirsi in una “politicante”. Ma lo ha fatto nel partito Colombia Humana, con Gustavo Petro.
Molti hanno pensato che Colombia Humana avrebbe vinto ma il cambiamento non è stato possibile. Comunque qualcosa si è mosso nella società colombiana. È stato piantato un seme in questi ultimi mesi?
Sì, senza dubbio. Io credo che stia delineandosi un cambiamento in Colombia. Prima d’ora nessun partito progressista aveva mai raccolto più di tre milioni di voti alle elezioni. La destra aveva sempre ottenuto molti voti ed è sempre stato così. Questa volta ha dovuto usare molti inganni e menzogne [il partito Centro Democrático è stato accusato di aver fatto circolare molte fakenews]. Nonostante questo, credo che la gente abbia smesso di credere in queste favole. C’è un movimento che sta riflettendo su una alternativa allo sviluppo, lottando per l’ambiente, per ottenere condizioni degne di fronte a situazioni di iniquità che hanno generato una dirigenza politica che dura da più di 200 anni. Colombia Humana ha perso, però c’è un movimento politico alternativo che sta crescando. Anche l’uribismo fu aiutato dall’ignoranza politica che ha seminato per molti anni per non fare pensare le persone in un cambiamento. Questo cambiamento arriverà.
Durante gli anni della schiavitù, le sue antenate disegnavano con tropas – fine trecce tessute sul cuoio capelluto – mappe che mostravano come scappare dalle fattorie degli schiavisti. Erano delle mappe di fuga, un codice occulto che permetteva agli schiavi di scappare. Come disegnerebbe oggi la mappa di fuga dalla Colombia?
Non credo che ci sia una mappa di fuga. Al contrario: stiamo resistendo per rimanere nei nostri territori. Il territorio è necessario alla costruzione della comunità afro-colombiana. Siamo parte della Colombia. Abbiamo costruito questo paese, ci abbiamo scommesso e l’unica cosa che vogliamo è poterci vivere degnamente e tranquilli una volta per tutte, però il razzismo istituzionale non lo permette. Stiamo resistendo con tutta la nostra forza per fare in modo che ci lascino esercitare un autogoverno, la nostra autonomia e pensare a come vivere bene. A volte dobbiamo usare i nostri corpi. A volte l’anima e lo spirito. Ci collochiamo in uno spazio che non ci fu regalato, che costò ai nostri antenati molti anni di sofferenze e lavoro. In questo senso, continuiamo a partorire la libertà del nostro popolo.
Articolo apparso sul sito pikaramagazine
Traduzione a cura di DINAMOpress