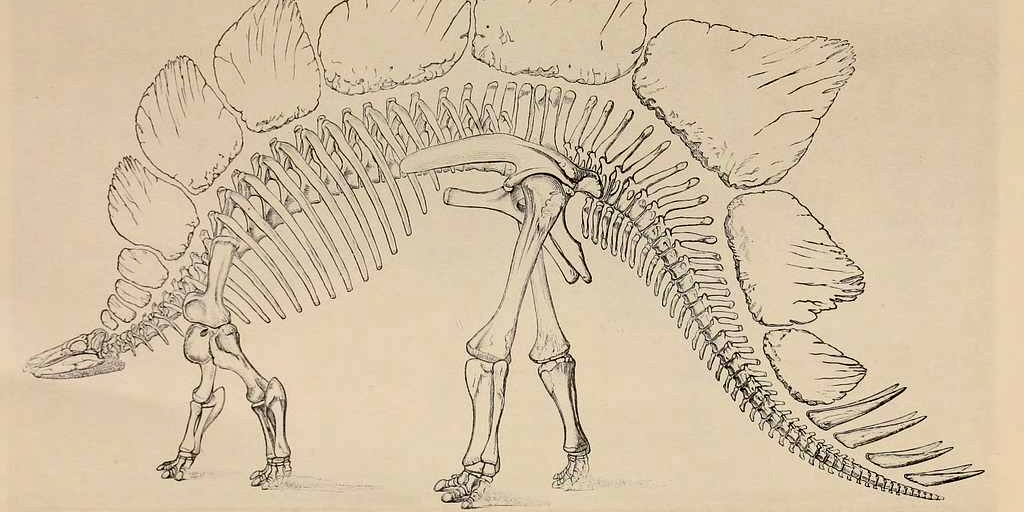L’Intrepido

Una storia patetica e uno spot di cattiva architettura.
Questa volta neanche Bigazzi ha potuto salvare la situazione. Quando sceneggiatura, regia e recitazione fanno acqua, la fotografia non basta a tenere a galla lo scafo. L’Intrepido è un film costruito su una formula: il nome Gianni Amelio, il nome Antonio Albanese, il nome Luca Bigazzi, una sceneggiatura imperniata intorno alla figura di un precario che rimpiazza il lavoro altrui – che consente la giustapposizione di tante scene eterogenee: l’incontro con il migrante nella cucina, con la vecchietta sul tram, con la ragazza depressa mentre pulisce lo stadio etc. –, e lo scenario di una Milano-città che sale, dei nuovi cantieri e dei nuovi grattacieli colti sul nascere. Ebbene, la formula non ha funzionato perché il personaggio disgraziato ma gentile e ottimista, uno pseudo-Charlot impregnato di retorica italiana della dignità dell’arrangiarsi, risulta patetico e imbarazzante, perché i comprimari e la trama sono inesistenti e l’insieme è una zuppa triste.
Non varrebbe neanche la pena di parlarne se non fosse per i surreali commenti apparsi qua e là di descrivere il film come una “visione” di Milano. È vero che allo spettatore viene offerta una massiccia dose di inquadrature impeccabili dei cantieri di Santa Giulia e Porta Nuova, le due case history immobiliari più eclatanti dell’ultimo decennio: la prima nota come esempio di desolazione per il fallimento di Zunino, la corruzione del sistema finanza-politica-real estate e una storia di false bonifiche, e la seconda pubblicizzata come operazione di grande qualità architettonica e successo economico, laddove nella realtà appare carente su entrambi i fronti. Tuttavia nel film questi palazzi, torri, gru, strade, cantieri, non sono altro che locations, al pari dei noti bar e ristoranti e di quei luoghi “vecchia Milan” che hanno fatto la fortuna di tanti speculatori immobiliari da quando esplose la moda delle case di ringhiera.
Non solo non c’è traccia di critica – e questo sarebbe il meno, perché nessuno pretende che i registi si trasformino in esperti di architettura e città – ma manca del tutto uno sguardo sulla città. Tornando ai toni lividi, grigio-blu, dei primi film di Soldini, Bigazzi riesce senza sforzo a uniformare una vista a volo d’uccello dal “Bosco verticale” (una delle torri simbolo del lusso di Porta Nuova) e le squallide ringhiere dei cavalcavia sopra i binari della stazione Garibaldi, il sottopasso della Chiusa di Leonardo in piena Brera e i ballatoi di un caseggiato multietnico in via Padova, il commerciale Corso Como, regno fino a poco tempo fa di Fabrizio Corona e l’allée deserta di Santa Giulia, ma la scelta di questi posti è pretestuosa quanto la sequenza degli inconcludenti episodi. Mentre scorrono le immagini viene naturale pensare agli accordi tra il regista e una di quelle istituzioni, le Film Commission, il cui compito è “promuovere sul territorio la realizzazione di film, documentari, fiction e ogni altra forma di produzione audiovisiva per aumentare la visibilità del territorio stesso e promuoverne l’immagine nel mondo”. Le Film Commission forniscono servizi come permessi, autorizzazioni, elenchi di maestranze e imprese locali, e soprattutto locations, in cambio di comunicazione, in base ai principi elementari del marketing territoriale. Molti o tutti i registi e produttori lavorano con le Film commission regionali, ma in assenza di un forte controllo artistico sull’opera i nostri film assomigliano sempre di più a spot di basso livello, pubblicità della caciotta locale e del folklore urbano. Il tempo e lo spazio delle pellicole tendono a prendere la forma rigida di videogallery, i contenuti vengono subordinati alla possibilità di mostrare quante più ville, paesaggi, locali, palazzi si riesca a stipare in 120 minuti.
Nel caso de L’Intrepido l’operazione è tanto più straniante perché l’oggetto della gallery è il prodotto della peggiore urbanistica ambrosiana, presentato da Amelio e Bigazzi in tono neutrale, alla luce di un benevolo accostamento di vecchio e nuovo e di un’indigeribile melassa di speranza. A ogni ripresa sembra di leggere un sottotesto di questo tenore: “che ci vuoi fare, Milano è fredda, ma a sapere cercare si trova la poesia”. Un po’ il contrario dello Stay hungry di Jobsiana memoria: incassa, incassa sorridendo, e forse andrà meglio. Sospendere il giudizio sulla città (e sul resto?), è questa la richiesta indiretta del film. Ci vuole coraggio, in effetti.