ITALIA
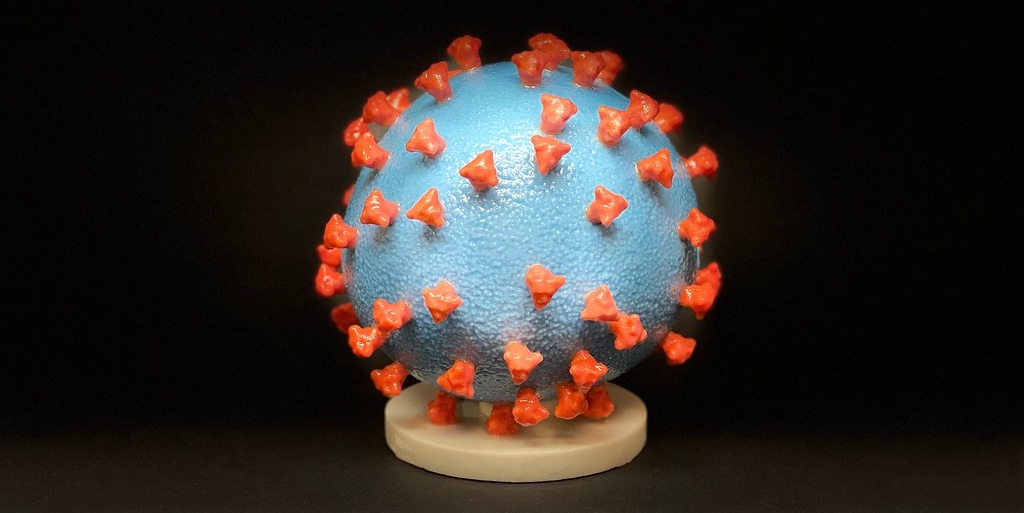
L’epidemia e il bisogno di costruire un pensiero sulla fragilità
Pensare la fragilità, la cura e la responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri richiede di abbandonare le narrazioni tossiche biopolitiche, abiliste e ideologiche
Ho letto due cose buone sul coronavirus. Uno è un articolo di Augusto Illuminati, Annotazioni marginali alle catastrofi, che parte dalla sua antipatia per il sapone antibatterico e compone un sapiente, informato ed elegante elogio dei batteri e della nostra convivenza con essi – gettando in cattiva luce, ovviamente, i virus, e implicitamente massacrando quell’uso teorico che si fa dei virus, in ciò che continua a essere, per inciso, una produzione della nostra soggettività, postumana o apocalittica che sia.
Il secondo scritto che mi ha dato la sensazione di tornare a respirare – a dire il vero precede il pezzo di Augusto – è di Chiara Bersani, che come dice il sottotitolo, ci racconta l’effetto che ha la «narrazione abilista di un’emergenza» su tutti quei soggetti che definiamo «deboli». Parla di un’occasione mancata: «Questo virus, il suo muoversi facilmente nel mondo, poteva diventare occasione per ricordarci che siamo umani e in quanto tali siamo fragili. Avremmo potuto accettare tutt* insieme che non siamo immortali, non solo noi soggetti deboli ma anche quel 40enne che sente l’eterna potenza scorrere nelle sue ossa. Sarebbe stato bello per una volta cercare un senso più nobile in un momento effettivamente speciale. Forse si sarebbe creato un precedente illuminato, forse la cura di sé e degli altri avrebbe veramente occupato per qualche tempo il centro del mondo. E siccome sto facendo un gioco di fantasia mi piace spingermi oltre e pensare che forse il capitalismo avrebbe tremato vedendo vacillare i suoi finti corpi immortali e prestanti».
È stato a partire da questo pezzo, arrivato come una freccia una mattina in cui non riuscivo a lavorare, in cui me ne stavo paralizzata di fronte allo schermo del computer, a metter in moto questo pensiero-esigenza che è «facciamolo», non è tardi – ed è l’unica cosa su cui vorrei che lei cambiasse idea – possiamo farne un inizio, anche ora.
Ho letto L’incubatrice mostruosa o Sars Wars Cov-2 di Angela Balzano, uscito su Dinamopress il 4 marzo. Nuovamente, il senso di una sconfitta immensa. Non era bastato il pezzo di Agamben, a suo modo deriso sui social (ha persino generato dei meme). È certamente una reazione al panico indotto dalla comunicazione schizofrenica delle istituzioni – ma su questo si poteva cominciare dicendo, cosa che ho appreso da un conoscente informato, che l’Italia, a differenza della Germania, per esempio, non ha alcun protocollo da attivare in situazioni del genere. Procedo: le strade si svuotano e compaiono, al nord, le camionette dei militari. È il bio-controllo, in cui siamo tutt* tenut* ad autodenunciarci al presidio medico-militare. Segue l’elogio del virus e della sua forma di vita. I virus sono organismi «capaci di cambiare il mondo […] contrabbandieri proteiformi», ovviamente la citazione è di Haraway e Balzano si augura che «torni familiare anche per l’umano», perché«siamo tutt* in bilico tra la vita e la morte e abbiamo tutt* bisogno di un intero mondo che ci ospiti per vivere e riprodurci».
La mia reazione è fortissima. Mi rendo conto che questo articolo tocca un tasto, che la mia reazione è emotiva. Non siamo tutt* in bilico tra la vita e la morte, io, per esempio, non lo sono. Ma il fatto è questo: mia padre ha un enfisema, mia madre si è ripresa ora da una polmonite, entra e esce dall’ospedale da settembre. Io dovrei andare oggi a trovarli, e sono due giorni che mi misuro compulsivamente la “febbre”. Ho 37.2: è febbre? Mia sorella mi dice che sono ipocondriaca, che quello che ho si chiama, banalmente, hangover. Neanche mia madre crede sia febbre, mi dice vieni, alla peggio, se ti metti a tossire, ti caccio. Ma ecco, sono nel loop della “misurabilità”, con tutto quello che comporta, e non so che fare. I confini tra corpo sano e corpo infetto non sono facili, sono invisibili. Si chiamano incubazione. Sono più difficili da decifrare di quelli tra corpo debole, fragile, e corpo potente, forte. E mischiano le categorie, formano un chiasmo: chiamano in causa gli effetti che ha il mio corpo sano su un altro corpo che è fragile.
Penso: sono corpo sano nella fragilità che non è la mia ma in cui sono immersa. E questo, mi sembra un modo per pensare la maniera di stare in questa relazione così difficile.
In questa difficoltà pensare che tutto sia biopolitico, o bio qualcosa, non mi aiuta. Non mi aiuta pensare che lo Stato stia usando il virus per renderci più tristi. Non mi aiuta una chiamata a resistere, ad attraversare comunque le piazze e i luoghi pubblici infettandoli – con riferimento ai cortei che NUDM ha annullato. Balzano scrive: «so che ci sono migliaia di corpi indisposti a rinunciare a quella botta di endorfina che innescano gli incontri in strade liberate, corpi su cui non attecchisce alcuna revoca, che si sono resi immuni al controllo», e via dicendo. Il tono è entusiasta, ottimista, direi esaltato. E mi ritrovo per l’ennesima volta a fare un pensiero, che ultimamente faccio spesso: penso infatti che pensiamo troppo, che abbiamo letto troppo, studiato troppo, che ci siamo armati di discorsi che poi ci rendono difficilissimo entrare in contatto davvero con la realtà, un contatto che spesso è una frattura, un pezzo di dolore, qualcosa che manca, o che è andato male.
Mi viene in mente una battuta che io faccio spesso ai miei amici lacaniani: ma con tutto quel fardello, con tutta quella teoria, come fa a lavorare un analista lacaniano? Ovviamente è una battuta ironica e allo stesso tempo una mia curiosità reale, di sapere cos’è che in fondo fanno. La uso perché trovo sia un’immagine e mi aiuta a formulare un dubbio. Ho la sensazione che a volte facciamo precedere i discorsi al sentire, e siamo spaesati di fronte a tutto quello che non riusciamo ad anticipare, prevedere, rassicurare. Che ci sono eventi che finiscono per essere usati come conferme, auto-conferme. Io personalmente qui dentro mi sento scissa. Un ottimismo come quello che ho trovato in questo articolo cancella pezzi interi di realtà, o meglio tratta questa realtà come un blocco, qualcosa da cui, nel nostro “antagonismo” è possibile stare fuori. A chi esattamente stiamo dicendo «non ci avrete»? Io questo soggetto non lo vedo.
Nel mio palazzo ho lanciato un’idea: scrivere. Usiamo una chat e abbiamo deciso di elaborare una sorta di decalogo, delle regole belle che ci aiutino ad affrontare insieme la situazione, che significa in sostanza parlare di quello che questa situazione significa per ognuno di noi e aiutarsi.
Io penso ai miei genitori, il mio coinquilino non riesce a guadagnare abbastanza, la mia vicina ha un sistema immunitario compromesso, poi c’è chi non può partire, e via dicendo. Il mio coinquilino voleva mandare il figlio in Calabria, ora che le scuole sono chiuse, a casa di parenti. Ha riflettuto con la madre, hanno capito che non è una buona idea. Mi ha detto che Cosenza ha più o meno 200 mila abitanti, l’unico ospedale che hanno è l’Annunziata, che ha 40 posti in rianimazione, e poi c’è il nulla. Ora, a fronte di una considerazione che io trovo giusta, che è in sostanza “non ammalarsi per non far ammalare gli altri”, cosa me ne faccio dell’idea dell’«auto-controllo biomedico»? Cosa me ne faccio dell’idea che l’ospedale è un “istituto disciplinare” quando a mia madre, in ospedale, è stata da poco salvata la vita? Mi viene da pensare che chi può limitarsi a ripetere Foucault, come se bastasse davvero questo per fare fronte a una situazione che è oggettivamente faticosa, non ci ha mai messo piede in un ospedale – per altro europeo, dunque accessibile, gratuito, pubblico.
C’è un ottimo articolo di Simone Pieranni sul “Manifesto” che anche parla di potere. Eppure lo fa informando – parla della Cina, di cui tendiamo ad avere un’idea sbagliata, preconcetta. Gli editoriali (le opinioni) non possono sostituire l’informazione e le ingiunzioni a un ottimismo sfrenato e cieco non servono a niente e a nessuno. Giusto manifestare la propria presenza disobbediente come si è fatto nei flash mob del 6 ma senza enfatizzare, in questa particolare circostanza, lo scrollarsi di dosso la trama di relazioni e di cura in cui siamo immesse.
Più che alla legge del padre io penso a mio padre reale, a casa, in difficoltà, con una forma di demenza che lo confonde, che l’ha trasformato in bambino, improvvisamente. No, non ci penso neanche un secondo a lasciare mio padre a casa da solo e, non-febbre permettendo, starò a casa con lui.
Certo che mi prenderò cura di lui senza espormi gratuitamente, perché io ci tengo a che lui sia e rimanga vivo e io cercherò di non ammalarmi per questo. Tutto ciò è ideologia, e credo sia offensivo, e ignorante, nel senso letterale di ignorare tutto ciò che non serve la causa della forza, del “nostro” (di chi?!) sentirci forti. E tutto ciò m’induce a domandare: è possibile che questo tipo di discorso, che la “teoria” in generale, che è quel luogo in cui è stata prodotta intelligenza bellissima e necessaria, ma anche il luogo in cui ci rintaniamo perché qui siamo bravi, sia addirittura diventato qualcosa a cui ci rivolgiamo per non dover guardare, vedere, tutto quello che non ci torna? Ovvero, quello che ci fa sentire impotenti. Lo dice Mark Fisher molto meglio di me, in Scritti politici. Il nostro desiderio è senza nome, uscito da poco in italiano. Invita a rileggere Marcuse, per fare i conti con il negativo, a stare attenti non a Spinoza, Deleuze, Negri, ecc., i suoi autori di riferimento, ma al modo in cui sono stati usati.
Mette in guardia contro un vitalismo che è stato in realtà già appropriato dal capitale: che è infinita potenza, volontarismo magico, in un’epoca in cui, piuttosto, è diventato urgente pensare il limite, la misura, la natura finita dei corpi e delle risorse. Ecco, non saper stare in tutto ciò che ci sfugge (nel negativo, come dice lui) si trasforma in una sorta di delirio di onnipotenza, che non fa bene, e che non ci aiuta di certo a sconfiggere quello che ci fa male. Anzi, crea nemici dove non ci sono, crea fronti e sensi di appartenenza che si producono per differenziazione, che sono privi di compassione, di sentire, di possibilità reali di stare dove qualcosa fallisce, viene meno.
Mi ha suonato il vicino per chiedermi il termometro, per la sua compagna, che ha la febbre. Di termometro ne abbiamo uno nel palazzo e ce lo passiamo. Sta cucinando, mi porterà il pranzo. Lui è guarito. La settimana scorsa mi è capitato di cucinare per lui.
Andremo avanti così. Il mio coinquilino è uscito per fare il giro dei clienti, ristoratori, che lo devono pagare. Sappiamo entrambi che tornerà con poco. Quando avrà finito i soldi la spesa la farò io, ho pensato, che ho più soldi di lui. Mi ha detto stamattina che potersi fermare è bello, anche nella difficoltà che questo comporta. Ma non ha usato nessuno slogan, nessun hashtag, non si è detto forte, anzi, ci siamo detti fragili, e abbiamo ribadito il desiderio che abbiamo di farla insieme, la nostra fragilità, spiegandocela, facendo in modo che piano piano, nei giorni, diventi una cosa che possiamo dire, con parole che per adesso ancora non ci vengono.




