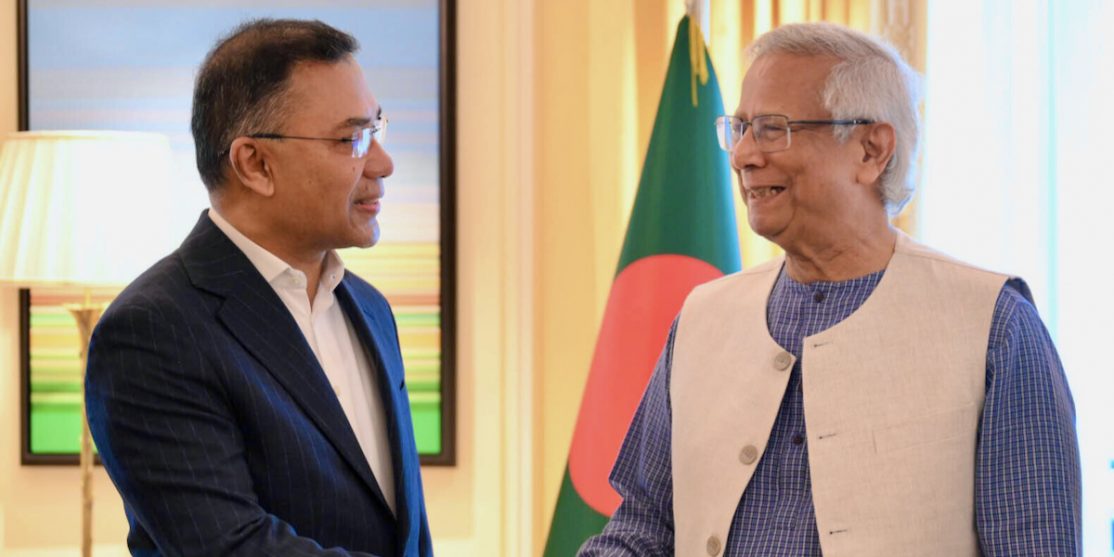MONDO
Israele ha ancora tutte le carte in mano

La quiete relativa sul campo, in anni recenti, rafforzata dalla Autorità Palestinese che ha lavorato per conto di Israele, ha portato gli israeliani a credere di poter godere di pace e prosperità senza mettere fine all’occupazione.
Tredici anni sono trascorsi tra la Prima Intifada, esplosa nel Dicembre 1987, e l’inizio della seconda, ad Ottobre 2000. Entrambe le intifade sono durate per circa 5 anni. Sono passati 15 anni dall’inizio della Seconda Intifada, e 10 dalla sua conclusione.
Se la storia e l’esperienza ci insegnano qualcosa, le tempistiche sono giuste per l’arrivo di una nuova generazione di giovani Palestinesi che motivati ad affrontare Israele – come fecero i loro fratelli maggiori, e prima di loro, i loro genitori. Questa teoria regge anche guardando il profilo di coloro che portano avanti gli attacchi armati di coltello, e che prendono parte alle manifestazioni in questi giorni: la maggior parte è al di sotto dei 20 anni.
Gli eventi delle scorse settimane non sono un’intifada. Attacchi e manifestazioni contro simboli e target israeliani, civili o militari, ci sono sempre state dall’inizio degli anni ‘70 con frequenza variabile. Al contrario, le intifade erano contraddistinte da un sollevamento (come dice la parola stessa N.D.R.) determinato da una mobilitazione trasversale di quasi tutta la società palestinese e delle sue istituzioni (anche se la Seconda Intifada è divenuta presto una lotta armata portata avanti da un numero relativamente piccolo di militanti).
La situazione attuale è diversa. Anche Netanyahu si è visto forzato ad ammettere che l’Autorità Palestinese non sta prendendo parte alla mobilitazione attuale. Gli scontri sono concentrati a Gerusalemme Est, che è sotto diretto controllo israeliano, e non in West Bank. Ciò spiega perché Israele farà qualunque cosa per prevenire il collasso dell’Autorità Nazionale Palestinese, impedendo quindi un ritorno alla situazione pre-Oslo, come invece un certo numero di demagoghi della destra israeliana sta chiedendo in questi giorni. L’Autorità Palestinese, in funzione di contractor per la sicurezza di Israele, è ben più efficiente nel mantenere la pace di quanto non siano mai stati lo Shin Bet (servizi segreti) o l’IDF (esercito). Israele se ne sbarazzerà quando avrà smesso del tutto di svolgere questo ruolo.
La strategia internazionale dell’OLP è collassata
L’Autorità Palestinese è un’istituzione insolita. Una enorme parte del suo budget – si dice il 25% – è dedicata alla sicurezza. Non a rendere sicuri i palestinesi, quanto piuttosto gli israeliani. Ai poliziotti palestinesi è vietato infatti proteggere gli abitanti dei villaggi palestinesi dagli attacchi dei coloni. Per farlo, devono chiamare la polizia israeliana.
Nello scorso decennio, l’Autorità Palestinese ha assunto per sé il ruolo di contractor dell’occupazione israeliana, con la convinzione che la calma in West Bank avrebbe creato le condizioni richieste per il progresso nei dialoghi di pace con Israele. Questo almeno è quanto si è sempre promesso ai palestinesi: se la violenza ha fine, vi parleremo e avrete il vostro stato.
Ma è ora chiaro che la dinamica è esattamente all’opposto. La calma sul terreno fa credere agli israeliani che possono godere di pace e prosperità senza mettere fine all’occupazione. Il tragico paradosso è che furono le intifade a portare alle concessioni (gli accordi di Oslo, il ritiro da Gaza) mentre gli anni di pace hanno portato a posizioni israeliane più radicali e all’espansione delle colonie. In settimane come questa è triste ricordare il subbuglio che creò Netanyahu richiedendo che Abbas riconoscesse Israele come uno “stato ebraico” e non solo come “lo stato di Israele”, come se Israele avesse bisogno di Abbas per definire la sua identità. State tranquilli, se Abbas avesse riconosciuto Israele come stato ebraico, Netanyahu si sarebbe inventato qualcos’altro da chiedere. Qualunque cosa pur di non raggiungere un accordo.
Quando la leadership dell’OLP comprese che non avrebbe raggiunto nessun accordo con Israele, ha scommesso nella ricerca di una pressione internazionale – prima dagli Stati Uniti, e poi dall’Europa. Il fatto è che Washington non farà mai una pressione seria su Israele. Se si confronta l’impegno statunitense per raggiungere l’accordo con l’Iran, con il suo floscio approccio alla questione palestinese, la realtà delle cose appare ad un tratto chiara. L’accordo con l’Iran era una questione di interesse statunitense per l’amministrazione Obama. Il conflitto israelo-palestinese era poco più di un fastidio.
I drammatici sviluppi nel mondo arabo, in particolar modo in Siria, sono il requiem della strategia palestinese. La Siria è passata dall’essere la guerra tra Iran, Turchia e Arabia Saudita, agita per interposta persona, ad essere quella tra Stati Uniti e Russia, con conseguenze enormi per tutta la regione ed oltre. Se non bastasse questo, ora gli statunitensi sono preoccupati della stabilità della Giordania. In queste condizioni, la strategia israeliana di rafforzare e mantenere lo status quo nei territori occupati appare all’improvviso ragionevole per gli Stati Uniti. Hillary Clinton, che è ancora considerata la favorita alle primarie democratiche, ha detto la settimana scorsa che il conflitto israelo-palestinese dovrà probabilmente aspettare, ed è chiaro che a nessun candidato repubblicano verrà mai mente di fare pressione su Israele per mettere fine all’occupazione. La strategia internazionale dell’OLP è completamente collassata quest’anno, ed Abbas non ha mai avuto un piano B.
Un conflitto per una parte
Non so a quanti giovani palestinesi che protestano in West Bank e a Gerusalemme Est importino le considerazioni geopolitiche generali. Quello che è assolutamente chiaro è che negli ultimi due di anni gli sviluppi diplomatici non hanno generato altro che totale sconforto nei territori occupati. E’ qualcosa che ho sentito da ogni palestinese con cui ho parlato, un’incapacità perfino di immaginare quale catena teoretica di eventi potrebbe un giorno portare con sé la fine dell’occupazione. In queste circostanze, qualcuno continua la sua vita quotidiana a Ramallah o Jenin, che si sono riprese un po’ nell’ultimo decennio, mentre altri sono pronti a fare scelte disperate.
Agli israeliani piace parlare di “incitamento alla violenza” nei territori occupati. Ciò offre una spiegazione confortevole alla violenza che esplode di quando in quando. La percezione israeliana di stare dalla parte del giusto è rafforzata dalla sensazione che i palestinesi sostengano la violenza, e che dal lato israeliano si desiderino solo la pace e la quiete – un po’ di normalità, commerci, la rimozione di un po’ di check point qua e là come segno di buona volontà.
Ma la situazione, ovviamente è del tutto diversa. I palestinesi sono sempre soggetti alla violenza dell’occupazione, che è ogni giorno arbitraria, mentre gli Israeliani per lo più godono di calma e prosperità. Il conflitto israelo-palestinese, la maggior parte delle volte esiste solo ed esclusivamente per una parte.
I palestinesi sono prigionieri nella loro stessa terra. Non possono muoversi liberamente, non possono entrare o uscire dal loro paese. Ricevere visite dipende dalla buona volontà del regime militare israeliano. Lo stesso accade per mantenere le strade aperte e costruire nuovi quartieri o anche singole case. Sono interamente dipendenti dalla buona volontà di Israele per proteggersi dagli attacchi dei coloni, mentre l’esercito israeliano non ha mai visto la protezione della popolazione palestinese come parte della sua missione all’interno dei territori palestinesi. Sono giudicati in corti militari, possono essere imprigionati senza colpa o processo, e molto altro ancora. E, ovviamente, non hanno diritti politici come votare o essere rappresentati politicamente.
La politica è sempre stata un sostituzione della violenza nella gestione di relazioni tra popolazioni differenti, e coloro che non hanno diritto a partecipare in politica, arrivano presto alla conclusione che non hanno a loro disposizione nient’altro che la violenza. Anche se ogni post sui social contro Israele, gli ebrei o i sionisti fosse cancellato da internet, la violenza continuerebbe. Allo stesso modo, anche smantellando ogni singolo organo e rete di Hamas, essa non smetterebbe di crescere di nuovo.
Dobbiamo ricordarcelo sempre: l’occupazione è la massima infrastruttura terroristica. Bisogna essere del tutto ciechi per pensare che quell’estrema disuguaglianza e più di mezzo secolo di oppressione avrebbero portato ad un risultato differente. Non dobbiamo neppure illuderci del contrario: finire l’occupazione potrebbe non portare la pace, di certo non a breve termine, ma continuarla porterà di sicuro ad una guerra civile, di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio questa settimana. E’ vero, non è la Siria né la Yugoslavia. Non si avvicina neppure. Ma anch’esse non erano la Siria e la Yugoslavia prima della guerra civile. La situazione in Israele – due popolazioni mescolate che hanno prospettive a somma zero, e in cui una ha tutto il potere e i diritti e l’altra ha solo briciole – rimane il problema fondamentale.
In quel contesto, il fenomeno più preoccupante questa settimana è stata la violenza spontanea da parte di cittadini normali, da ambo le parti. Parte della ragione sta nel fatto che entrambe le parti sono esposte solo al terrore prodotto dall’altro. Gli ebrei hanno visto il video di Adelle Bennett che urla chiedendo aiuto, ricevendo solo scherno dai commercianti a Gerusalemme Est. Gli arabi hanno visto la folla rincorrere Fadi Alloun – uno di coloro che sono stati accusati di essere gli aggressori armati di pugnale a Gerusalemme – finché la polizia non lo ha ucciso a sangue freddo. Forse c’è un’altra spiegazione per la giovane età degli aggressori: sono loro i più esposti ai social media, dove tutti i video e i racconti stanno circolando.
La pace ha un prezzo
La cattiva notizia ha due aspetti. Primo, è molto più difficile raggiungere soluzioni politiche in assenza di strutture di potere centrale. Secondo, in tornate precedenti ci sono voluti quattro o cinque anni di reciproco spargimento di sangue – nel quale Israele ha pagato un prezzo pesante, e i palestinesi uno molte volte maggiore – finché si creasse un consenso in Israele, intenzionato a considerare l’idea di concessioni reali (Oslo e il ritiro da Gaza). Non c’è prospettiva per una soluzione temporanea o permanente al momento. Non c’è sostegno pubblico e non ci sono politici che vadano in quella direzione.
Il leader dell’opposizione Isaac Herzog questa settimana ha chiesto che il governo metta tutti i territori occupati sotto assedio. Una punizione collettiva che non ci porterebbe neppure di un metro più vicino ad una soluzione, né militare né diplomatica. Il ministro Naftali Bennett ha proposto di costruire ulteriori colonie in West Bank. Il precedente ministro degli esteri Avigdor Liberman ha chiesto pubblicamente di vendicarsi sugli arabi. Yair Lapid ha proposto di attivare una politica da “tagliaerba” (dio solo sa cosa questo voglia dire) e ha espresso sostegno ai coloni che vivono nei quartieri arabi di Gerusalemme Est. Netanyahu sembra il più razionale e a mente fredda, in mezzo a tutti quelli che vogliono toglierlo dal trono, ma è chiaro che non sarà certo lui che ci porterà ad alcuna svolta significativa.
E comunque in nessun modo si può giustificare la sensazione di scoraggiamento e vittimismo che si sente per le strade israeliane in questi giorni. La nostra situazione attuale non è una “tragedia” quanto piuttosto una realtà verso cui marcia ad occhi sbarrati l’attuale leadership politica israeliana, con il sostegno della gran maggioranza di voti ebraici.
Le carte stanno ancora nelle mani di Israele, e hanno un gran potere. Israele può iniziate colloqui di pace con semplici gesti. Può anche decidere con chi: Fatah o un governo di unità palestinese. Può costruire una coalizione internazionale che sostenga la trattativa – dai paesi arabi, alla Turchia, Russia, gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La nostra è una delle poche questioni al mondo per cui tutti questi stati sarebbero felici di cooperare.
Israele può mettere fine al suo regime militare in West Bank. In breve, Israele ha una ampia gamma di strumenti in mano che, nel medio/lungo termine potrebbero modificare in modo fondamentale le relazioni tra ebrei e arabi in questa terra. Ma fare questo porta ad un prezzo: mettere fine alla costruzione di colonie, liberare prigionieri, e tutti gli altri passi che non solo la leadership politica, ma anche la maggior parte della popolazione ebraica di Israele rifiuta in questo momento.
*L’articolo in originale si trova qui all’interno di www.972mag.com, portale israeliano di informazione alternativa ed indipendente.
Traduzione di Riccardo Carraro