cult

CULT
The Best of 2017. Le serie TV
Il 2017 per la serialità televisiva verrà ricordato senz’altro come l’anno di Twin Peaks, un evento che ci poteremo dietro ancora per molto. Ma c’è stato anche il ritorno di David Simon, la prima grande produzione europea con Babylon Berlin, e il successo di Handmaid’s Tale tratto dal romanzo di Margaret Atwood. Ecco tutte le serie tv che abbiamo amato di più nel 2017
 10. She’s Gotta Have It
10. She’s Gotta Have It
di Spike Lee (Netflix)
31 anni dopo Lola Darling, Spike Lee torna con un reboot Netflix in 10 puntate al suo capolavoro d’esordio. E Nola, questo il nome originale della protagonista, non è diversa da come era nel 1986: libera ed emancipata, viva la sessualità divisa tra il responsabile Jamie, il narcisista Greer e l’immaturo Mars. Persino alcune battute sono le stesse del film, e funzionano altrettanto bene oggi di quanto funzionassero allora. Quello che è cambiato è Fort Greene, il quartiere di Brooklyn dove è ambientata la serie, che non è più popolare e black come era negli anni Ottanta, ma è attraversato da un processo di gentrification. She’s Gotta Have It però non è solo un’efficace riflessione sulla sessualità contemporanea, sulla libertà femminile o sulla pervasività della linea del colore in America, ma è anche una messa in forma d’immagine della meta-riflessività della cultura urbana di oggi, di chi vive la propria vita all’interno di una costante rappresentazione del proprio sé. Spike Lee abbonda con sguardi in macchina, incursioni “meta”, e persino l’idea di mostrare le copertine degli album che sentiamo durante le puntate dando l’impressione di una narrazione espansa che però non manca della forza delle sue opere migliori. (Pietro Bianchi)
 9. Tin Star
9. Tin Star
di Rowan Joffe (Amazon)
Tin Star è una serie televisiva britannica del 2017 diretta da Rowan Joffé, interpretata da Tim Roth, alcolizzato detective inglese sotto copertura trasferitosi in un piccolo paese del Canada dopo una tragedia che viene svelata solo alla fine, inseguito da criminali che vogliono vendicarsi con qualche ragione. Una vera tragedia elisabettiana in cui gli uomini si sterminano a vicenda e sopravvivono solo le donne che perdonano, le splendide Abigail Lawrie (la figlia), Genevieve O’Reilly (la moglie) nonché la Christina Hendriks di Mad Men, nel ruolo ambiguo dell’emissaria di una compagnia petrolifera che si serve di quei criminali per i propri progetti estrattivistici. È interessante sia il doppio registro territoriale (l’Eden minacciato della provincia canadese di Alberta e la periferia inglese), sia la cruda ambivalenza dei personaggi fra bene e male: non ci sono innocenti e il destino la fa da padrone, al punto che spesso la chiusa di un episodio è esposta al suo inizio. (Augusto Illuminati)
 8. Babylon Berlin
8. Babylon Berlin
di Tom Tykwer, Achim von Borries e Hendrik Handloegten (Sky/ARD)
Ambientata a Berlino nel 1929 ne è protagonista l’ispettore di polizia Gereon Rath (V. Bruch), trasferito alla capitale da Colonia per far luce su un ricatto sessuale volto a screditare l’allora borgomastro (e futuro Cancelliere post-bellico) Adenauer. Rath indaga negli ambienti criminali e della nascente industria cinematografica pornografica, con l’aiuto di una ragazza molto autonoma, in bilico fra prostituzione di lusso e desiderio di entrare come detective in polizia, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). Il noir si intreccia con le vicende reali della declinante repubblica di Weimar (la sanguinosa repressione anti-comunista del 1 maggio 1929), all’immaginaria congiura per deviare un treno carico d’oro dall’Unione Sovietica a Istanbul dove era esule Trockij, con le trame militariste e naziste – il tutto sullo sfondo della brillante e nichilistica cultura degli anni d’oro di Berlino. Perfezione dei dettagli e della ricostruzione scenografica (la Alexanderplatz senza torre televisiva), mix teatrale di storia e contro-storia e squarci contro-culturali (i numeri di cabaret) contrassegnano un modello “europeo” di serial che si contrappone, con pregi e difetti, a quello Usa. (Augusto Illuminati)
 7. Big Mouth
7. Big Mouth
di Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackettuth (Netflix)
“A show about a bunch of kids masturbating?” “Isn’t that basically like child pornography?” “Maybe, if it’s animated, we can get away with it.” La distanza garantita dall’animazione, così come la trovata di delegare agli immaginari Hormone Monsters (sorta di personificazione furry dell’Es) gli impulsi meno socialmente informati, consentono a Big Mouth di raccontare il disagio e l’imbarazzo che accompagnano l’avvento della pubertà con onestà brutale e abbondante volgarità ma allo stesso tempo – e sarebbe bene non stupirsene troppo – con una sensibilità estremamente empatica nei confronti dei protagonisti. Consapevolezza morale, rispetto e confronto con l’altro sembrano dati per acquisiti, ma l’esperienza e la capacità di gestire le situazioni emergono solo al costo di errori e conflitti. Big Mouth è l’educazione sessuale che tutti vorrebbero/dovrebbero ricevere. (Elisa Cuter)
 6. Master of None (seconda stagione)
6. Master of None (seconda stagione)
di Aziz Ansari e Alan Yang (Netflix)
Aziz Ansari aveva raggiunto una moderata notorietà come comico di seconda fila in Parks and Recreation e in diversi film prodotti e diretti da Judd Apatow, ma il suo ruolo non era mai andato oltre quello del ragazzino indiano, petulante, logorroico e con la battuta pronta. Il suo primo show da protagonista e scrittore non è niente di tutto questo: Master of None, è uno show personale e profondo, che ha anche un’inaspettata vena drammatica ma che soprattutto può vantare una naturalezza nella scrittura inedita per la televisione di oggi. Questa splendida seconda stagione poi inizia col protagonista che va a “smaltire” una delusione amorosa a Modena, e le prime 2 puntate sono girate in Emilia, con parte del cast italiano e con Aziz Ansari che si cimenta in una zoppicante ma credibilissima parlata italiana. C’è persino una puntata in bianco e nero, tributo al neorealismo e a Vittorio De Sica, ma dove invece delle biciclette, viene rubato… un cellulare. (Pietro Bianchi)
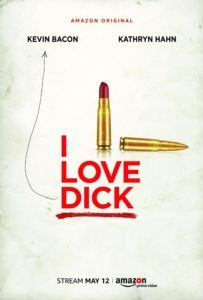 5. I Love Dick
5. I Love Dick
di Sarah Gubbins e Jill Soloway (Amazon)
La serie di Jill Soloway è a tutti gli effetti uno stato dell’arte sui rapporti di genere. Sotto forma di dramedy, fotografa con precisione chirurgica e a tratti dolorosa le dinamiche del desiderio (in primis quello femminile) e il modo in cui queste si intersecano con i rapporti di potere (in primis quelli del mondo dell’arte e dell’accademia statunitense). Senza fare sconti a nessuno, trasportando nel presente il triangolo tra lei, lui e l’altro raccontato nel romanzo di culto di Chris Kraus da cui prende le mosse, opera un ribaltamento delle dinamiche genderizzate dell’ossessione erotica e della sua rielaborazione attraverso l’arte, interrogandosi sull’opportunità di un female gaze nel cinema. (Elisa Cuter)
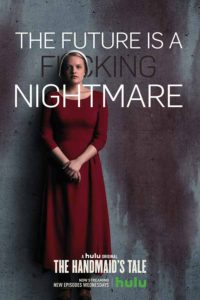 4. The Handmaid’s Tale
4. The Handmaid’s Tale
di Bruce Miller (Hulu)
‘Prima ero addormentata. Quando hanno preso il Congresso non ci siamo svegliati, quando hanno detto che era colpa dei terroristi e sospeso la Costituzione, non ci siamo svegliati. Ora sono sveglia’. Queste le prime parole del trailer della serie The Handmaid’s Tale, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Margarete Atwood del 1985. Uscito nell’aprile del 2017 negli Stati Uniti, pochi mesi dopo le elezione di Trump, questa serie è risuonata non tanto una visione distopica del futuro, ma un riadattamento possibile del presente. Gli Stati Uniti diventano uno stato teocratico – la Repubblica di Gileard – sotto la guida degli eletti. Secondo gli eletti, il mondo è stato punito per i propri peccati attraverso l’infertilità, per questo è necessario ritornare alla vita tradizionale. Punire i gay, distruggere l’indipendenza delle donne, e riportarle al loro ruolo di angeli del focolare, rinchiudendole dentro casa. E coloro le quali hanno ancora il sacro dono della procreazione diventano le schiave degli uomini eletti, affinché possano mettere al mondo nuovi figli per la Repubblica. Queste sono le ancelle, vestite di rosso, non appartengono più a se stesse, il loro corpo è dei Comandanti, i loro figli saranno delle mogli dei comandanti, il loro ciclo controllato dalle Marte. Le donne possono o procreare, o aver cura, in questo nuova Repubblica. Sono controllate, umiliate, punite, prima di tutto dalle altre donne. È un mondo senza speranza quello di Gileard, a meno che nei piccoli sguardi rubati, non si riesca a ritrovare l’umanità massacrata dall’autorità e sanzionata dal controllo sociale. E l’umanità non è altro che la relazione con gli altri, il senso ultimo del nostro essere, è essere insieme, essere società. The Handmaid’s Tale è una serie potente, diventata subito uno strumento per il movimento delle donne. In tante negli Stati Uniti sono scese in piazza vestite di rosso, in molti spazi delle donne in Italia la serie si guarda collettivamente, mentre si rilegge il libro. The Handmaid’s Tale non può non essere serie dell’anno perché la sua distopia è un’arma per svegliarsi nel presente. (Vanebix)
 3. Mindhunter
3. Mindhunter
di Joe Penhall (Netflix)
Fincher utilizza la tv come strumento per andare alla ricerca dell’origine delle proprie ossessioni. La descrizione della nascita degli studi comportamentali come forma di indagine per i casi di omicidio – e la conseguente definizione dell’espressione serial killer – non è però soltanto una detection story (o la storia della detection story). È in senso più allargato un viaggio ai confini della serialità, intesa come impianto narrativo, messa in scena e ricostruzione. C’è innanzi tutto la riedificazione di un immaginario, quello della fine degli anni Settanta, culturalmente trascurato, quasi fuori dalla Storia (non a caso il 1977 è anche l’anno di Boogie Nights, che racconta un’altra Storia) a cui viene dato un risalto inedito. E poi la geniale intuizione di espandere il concetto di serialità. “Serial” come killer ovviamente, ma anche come racconto a episodi. Mindhunter è un meta-testo che mette insieme le indagini dell’Fbi, i film polizieschi (Quel pomeriggio di un giorno da cani) e la cronaca da infotainment (gli omicidi della Manson Family) rendendo tutto vero e tutto possibile allo stesso modo. Quasi che all’interno dello sguardo del medium per eccellenza (cioè la tv) a mancare sia proprio la mediazione fra il racconto e la realtà. (Lorenzo Rossi)
 2. The Deuce
2. The Deuce
di George Pelecanos e David Simon (HBO)
Dopo aver creato negli anni Zero un evento epocale per la storia della televisione come The Wire, David Simon arriva nel 2017 con quello che è forse l’intervento più “rilevante” possibile in questa congiuntura politica in cui si accavallano l’elezione di Trump, il caso Weinstein e il movimento #metoo. The Deuce si concentra sullo sviluppo del mercato del sesso attorno alla famigerata 42nd Street di New York, la strada accanto a Times Square dove negli anni Settanta proliferava ogni possibile attività legata allo sfruttamento della prostituzione e alla nascente industria della pornografia, allora ancora in una fase di interstizio tra l’illegalità e la legalità. Ma nel microcosmo di papponi, di prostitute alle prime armi appena arrivate a New York o già in parabola discendente, dei gay bar e dei peep shows semi-legali, dei cinema porno e dei grindhouse, si fanno largo tutte le politiche di riqualificazione urbana dell’area e di ridefinizione dei rapporti capitalistici a essa legata, che naturalmente in questo caso passano anche per una ridefinizione dei rapporti di genere. Si tratta in effetti di una serie che mostra qual è l’economia politica della sessualità e la sua dimensione affatto materiale. E indirettamente ci dice anche che quello che sta accadendo ora in America, ma anche nel resto del mondo, è ben più importante di qualche aneddoto hollywoodiano. (Pietro Bianchi)
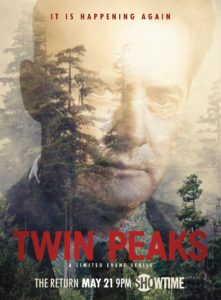 1. Twin Peaks: The Return
1. Twin Peaks: The Return
di Mark Frost e David Lynch (Showtime)
“È il futuro o il passato?” Non è da Lynch dare risposte, e il suo ritorno, a 25 anni dalla creazione che ha rivoluzionato il concetto di serialità televisiva, non può che scompaginare quanto è seguito, provocare e frustrare aspettative, scatenare sciami di fan teorici. “Il passato detta il futuro,” ma questo dettato in Twin Peaks esplode in una cabala di permutazioni. Nessuna operazione nostalgia, se non come etimologico “dolore del ritorno”: il tempo segnato sui volti dei personaggi e dilatato in un presente insostenibile, un sogno di esistenze virtuali e viscerali emozioni. Riattraversando la sua opera, dal mondo in gestazione di Eraserhead alla dissoluzione digitale di Inland Empire, Lynch trova nuovi modi di percorrere il nastro di Moebius della realtà, passaggi elettrici che giuntano il tempo e lo riavvolgono in una fine/inizio, dove innocenza e orrore si confrontano in eterno, jukebox all’idrogeno che suona un disco dei Platters nel rimbombo di Hiroshima. (Tommaso Isabella)
