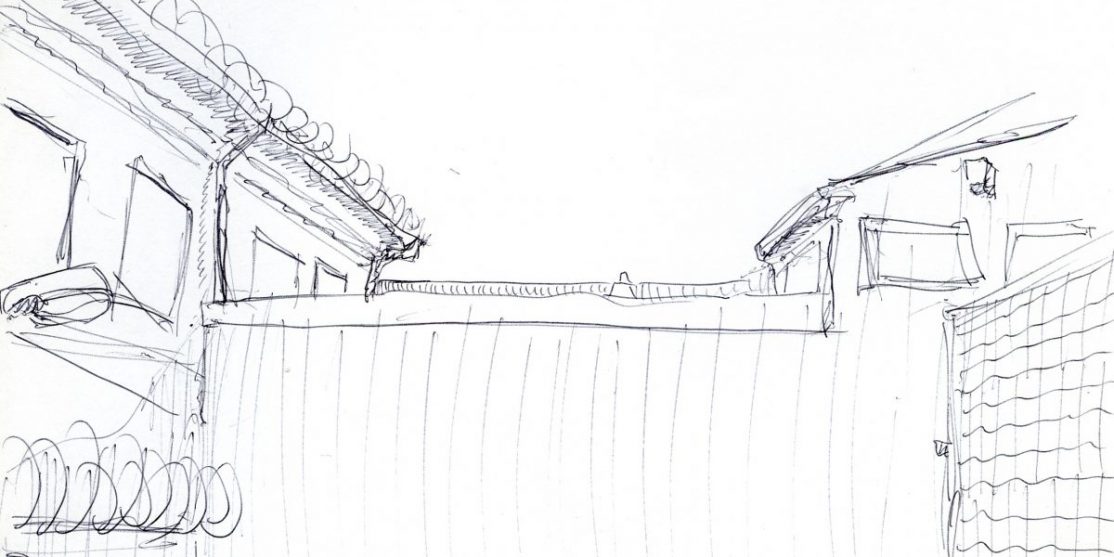CULT

Short Theatre #1. Sognare di cadere
Al festival di arte performative capitolino, che si chiude oggi, “Dream” di Alessandro Sciarroni e “L’Envol” di Nacera Belaza rappresentano quasi due percorsi complementari, due opposti modi di intendere la distanza fra performer e pubblico
Ogni distanza è relativa, soprattutto a teatro. Nel caso di Dream del coreografo Alessandro Sciarroni (andato in scena martedì 12 settembre) si raggiunge in maniera indiretta, quasi per contraccolpo con la prossimità fisica assoluta che invece intercorre fra spettatori e performer. All’interno del grande salone circolare dell’Acquario Romano, edificio in stile umbertino situato nel rione Esquilino della capitale, lo specifico teatrale è fluttuante e disperso in un’atmosfera che già dal titolo vuole essere onirica, fortemente onirica ma non forzatamente tale. Marta Ciappina, Matteo Ramponi, Elena Giannotti, Valerio Sirna, Edoardo Mozzanega, Pere Jou, più che danzare, “sostano in movimento” in diversi punti della scena, mostrandosi nella loro paradossale presenza di figure concretamente astratte. Al centro, Davide Finotti è seduto al pianoforte su cui esegue con morbida e cullante trasandatezza una Gymnopédie di Satie.
Non siamo dunque di fronte a un vero e proprio spettacolo, né a delle apparizioni fantasmatiche o a delle allucinazioni. Siamo, piuttosto, come presi in una palla di vetro con neve, nell’ingranaggio di un carillon scenico che al tempo stesso ci intrappola assieme ai perfomer e ci aliena rispetto alla loro natura.
Mentre infatti siamo liberi di aggirarci per lo spazio osserviamo i danzatori come fossero oggetti sotto teca, salvo accorgerci che piano piano anche noi spettatori diventiamo gradualmente parte del tutto – elementi non sognanti ma sognati, da qualcuno o qualcosa che rimane occultato alla visione. Sciarroni sembra proporre una sfida che ha a che fare col nostro senso di voyeurismo, sia individuale che collettivo: quanto siamo disposti a “violare” lo spazio d’esposizione di danzatori e danzatrici, anche solo avvicinandoci con lo sguardo o interagendo con loro? Ma anche: fino a che punto ci sentiamo di condividere la loro condizione onirica e, in quanto tale, parzialmente spersonalizzante? D’altronde, Ciappina, Ramponi, Giannotti, Sirna, Mozzanega e Jou né ci invitano né ci resistono, semplicemente permangono nella loro intenzione che appare totalmente autonoma e indipendente dalle nostre scelte, dalla nostra visione. Ogni tanto si muovono all’unisono, altre volte con gesti complementari, altre ancora si esprimono nella loro libera singolarità – figure prese non da un eguale obiettivo ma da una simile indefinitezza di statuto, che è anche quella degli spettatori. Così, forse, l’unico modo per rompere il limite di una vicinanza inscalfibile è infine uscire dal sogno, recuperare una distanza che è anche lo scioglimento del patto teatrale – in maniera inaspettata e fascinosamente eterea, come fosse lo scoppio di una bolla di sapone.

(foto di Laurent Philippe)
In maniera per certi versi opposta, la coreografa algerina Nacera Belaza con L’Envol ci pone in una dimensione di radicale lontananza dai corpi dei performer. La scena è quella di un palco “classico”, quello del Teatro India, che possiamo osservare seduti sulle nostre poltrone e immersi in un buio che non solo invade la platea ma anche la scena. Dalila Belaza, Paulin Banc, Mohammed Ech Charquaouy e la stessa Nacera Belaza sono infatti illuminati solo da un faro sullo sfondo e qualche luce di riempimento dall’alto, che celano volti e dettagli mettendo in risalto esclusivamente i profili dei danzatori. Si muovono talvolta a coppie, più raramente in terzetti, oppure più spesso da soli. È una gestualità fluida, armonica e pure con tratti di eleganza per quanto riguarda il disegno sottostante ma pervasa da una rabbia e un nervosismo impliciti, a fondersi perfettamente con l’angosciante atmosfera generale. D’altronde, lo spettacolo si ispira allo scatto fotografico The Falling Man (“l’uomo che cade”) di Richard Drew, che immortalava una delle vittime dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 mentre si lanciava nel vuoto per sfuggire alle fiamme divampate nei grattacieli.
L’immagine di partenza – che di fatto rimane solo a livello di allusione – è dunque l’immagine per eccellenza dell’essere umano senza scampo. Ma a essere, o a sentirci, senza scampo con L’Envol siamo noi spettatori, inchiodati a una visione totalmente indirizzata ed “esatta” da cui è impossibile sfuggire se non chiudendo gli occhi.
Di converso, nel loro agitarsi con estrema disinvoltura e quasi ostentata agilità, le figure sul palco sembrano godere di una libertà sovrana. L’assenza di luce non ne limita i movimenti, anzi fa risaltare la piena consapevolezza del loro corpo e dello spazio attorno. L’indefinitezza che li avvolge – tale per cui è impossibile distinguere fra l’uno o l’altro – non ce li rende estranei, ma anzi pone ancora più l’accento sulla precisione di una coreografa eseguita in maniera meticolosa e millimetrica. Per questo, nonostante agiscano il più delle volte a fondo palco e dunque lasciando un ampio vuoto scenico fra sé e il pubblico, li vediamo – li scorgiamo – massimamente vicini a noi, prossimi alla nostra visione. O ancora di più, prossimi ai reconditi della nostra mente e delle nostre paure più intime: delle ombre, talmente sicure del proprio posto nella trama teatrale dello spettacolo (e al contempo, se pensiamo a ciò da cui trae ispirazione la performance, del proprio posto nella Storia) da inseguirci e attanagliarci, inchiodandoci di fronte all’evocazione di un qualche archetipico rimosso. Come in un rovescio oscuro rispetto a Dream, allora, siamo sui territori di un incubo, sì oscuro e fuligginoso eppure lucido. Di fronte all’estrema mobilità dei performer e alla cupezza scenica che fissa il nostro sguardo su pochi punti prestabiliti, siamo noi a “permanere” incapaci di fare altro: l’unica forma di partecipazione possibile è l’abbandono, sognare di cadere nel vuoto.
Immagine di copertina di Claudia Pajewski