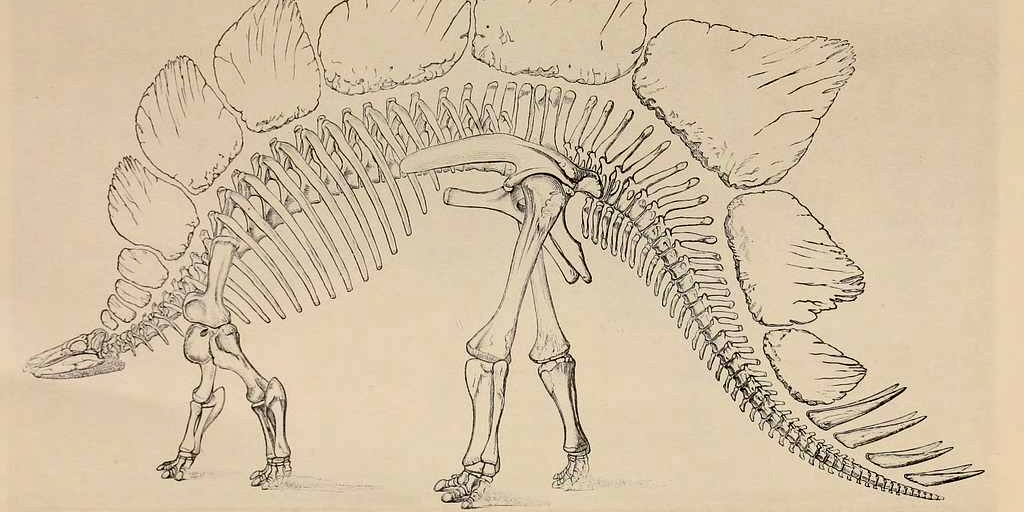ITALIA

Re:common: «La lobby del fossile sfrutta la pandemia per i propri profitti»
La coalizione europea “Fossil Fuel Politics”, della quale fa parte l’Ong italiana Re:common, ha prodotto a inizio ottobre un report molto interessante sul fossile durante la pandemia
A proposito del report “Trasformare la crisi in opportunità: lobby e grandi manovre dell’industria fossile durante la pandemia” abbiamo intervistato Alessandro Runci, campaigner di Re:common
Nel vostro report riuscite a dimostrare un fatto chiave. La lobby del fossile non si è convertita in green, grazie alla sensibilità diffusa data dalla Covid-19, ma ha operato in modo ancora più spietato e spregiudicato per rafforzare il proprio profitto e il proprio business. Qual è il percorso che vi ha portato a questo report e a questa conclusione?
Durante fasi di crisi come quella attuale la grande industria si adopera per tentare di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Lo abbiamo visto ad esempio con il crack finanziario iniziato nel 2008; i principali responsabili di quella crisi, banche e fondi di investimento, hanno ricevuto quantità enormi di sussidi pubblici, mentre decine di milioni di persone perdevano il lavoro e la propria casa. Partendo da questo assunto, e avendo visto come negli ultimi anni la lobby dei combustibili fossili abbia acquisito sempre più potere e capacità di influenzare i decisori politici, ci siamo interrogati su come l’industria fossile si stesse muovendo durante la pandemia e soprattutto con quali finalità.
Abbiamo concentrato questa ricerca collettiva sia sul livello nazionale (Italia, Francia, Spagna) che su quello europeo, cercando così di individuare trame e tattiche comuni del settore fossile nei diversi contesti geografici e politici. Dalla nostra analisi sono emerse con chiarezza alcune strategie che le compagnie del petrolio e gas hanno implementato sin dall’inizio della pandemia, che ricadono lungo tre direttrici principali: 1) accaparrarsi gli aiuti pubblici approntati dai governi e dall’UE per far fronte alla crisi; 2) smantellare le normative in ambito di ambiente e clima; 3) plasmare i piani per la ripresa, insinuando al loro interno le false soluzioni avanzate dall’industria, come idrogeno e CCS.
Uno degli elementi particolarmente interessanti del report è la dimensione continentale del problema, sembra che i parlamenti e la Commissione Europea non siano stati in grado (o non abbiano voluto) in nessun contesto nazionale fare da argine rispetto all’iniziativa delle lobby del fossile. Perché ciò è avvenuto proprio in un momento in cui tutti parlano di prendersi cura del pianeta e delle nostre vite?
Buona parte delle politiche riguardanti la questione climatica vengono discusse a livello europeo, per questo il comparto fossile ha aumentato significativamente la propria presenza, e dunque la propria influenza sulla Commissione. Grazie a questa ramificazione, non appena la pandemia ha investito l’Europa, le lobby dei combustibili fossili si sono attivate all’istante, in modo coordinato, per avanzare la propria agenda, sfruttando la fase di incertezza e la riduzione degli spazi per il controllo democratico. Per prima cosa, il settore ha spinto per la sospensione di tutte le normative «non direttamente legate alla crisi sanitaria ed economica», inclusi alcuni elementi portanti del Green Deal Europeo e gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni.
Lo stesso è avvenuto a livello nazionale. Snam e Confindustria si sono lanciate all’attacco della legislazione ambientale, avanzando le proprie proposte di revisione (o meglio di demolizione) in varie forme. Proposte tramutatesi poi in leggi attraverso il Decreto Semplificazioni, che le accoglie praticamente in toto. Lo stesso decreto stende un tappeto rosso per la conversione delle centrali a carbone in centrali a gas, che ha tutta l’aria di essere una norma ad hoc per Enel, che vorrebbe realizzare nuove centrali a gas per almeno 3 GW sul territorio nazionale. Ancora una volta vediamo come, al di là delle dichiarazioni di facciata, la politica si piega agli interessi dell’industria fossile, persino durante una crisi profonda come quella che stiamo attraversando.

Il vostro report smaschera le false soluzioni green che le aziende del fossile stanno proponendo per accaparrarsi i soldi del Recovery fund. Ci puoi fare gli esempi dei fake green più rilevanti?
La lobby del gas è sicuramente quella che, più di ogni altra, in questi anni si è conquistata un ruolo da protagonista all’interno degli spazi decisionali nazionali ed europei. Si serve di circa 167 gruppi di pressione e 759 lobbisti, con una spesa di almeno 60-80 milioni di euro l’anno. Il fine ultimo di questo esercito di lobbisti è quello di promuovere il gas fossile come il combustibile “pulito” (o “naturale”). Questa narrazione, purtroppo, è stata assunta anche da governi e soprattutto dalla Commissione Europea, andando a inquinare il dibattito pubblico e politico sulla crisi climatica. Non è un caso che la Commissione sia stata tra i più ferventi promotori del gasdotto TAP, tra gli altri. Recentemente, l’industria del gas e i grandi gruppi petroliferi come Eni e Shell, stanno promuovendo con forza tecnologie come idrogeno e CCS (Cattura e Stoccaggio del Carbonio), presentandole come la nuova panacea alla crisi climatica.
Per quanto riguarda il primo, è bene tenere a mente che attualmente il 96% dell’idrogeno viene prodotto a partire dal gas. La promessa dell’idrogeno verde viene utilizzata per spianare la strada a quello fossile, attraverso grandi investimenti infrastrutturali che rischiano di vincolarci ancor di più a un modello energetico insostenibile e ingiusto. Il CCS invece – che si fonda sull’idea che la CO2 rilasciata dai combustibili fossili possa venire catturata e stoccata sottoterra o sott’acqua – è una tecnologia rischiosissima e ad alta intensità energetica, oltre che molto costosa. Di recente, Eni ha annunciato di voler realizzare a Ravenna il più grande progetto di CCS al mondo, già candidato a ricevere fondi pubblici europei. Il progetto ha immediatamente ricevuto l’endorsement pubblico del premier Giuseppe Conte, a riprova di come queste aziende riescano a imprimere la propria agenda e visione, orientando così le politiche energetiche e non solo.
La Covid-19 è arrivato proprio nel momento in cui, finalmente, la Commissione Europea stava iniziando a stanziare risorse per decarbonizzare il continente. Quanto questa “Fossil Fuel Politics” che voi denunciate è riuscita a rallentare o impedire questo processo?
La questione climatica e quella della decarbonizzazione sono temi che hanno certamente caratterizzato questa Commissione, per lo meno sul piano del discorso pubblico. Iniziative come il Green Deal Europeo hanno sicuramente aperto uno spazio importante, ma nel quale si sono inseriti anche quegli attori che hanno tutto l’interesse affinché nulla cambi davvero. Nei mesi scorsi, questa tensione si è palesata nel corso di due importanti decisioni a livello europeo, quella sul Fondo per una Transizione Giusta (Just Transition Fund) – il pacchetto di risorse da destinare alla decarbonizzazione – e quella sulla cosiddetta Tassonomia verde, ovvero la definizione della lista dei settori industriali considerati “sostenibili”. In entrambi i casi, l’industria è riuscita a insinuare il gas tra le tecnologie sostenibili, e quindi tra i potenziali beneficiari di aiuti economici destinati alla transizione. Un paradosso insopportabile. Una nota più incoraggiante è arrivata invece martedì scorso dal Parlamento Europeo, dove la Commissione Ambiente (ENVI) ha votato una mozione per escludere tutti i combustibili fossili, compreso il gas, dal Recovery Fund. Ora la parola passa alle Commissioni per il Bilancio e per l’Economia, che si riuniranno a novembre per ridiscutere il testo. Possiamo aspettarci uno scontro durissimo anche in quell’occasione.

In Italia a farla da padrone è ancora soprattutto Eni, con i suoi spot sui progetti di idrogeno e CCS a Ravenna. Nel frattempo l’azienda ha deciso di fare causa alla Nigeria, per continuare il suo sfruttamento fossile. Ci puoi aggiornare in merito?
Mentre a Milano è ancora in corso il processo per corruzione internazionale a Eni e ai suoi manager, accusati di aver pagato una tangente da circa un miliardo per l’acquisizione di una licenza petrolifera in Nigeria, lo scorso settembre Eni ha deciso di intraprendere un’azione legale contro la Nigeria, rea secondo il Cane a Sei Zampe di non aver rispettato il contratto relativo proprio a quella licenza. Per farlo, Eni si è servita del meccanismo degli arbitrati internazionali privati, notoriamente sbilanciati verso le imprese multinazionali, privi di trasparenza e capaci di minare la giurisprudenza delle corti nazionali sovrane. Con due processi in corso – in Italia e in Nigeria – la decisione di Eni di muovere un arbitrato internazionale contro il paese africano che è stato legittimamente riconosciuto come parte civile, in qualità di vittima, dal tribunale di Milano, non sembra affatto rispettosa della sovranità di quei due paesi. Un’azione che peraltro mette a serio rischio le relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Nigeria, dato che Eni è pur sempre una società controllata dallo Stato italiano.
Quali sfide vedi per i movimenti ambientalisti che devono muoversi in questo complesso scenario?
L’irruzione dei movimenti per la giustizia climatica sulla scena politica internazionale ha inevitabilmente prodotto una reazione da parte dell’industria fossile e dei suoi alleati, segno che il settore si sente profondamente minacciato dall’emergere di questa critica radicale al modello capitalista fossile. L’intensificarsi delle operazioni di greenwashing fa sicuramente parte di questa reazione, ma è soltanto un tassello di una strategia più ampia e sofisticata, che mira a mio avviso a riassorbire questa critica all’interno del paradigma della green economy, ovvero la logica del tutto cambia affinché nulla cambi davvero.
Credo che sia attraverso questa lente che vadano lette le promesse di cambiamento da parte delle major di petrolio e gas e i loro obiettivi di riduzione delle emissioni che passano attraverso false soluzioni tecnologiche fondate sulla stessa logica estrattivistica. Per riuscire davvero a neutralizzare queste strategie è fondamentale togliere legittimità ai loro proponenti. Per decenni, l’industria fossile ha insabbiato la scienza e sabotato l’azione climatica, con il solo fine di poter consolidare il proprio modello estrattivo e i propri profitti. Le manovre messe in campo dal settore durante la pandemia ci dimostrano ancora una volta una cosa tanto semplice quanto fondamentale: queste società non muteranno finché non saranno costrette a farlo.
A mio parere, sarebbe illogico aspettarsi che siano i governi a forzare questa transizione. I settant’anni di storia di Eni, di cui lo Stato italiano è il principale azionista, ci dimostrano come l’interesse ultimo dei governi, di questo o quel colore, sia in fondo quello di incassare i dividendi, incuranti del suo costo sociale e ambientale. Con l’inasprirsi della crisi economica in corso, mi aspetto che il ricatto occupazionale sarà utilizzato con sempre più forza per neutralizzare le critiche a questo sistema e per creare fratture tra chi ne subisce gli impatti. Al contempo, le misure “green” imposte dall’alto, non sono soltanto inefficaci per contrastare la crisi climatica, ma ricadrebbero ancora una volta sulle fasce più vulnerabili della popolazione, andando ad ampliare le disuguaglianze e creando le condizioni da cui potrebbero scaturire derive negazioniste ancora più pervasive e pericolose. Lottare per una transizione realmente giusta significa affrontare interessi economici profondissimi e centri di potere fortemente radicati anche all’interno delle istituzioni. Prendere atto di questo ci sarà di aiuto per costruire insieme le strategie e, soprattutto, le alleanze necessarie a vincere questa battaglia.