cult
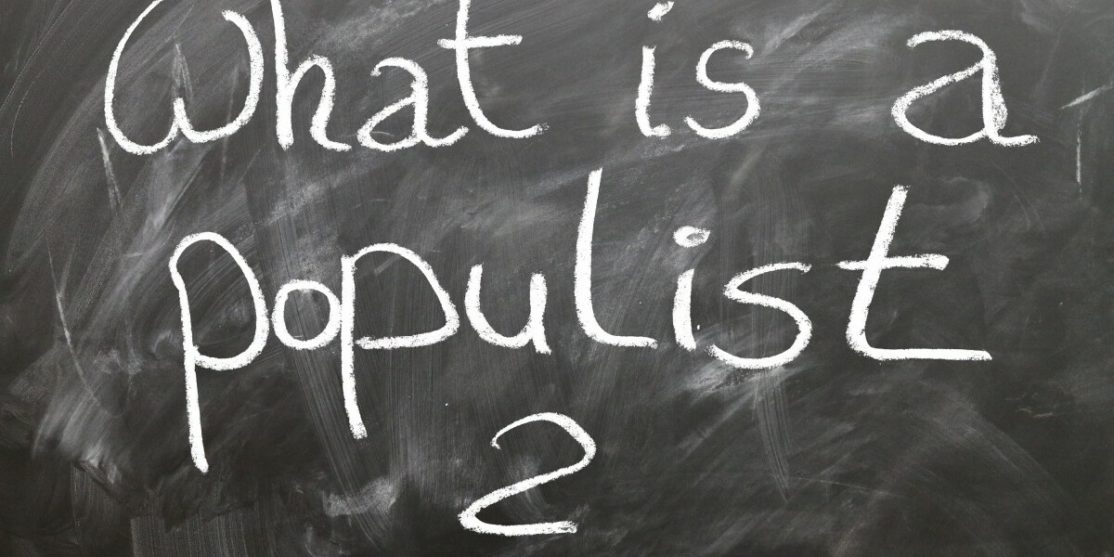
CULT
Prima del diluvio
“Il secondo tempo del populismo. Sovranismi e lotte di classe”, a cura di Alessandro Barile (Momo edizioni, Roma 2020), raccoglie una serie di interessanti contributi che fanno il punto sulla questione populista alla vigilia della Covid-19
Interesse precipuo di questo grappolo di scritti – tale da far passare in secondo piano una qualche eterogeneità di approccio – è che essi testimoniano lo stato della questione all’immediata vigilia di un ciclone pandemico che ha fatto saltare non solo molti snodi e catene di produzione, distribuzione e comando della globalizzazione neoliberale, ma anche i cardini dei movimenti e sentimenti che le si opponevano, in prima battuta proprio della galassia populista. Basterebbe segnalare il regresso di Salvini dal nazional-populismo alla Le Pen verso un modello più padano-centrico – “un ritorno alle origini” che denota un parziale fallimento dell’operazione e la biforcazione del progetto su due portatori: la Lega e Fratelli d’Italia, con definitiva frattura di fatto con la centrista Forza Italia. Inoltre il carisma di Salvini, coessenziale al progetto populista, già appannato dopo le prove di insipienza tattica dell’agosto 2019 e l’estromissione dal governo, si è ulteriormente indebolito per l’astinenza mediatica indotta da Covid-19 e subisce la concorrenza di una figura più abile e solida quale Giorgia Meloni. Un populismo a due teste non si è visto mai, è un fattore di confusione. Aggiungiamo che la base sociale della Lega – la piccola e media impresa del Nord – esce stravolta dalla crisi della globalizzazione, cui partecipava mediante il mercato del lusso e le forniture di componenti all’industria tedesca, due settori entrambi pesantemente compromessi.
Tutto cambiato, quindi?
No, è utile tirare le somme del dibattito che c’è stato finora e cui questo testo collettaneo aggiunge tasselli utili (non tutti condivisibili), ma allo stesso tempo è evidente, a parte le specificità italiane, che le interruzioni e gli scompensi della macchina globale, se non della logica ordoliberale, stanno alterando sensibilmente il terreno di gioco.
Alessandro Barile, che è anche il curatore dell’intero libro, nel suo scrittoFascismo, populismo o “resistenze”. Note per la comprensione della critica reazionaria alla democrazia liberale, tende a identificare il “secondo tempo” del populismo con la sua deriva sovranista, la repressa nazione del basso contro l’antinazione globalista, l’alto della casta – una riedizione della “Grande Proletaria” di inizio Novecento che ricostruisce ormai perduti sensi di appartenenza. Con la differenza che «se le resistenze populiste chiedono di continuare a vivere come un tempo, le lotte di classe otto-novecentesche rivendicavano con forza il non voler vivere come prima» e che, inoltre la contrapposizione alle logiche ordoliberali produce un sovrappiù di liberismo più che il suo contrario. Manca l’anticapitalismo e questo populismo ha la sua specifica ricaduta territoriale nelle periferie metropolitane più che in una classe sociale definita. Di qui il carattere superficiale del suo stesso fascismo (restando quello reale annidato nei gangli profondi della struttura politica e burocratica ordoliberale). Le contraddizioni del governo-giallo-verde o lo slittamento a destra dell’elettorato M5S a Roma definiscono l’orizzonte effettuale di questa analisi.
Stefano G. Azzarà, invece, nel saggio “Sovranismo” o questione nazionale? Il rinselvatichimento socialsciovinista nella politica odierna, trattando deliberatamente i soli fenomeni populistici europei e non latinoamericani, affronta il revival patriottico che ha percorso trasversalmente l’intero schieramento politico almeno a partire dalla presidenza Ciampi, forse per prevenire le spinte secessionistiche negli anni ’90 e suscitare una sorta di “patriottismo costituzionale” alla Habermas, integrato con l’europeismo. Operazione fallita, rispetto alle intenzioni dei promotori, ma che ha avuto un inintenzionale successo nel rilegittimare la destra extra-costituzionale e aprire la porta (anche nella sinistra rosso-bruna) alla retorica sciovinista, fino a riqualificare la Lega secessionista come Partito della Patria, del “prima gli italiani” e “fuori i clandestini”, su sfondo no-euro e anti-Ue. Una disastrosa ri-nazionalizzazione culturale, insomma, che sarebbe dovuta in buona parte alla sottovalutazione a sinistra della “questione nazionale”, addirittura a una specie di “nichilismo nazionale” e deficit di egemonia che, in ultima analisi, risalirebbe al particolarismo operaista post-68. Questo assumeva la classe operaia «come parzialità irriducibile e non come soggetto generale ed egemonico, in coppia complementare con un’«ontologia rizomatica» anti-identitaria e refrattaria al pensiero dialettico che avrebbe lasciato campo libero all’ideologia del mercato, simultaneamente promossa dai partiti di sinistra, meno sensibili al ‘68 ma molto coinvolti nella globalizzazione neoliberale.
All’indifferenza verso la Nazione si accompagna, per Azzarà, quella verso lo Stato, inteso quale nemico strutturale e non come “campo di battaglia”., perpetuando una «visione astorica dello spirito oggettivo» che avrebbe un precedente illustre «persino nel Lenin prerivoluzionario» – cioè, con bizzarra definizione, quello di Stato e rivoluzione, antecedente di poche settimane alla conquista e all’esercizio bolscevico del potere…
Seguendo l’impostazione di Domenico Losurdo e in riferimento alle esperienze della costruzione del socialismo in un paese solo e della resistenza antimperialista mirante a difendere o costruire uno Stato nazionale indipendente, Azzarà critica l’astratto cosmopolitismo «dirittumanistico», cattivo succedaneo di un «malinteso internazionalismo proletario», e osserva che la questione nazionale è stata bagatellizzata e il potere definito in termini solo negativi. Purtroppo la fuoriuscita populista «dall’ubriacatura sessantottina, foucaultiana, anarchica» non è, a sinistra, «l’attesa e necessaria riabilitazione del principio di sovranità […] ma l’espressione codista di una nuova subalternità ideologica», assai affine al vecchio socialsciovinismo, mentre a destra si articola perfettamente con l’ordine liberale. Non abbiamo dunque una reattività difensiva, piuttosto una ricolonizzazione aggressiva del mondo, un attacco bellico alla Nuova Convergenza che si stava delineando con la riduzione dell’egemonia Usa, un tentativo di mettere i ceti medi declassati a rimorchio del suprematismo di stampo trumpiano.

Più aderente, sin dalla definizione di “neopopulismo”, alla complessità della situazione pre-Covid è il saggio di Raffaelo Sciortino, Il neopopulismo come problema: tra geopolitica e lotta di classe, che affronta il tema attraverso una triplice griglia: quella delle trasformazioni della lotta di classe in relazione a un meccanismo di riproduzione sociale completamente integrato nel capitale fittizio, quella dell’intreccio dialettico tra il Sessantotto e gli assemblaggi della globalizzazione, quella dell’influenza reciproca di crisi sistemica e dinamiche soggettive di classe. Punto di svolta è il 1971 e la proclamazione nixoniana dell’inconvertibilità del dollaro in oro: «da quel momento, il dollaro svalutato servirà a scaricare debiti e inflazione sul resto del mondo, il dollaro rivalutato ne capterà i flussi di ricchezza».
Finanza, produzione e riproduzione sociale si stringono in un nodo che rende impossibile tornare a separare speculazione finanziaria ed economia reale: la globalizzazione non è un semplice prodotto di scelte politiche, ma un passaggio dello sviluppo capitalistico verso una sempre più integrale sussunzione reale del lavoro. Nel nuovo quadro geopolitico conseguente alla fine dell’egemonia unilaterale statunitense questo tipo di fenomeni concerne tanto gli Usa o, se vogliamo, l’Occidente, quanto la Cina, che riproduce analoghi processi capitalistici di accumulazione e finanziarizzazione al proprio interno. Nessun attore globale, tuttavia, possiede oggi tutti i fattori di potenza necessari a sostituire Washington e dunque la transizione a un sistema internazionale multipolare non sarà né pacifica né scontata. Il “secolo cinese” di Arrighi, con tanto di soft power, non è alle porte.
Per altro verso, la stessa estensione delle lotte, a partire dal ’68, a tutte le forme di alienazione ha moltiplicato le identità regionali a spese di quella operaia, già investita dalla fine del compromesso keynesiano, e il nesso fra produzione e consumo, che ormai è il nuovo tratto unificante, fa sì che la droga-merce diventi la nuova religione della vita quotidiana». In questa spinta verso l’individualizzazione, «dalla ricerca dell’autonomia di classe si è passati alla rincorsa dell’autonomia senza classe. L’individuo è compiutamente socializzato a scala globale ma per il capitale, la classe è tendenzialmente dissolta nel neo-popolo». L’interiorizzazione del diktat neoliberista riguarda così non solo le rappresentanze politiche della sinistra ma gli stessi soggetti che cercano di liberarsene. Il nuovo proletariato, effetto delle trasformazioni indotte nel vecchio proletariato e in gran parte dei ceti medi dalle innovazioni tecnologiche, si “cittadinizza”, diventa la “variante buona del neopopulismo”, con il rischio di sostituire alla conflittualità di classe una richiesta di protezionedentro cornici neo-sovraniste. In pratica, una versione aggiornata del vecchio riformismo operaio-borghese nei termini “noi contro loro”, che è la sostanza razionale dello strano connubio M5S-Lega durante il primo governo Conte e del suo rovesciamento in alleanza M5S-Lega sotto il secondo governo Conte con l’avanzare della crisi (suggellato poi dall’emergenza Covid-19).
L’autore quindi non ritiene persuasiva l’ipotesi di una deriva fascistizzante che riassorba le istanze populiste e si pone piuttosto la domanda di come il neopopulismo, che resterà a lungo fra noi, tenda a scomporsi e a quali condizioni possa essere superato in avanti. Nell’Occidente post-democratico si è riaccesa una «rivendicazione democratica plebea», che si smarca dal terreno liberale ma di per sé non segna una riattivazione anticapitalistica del proletariato né tanto meno stabilizza un nuovo blocco sociale, anche se «l’unica lotta effettiva con chiare connotazioni di classe, quella dei Gilets Jaunes, si è data su un terreno neopopulista», in alternativa alla gestione elettoralistica delle rivendicazione da parte tanto del M5S italiano quanto della Lega e dei lepenisti.
Oggi purtroppo, secondo Sciortino, tutti i movimenti e le lotte sarebbero sovradeterminati dalle dinamiche geopolitiche, globali o regionali, ma «vale sempre più anche l’inverso: senza una ripresa forte del conflitto di classe gli smottamenti geopolitici in corso non precipitano da soli verso punti di svolta effettivi».
Seguono due saggi che esplorano le esperienze del populismo di sinistra, generalmente marginali nella letteratura italiana, troppo spesso ipnotizzata dall’ancipite cratura Lega-M5S, Sulla cultura politica di Podemos e il populismo, di Raffaella Fittipaldi, e Sinistra, democrazia, sovranità, nazione: una relazione difficile, di Marco Santopadre, assai accurato il primo nella ricostruzione della genesi, ascesa e lacerazioni di Podemos, che si arresta alle soglie dell’esperienza di governo fra Psoe e Unidas Podemos, con conseguente prevalenza dell’elemento di sinistra da quello populista e perdita dell’originaria carica innovativa; dedicato ai movimenti europei indipendentisti il secondo, che riflette le contraddizioni in ambito di sinistra fra sovranismo nazionale e sovranismo secessionista, particolarmente evidenti nel caso catalano.
A conclusione, L’ipocentro della crisi e l’epifenomeno populista, di David Tranquilli, proietta la platea dei “perdenti della globalizzazione”, base materiale dei populismi, sulla scala romana, analizzando i flussi elettorali recenti di Roma e rigettando la retorica del “fascioleghismo”, cui si sostituisce lo studio degli effetti delle “due città” divise dalle Mura Aureliane e dove è la Lega, e non CasaPound, a capitalizzare impoverimento e frustrazione delle periferie, mentre Populismo e migrazioni, di Luca Altieri, interpreta in termini di sostanziale neocolonialismo l’atteggiamento mainstream verso le migrazioni, giustificato dalla gara elettorale fra partiti più che da un’effettiva competizione fra risorse economiche scarse a causa della stagnazione in Italia e in Europa. Dopo una sottile analisi delle varianti del razzismo e delle reazioni degli stessi migranti si ipotizza che dal labirinto della transizione si possa uscire in due modi: o «con l’acritica accettazione del suo paradigma di sviluppo», o «edificando un modello altro, inconciliabile con il precedente e imperniato su quei caratteri che il mondo occidentale considera invece negletti». Le migrazioni di oggi diverrebbero allora, come quelle interne di ieri dal Meridione verso le fabbriche del Nord, «enzima e non zavorra per il conflitto».
Orbene, cosa cambia con Covid-19? Al di là dei piccoli effetti italiani, che hanno ridimensionato Salvini solo in parte a vantaggio di Meloni e hanno genericamente rafforzato il Governo, ormai imperniato sul Pd e non più su un dissestatissimo M5S, a parte ciò sta vacillando l’intero impianto della globalizzazione, almeno quale l’abbiamo finora conosciuto. Centinaia di milioni di operai stabili e informali sono stati gettati nella disoccupazione e sono alla ricerca di qualche protezione pubblica, dunque di possibile opzioni populiste in assenza di soluzioni socialdemocratiche e tanto meno rivoluzionarie. È possibile dunque che si rinvigoriscano neopopulismi di sinistra anche in Europa oltre al suprematismo dei potenti e ai sovranismi fascistoidi dei pezzenti, mentre poco respiro sembra avere il cittadinismo pentastellato, di scarsa fortuna quando le moltitudini hanno l’acqua alla gola e che comunque ha dissipato il patrimonio iniziale di speranze e mal gestito perfino le proposte più popolari, quali il reddito di cittadinanza. Questo è annegato in un assistenzialismo condito di workfarismo velleitario, i cui limiti sono stati travolti sia dall’emergenza Covid che dal potente rilancio di un reddito di quarantena, forma congiunturale di uno strutturale reddito di base.
