approfondimenti
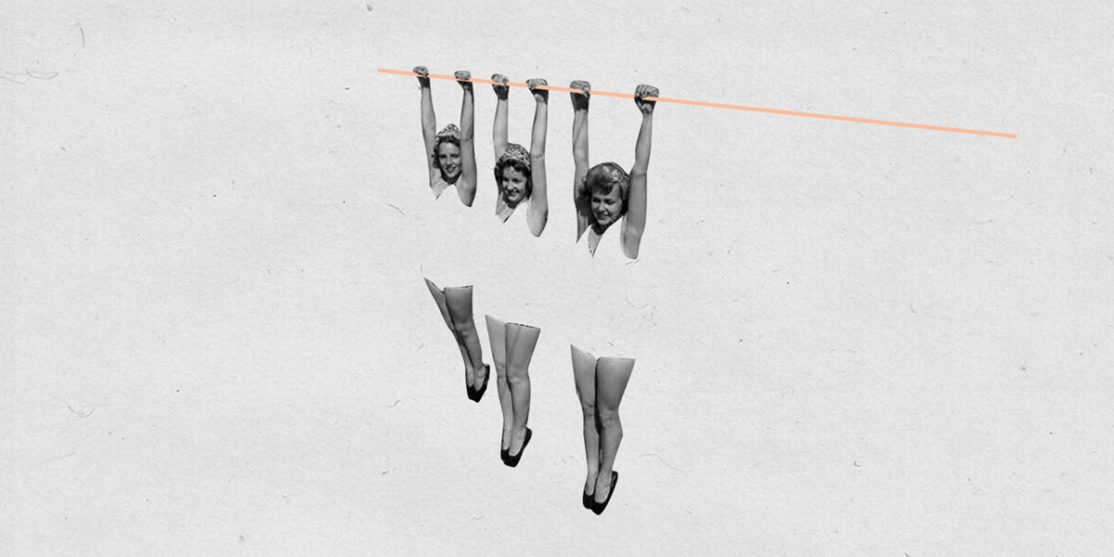
OPINIONI
Le vite agre. Il lavoro culturale tra desiderio e impossibilità
La denigrazione degli intellettuali nel discorso politico dei sovranisti rende necessaria una riflessione a tutto tondo sul lavoro culturale. Spinti da anni sull’orlo della propria sopravvivenza materiale, i lavoratori e le lavoratrici della cultura devono riprendere ad interrogare il senso della loro attività.
Qualche tempo fa Michela Murgia pubblicava un post in cui rispondeva all’accusa di “radical-chic”, mossale da Matteo Salvini in un tweet, passando in rassegna uno per uno tutti i diversi mestieri da lei svolti prima di approdare stabilmente al lavoro editoriale. La “sinossi del curriculum”, così l’autrice definiva l’elenco dei lavori fatti in vita sua, invitando il Ministro degli Interni a stilarne uno simile per mettere a confronto le proprie biografie e misurare il grado di “vita reale” che, a detta di Salvini, lei in quanto intellettuale non avrebbe avuto modo di esperire.
Radical chic – cugin* di “buonista” e di “politicamente corrett*” – è uno di quei concetti in cui gli ormai noti sovranisti fanno precipitare alcuni dei tratti salienti del proprio discorso, una sorta di meme che nell’essere usato continua a rafforzarsi pur svuotandosi sempre più di senso. Un costrutto linguistico, un artificio retorico per dipingere qualcosa di odioso, detestabile. Una tra le tante immagini distorte che nutre l’ideologia delle destre, tutte accomunate da un unico principio: la cultura viene vista come elemento di distinzione, superiorità, autorità, separatezza dalla vita vera. Qualcosa non soltanto di cui finalmente liberarsi dopo anni di dominio, ma anche da denigrare, perché sostanzialmente inutile, sprecone, incomprensibile, se non dannoso. D’altronde, chi ha ancora voglia di stare a sentire quei signori ingrigiti che sparano sentenze indossando papillon e occhiali dalla montatura strana? Sono passati ormai gli anni d’oro dell’egemonia culturale, in cui gli intellettuali parlavano a un paese che li ascoltava e il lavoro culturale era sinonimo di pratica politica, o per lo meno di valore sociale. Oggi dell’intellettuale, organico o integrato che sia, non resta che un’immagine stantia, dietro la quale si nasconde una schiera di individui che fatica a trovare un posto nel mondo.
Di fronte a uno scenario sociale e culturale completamente mutato nell’arco di poco tempo, perdiamo via via di vista il perché del “fare cultura”, condannando tutt* coloro che se ne occupano a replicare all’infinito uno schema nel quale la sopravvivenza diventa il fine unico di un intero sistema che finisce per cancellare il suo stesso senso.
Radical chi?
«Non sempre la guerra civile assume le sembianze classiche e visibili di un conflitto armato», ricorda Ida Dominijanni in un pezzo uscito su “Internazionale” qualche tempo fa. Le maglie che tengono insieme i pezzi della società si allentano ormai alla velocità della luce e vanno in direzioni sempre più radicalizzate. Da una parte troviamo quelli che gridano con forza le proprie esigenze, rivendicando quasi un diritto all’ignoranza in virtù di un bisogno crescente, qualsiasi esso sia. Dall’altra una “classe intellettuale” (e politica), genericamente identificata come “di sinistra” che, schiacciata in questo nuovo paradigma politico e sociale, non trova forse più alcuna forma di affermazione se non nel denigrare, ridicolizzare, sfottere e svilire.
Tra stipendi inesistenti, mansioni fantasiose, schizofrenia di diritti e prospettive improbabili, noi tutti che ci occupiamo di cultura e arte in Italia possiamo ancora permetterci di dirci estranei a tutto questo? Di fronte all’imponderabile che galoppa, e che tra poco finirà per colpirci direttamente, non avvertiamo una certa sproporzione tra la supposta responsabilità collettiva che dovremmo assumerci, il valore che il resto della società ci riconosce e la nostra semplice sopravvivenza materiale?
Che i lavoratori culturali fatichino a trovare posto in questa società è un dato di fatto; ed è un fatto anche che è il lavoro ciò che ci immette dentro la realtà della vita, che ci fa prendere posto nel mezzo della società, che ci fa scoprire problemi e frustrazioni, che ha a fare con i nostri gusti, le esigenze e i desideri. Per quanto inneggiamo all’automazione e auspichiamo la fine del lavoro, è sempre lui l’elemento che ancora oggi ci definisce. È all’interno di questo automatismo, quindi, che il lavoro intellettuale continua a individuare i soggetti che lo svolgono, e non c’è modo di spezzare l’equivalenza che rende chi lo fa un “radical chic”. Qualcuno che parla del mondo senza averne presa diretta, senza subirne le brutture e le fatiche, ponendosi in una posizione di distacco e autorevolezza.
In realtà, molt* di coloro che sentono in qualche modo di rientrare nella categoria del “radical chic” possono vantare una sinossi del curriculum piuttosto simile a quella della Murgia: una serie più o meno interminabile di lavori “del caso” fatti per portare a casa uno stipendio, in attesa che arrivi il giorno di poter “vivere delle proprie parole”. Siamo quindi forse in tant* a poterci definire parte di quel paese reale che Salvini accusa la scrittrice di non conoscere.
Contemporaneamente sacralizzati e demonizzati, il sapere, la cultura, l’arte e i mestieri a questi connessi vengono catalogati e inseriti in uno stesso calderone di pregiudizi, confusioni e banalizzazioni, da cui non possono che nascere chimere impossibili da sconfiggere, tossiche tanto per chi di questi mestieri vive che di chi li osserva e giudica dall’esterno. Quella peculiarità che ancora oggi caratterizza il lavoro culturale non è forse a questo punto più frutto di un discorso retorico che, seppur resiste nell’immaginario collettivo, è del tutto sconfitto in termini di realtà?
Oggi lo statuto del lavoro culturale è così tanto messo in crisi che leghisti, fascisti, terrapiattisti e complottardi vari sembrano semplicemente fare come gli avvoltoi, che vedono le carcasse prima ancora di sentirne la puzza. Prima di diventarle davvero, carcasse putrescenti, l’unica vera strategia che abbiamo è guardare in faccia la bestia e iniziare a immaginare tutto di nuovo da capo: basta raccontarsi come antilopi in fuga nel deserto, dobbiamo tornare a sentirci delfini che surfano sulle onde, pappagalli che si posano su rami lussureggianti, formiche nere, rosse e di qualsiasi altro colore che collaborano creando meraviglie come fossero un unico corpo. Prima iniziamo a farlo e più facilmente riusciremo ad aprire la possibilità che questo accada davvero.
Tecno-cultura
Nell’epoca in cui viviamo, il lavoro ha di fatto finito per tradursi quasi completamente in lavoro cognitivo. Ma, come dice Bifo, «per diventare lavoro salariato, l’attività deve essere sottomessa alle regole della ripetizione, indipendentemente da quanto creativa possa essere». E tra algoritmi e misuratori, ciò che oggi ruota intorno alla produzione di contenuti è caratterizzato da una forte dose di tecnica. Tutti i contesti culturali, soprattutto quelli che hanno a che fare con il finanziamento pubblico, sono strutturati a partire da sistemi informatizzati e indicizzati, formule acquisibili e replicabili che spesso finiscono per autonomizzarsi dal pensiero e dalle motivazioni che le hanno prodotte, oltre che dalla mente di chi ci lavora. D’altra parte, però, il livello di cognitivizzazione è tale che anche le capacità socialmente individuate come superiori, come la creatività e l’autorialità, vengano oggi richieste ai lavoratori e alle lavoratrici di tutti i livelli: gli stagisti e le stagiste, ad esempio, devono dimostrare di essere autonomi e brillanti nel momento stesso in cui iniziano la loro formazione pratica. Una creatività da produrre in serie e da mettere a disposizione degli scopi più disparati, tutti però tenuti insieme da un’unica funzione: quella della vendita. Che si tratti di prodotti, dati, utenti, visualizzazioni, biglietti di uno spettacolo, date di concerti, libri, idee.
In questa omologazione prolifera l’ambiguo statuto del lavoro culturale: se da un lato il suo funzionamento si è strutturato sul modello dell’azienda, dall’altra questo lo pone nella condizione di inseguire obiettivi quantitativi senza che esistano davvero gli strumenti adatti a raggiungerli, alterandone la natura e producendo un ibrido che non sembra in grado di andare più lontano di dove è ora. Molta parte del lavoro culturale continua a essere svolto dentro la contraddizione di dover competere in un mercato senza che esista davvero un mercato e soprattutto tralasciando quello che è il suo reale core business: qualcosa di completamente immateriale come “il contributo alla società” che, come ci ricorda Tiziano Bonini su “Che Fare”, «si misura in termini di potere restituito alla comunità».
Il lavoro culturale e intellettuale – così come quello artistico – è ancora in gran parte considerato alla stregua di non-lavoro. Questa diventa una condizione strutturale che si fa tanto causa che effetto di se stessa. Chi lo intraprende accetta il compromesso di dover barattare la propria “passione” con la stabilità economica ed esistenziale ed è qui che nasce l’equivoco: assecondare la propria attitudine che si manifesta oggi, nel presente, a scapito di una sicurezza futura (e tutta da verificare) implica assumersi la responsabilità di intraprendere un’attività che per definizione non corrisponde ai caratteri del lavoro comune, in termini di orari, dinamiche, retribuzione, valore sociale. E questo nel bene e nel male. Come se fare il medico, l’economista, l’avvocatessa, il logopedista o l’operaia non siano in ogni caso mestieri che possono da nascere da un piacere, da una passione, da un’attitudine, oltre che da una necessità.
Affianco a questo, c’è poi l’enorme scollatura che esiste tra teoria e pratica. La maggior parte delle persone che intraprendono un determinato percorso di studi umanistici in Italia non ha idea di che tipo di mestiere – concretamente – si troverà a svolgere dopo la laurea. Nessuno sa davvero cosa significa fare l’ufficio stampa, la producer, il correttore di bozze, la ricercatrice, il giornalista, l’operatrice culturale, il project manager se non nel momento stesso in cui inizia a farlo. E se poi non ti piace? Troppo tardi!
Nell’immaginario collettivo, essere pagati per pensare, studiare, approfondire e poi offrire agli altri le proprie opinioni non è – almeno in questo momento – differente dal programmare post, creare target per il pubblico, inviare inviti, fare data entry, aggiornare indirizzari, compilare bandi, imparare a fare editing video e foto, realizzare grafiche per le stories su Instagram, redigere le note spesa dei membri di un’associazione culturale. Sotto l’etichetta di lavoro culturale finiscono tutta una serie di professioni e attività che nella pratica hanno molto poco a che vedere con i contenuti e molto invece con le tecniche. Il risultato è che fare tanto il social media manager che la ricercatrice sono percepiti come attività velleitarie, entrambi spesso non contemplano gli stessi diritti e garanzie di cui godono le altre professioni, e la distanza che si crea tra gli strati sociali rende sterile qualsiasi tentativo di attraversamento tra questi. I prodotti e i contenuti che la classe intellettuale e culturale produce restano irrimediabilmente confinati in un iperuranio del discorso, all’interno di cerchi concentrici che vanno via via restringendosi persino all’interno di queste. Dando per scontato che la soluzione non possa essere che le persone smettano di scegliere ambiti legati alle “discipline umanistiche”, né tanto meno che le università smettano di fare teoria, votandosi al tanto disperatamente inseguito mercato del lavoro, lo sforzo che ci troviamo oggi a dover compiere è piuttosto quello di fare chiarezza e di facilitare gli scambi tra settori che si rispondono a vicenda ma che restano comunque separati da invalicabili muri.

Vite generose, vite agre
Constatare quanto la cultura e la produzione di pensiero in questo momento siano qualcosa di poco valore all’interno delle nostre società è banale ma anche profondamente inquietante. Razzismi, fascismi e suprematismi vari sono diventati il discorso dominante, pur mantenendo la propria facciata anti-sistema. Ignoranza, aggressività e pregiudizio dilagano facendoci avvertire tutto il pericolo di una situazione di emergenza costruita a tavolino. Mai come ora abbiamo un’urgenza di cultura, di pensiero e di confronto. Possiamo ancora permetterci il lusso di continuare ad accettare questo stato di cose?
Nella confusione di cause ed effetti che governano le dinamiche del lavoro culturale, molti sono gli errori “epistemologici” con cui si affrontano le questioni, e altrettanti sono i luoghi comuni, i micro-costumi ormai consolidati che contribuiscono a cristallizzare una situazione che sembra prossima all’implosione, ma che forse rappresenta solo una forma distorta di equilibrio.
Giusto per iniziare: non è affatto vero che nella cultura manca il lavoro. Il lavoro c’è e ce ne sarebbe per tutti, se fosse supportato da un sistema economico e di diritto adeguato. La situazione tipo di una media impresa culturale è quella di trovarsi strutturalmente sotto organico. Il meccanismo si potrebbe grosso modo raccontare così: avere la necessità di produrre, in termini di attività e proposta, senza poter permettersi il numero di persone necessario a portarle avanti, imponendo ai soggetti schizofrenia e iper-performatività come fossero il prezzo da pagare per aver scelto di seguire una “vocazione”. Se da un lato tutto questo avviene sulla pelle viva dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso l’odioso meccanismo della generosità – che diventa nient’altro se non un ricatto nel quale le posizioni di forza sono indistinguibili – dall’altro il rischio è che spesso la qualità del lavoro tenda a livellarsi verso il basso. Lavorare tanto, frammentati e disorganici, abituati ad aggirare ostacoli tecnici, burocratici, economici, senza aver tempo di aggiornarci e formarci, abbiamo molta ansia e guadagniamo poco.
Le dinamiche di forza e le gerarchie nelle strutture sono estremamente fluide, a volte ambigue: raramente si ha di fronte “un padrone” che si arricchisce alle spalle dei lavoratori, mentre più spesso la violenza di un sistema in cui si è tutti sulla stessa barca è distribuita su tutti i livelli, rendendo impossibile e inutile una dialettica tra le parti. Di fatto è un “o così o niente”. La sensazione è davvero quella che o si sale sulla giostra o la giostra si ferma, così che la professione culturale da mestiere diventa missione. Peccato che nessuno di noi salvi delle vite. O almeno questo stanno riuscendo a farci credere.
Immaginazione al potere, ma meglio potere all’immaginazione
Il lavoro culturale è proprio come tutti gli altri lavori. A volte bello e a volte brutto, a volte è meglio degli altri e a volte peggio, soprattutto quando scopriamo che può essere molto diverso da quello che ci aspettavamo. La gratificazione nel portarlo avanti non ha niente di mitico né di mistico. È esattamente la stessa provata da chiunque svolga una professione in cui crede e che lo appassiona, ed è sotto quel misticismo che si nasconde il sopruso e la frustrazione. Ciò che finisce per perdersi in questo dramma che vorremmo borghese è in fondo proprio il suo senso: persi nella frenesia di queste vite, dimentichiamo che il nostro compito è quello di creare le condizioni perché si produca pensiero, immaginazione, capacità critica, emozione. Altrimenti che senso avrebbe sottoporsi a tutto questo? Riscoprire e riconoscere una funzione sociale, e quindi politica, al lavoro culturale è in realtà un’arma che tutt* coloro che se ne occupano hanno tra le mani. Giocarsi il tutto per tutto e mettere in discussione il cuore stesso di ciò che facciamo è la chiave di volta capace di spezzare l’incantesimo da cui si genera questa rimozione collettiva. Mettere a valore il “privilegio” di avere a che fare con il non-dato, l’incomprensibile, il divenire, l’inutile, l’impossibile. La vera responsabilità è permettersi di giocare con grande serietà con ciò che ancora non esiste, accettando di diventare laboratorio di possibilità.
Da un lato rendere visibile l’invisibile, dichiarando che il lavoro culturale non coincide con il lavoro intellettuale e che entrambi comportano una contropartita, lontana dall’idea romantica dell’artista che fa la fame vivendo della sua arte, o dell’intellettuale che dall’alto del suo iperuranio illumina la via al popolo. Tutto il lavoro culturale, di cui il lavoro intellettuale e creativo sono una delle componenti, richiede dei compromessi, e la controparte è sempre il mercato. Abbiamo bisogno di chiamare le cose con il proprio nome, per poi poterle finalmente rimescolare, evitando di morire soffocati dalla settorialità.
Dall’altra ripristinare il senso profondo di quello che significa essere un lavoratore e lavoratrice della cultura, interrogandosi in maniera radicale su tutti i compromessi e gli automatismi che ognuno ripercorre all’interno di un meccanismo immobile e fagocitante.
Basterebbe in fondo riscoprire il valore del pensiero, che ha a che fare con il tempo e con la possibilità. Far circolare di nuovo il pensiero, metterlo al centro del nostro fare, far sgorgare da questo il desiderio di immaginare, progettare, realizzare. Permettere al pensiero di vivificare le nostre azioni e le nostre motivazioni. Riscoprire l’urgenza e la necessità alla base della nostra attività, riconoscendo il valore etico di un agire. Abbiamo bisogno di programmi di formazione tanto tecnica che teorica, di momenti di scambio, dialogo, dibattito sganciati dal produrre, di occasioni di relazione tra ambiti distinti e nicchie diverse della società. Dovremmo tornare ad azzardare e avere meno pudore nello sporcarci le mani guardando, interagendo con mondi differenti dal nostro pur restando radicali di fronte a questi. Abbandonare la paura di non essere capiti se non banalizzandosi.
Non smettere di imparare e di mettersi in discussione e, contemporaneamente, esigere con forza un salario.
Non salvare vite allo stesso ritmo di un chirurgo non può essere un parametro con cui valutare l’utilità collettiva di un mestiere. Né pretendere che con certe attività si debba produrre profitto. Anche solo in termini di istinto di sopravvivenza, prima che il disastro sia compiuto, non possiamo non batterci per sganciare la cultura e l’arte dall’efficacia, dalla vendibilità, riconoscendone la reale necessità e l’urgenza, tutte inscritte nella dimensione di un’etica, oltre che di una pratica.
È il pensiero, l’approfondimento, il dubbio e la curiosità che ci salvano dal diventare dei burocrati ed è il pensiero in fondo il fine ultimo dell’intera filiera culturale: produrre pensiero e inventare strategie perché questo si diffonda in tutti gli strati della società. Non ingabbiarlo dentro cerchie che non hanno altro fine se non quello di riconoscersi al loro interno e nemmeno delegarlo alle menti eccelse, illuminate, creative, settorializzando e tecnicizzando i ruoli e le posizioni fino a rimuoverne la matrice originaria.
Una cosa comune, come mangiare, dormire, divertirsi, ballare. Pensare. Il diritto al pensiero va riconosciuto come bene primario, da distribuire in tutte le fila della comunità, perché siano poi le persone a scegliere di non esercitarlo. Convincersi intimamente del potere dell’immaginazione e del desiderio riconsegnandoli a tutti gli strati della collettività è forse l’unico modo di fare spazio alla possibilità che esista qualcosa di diverso. Ed è qui che si rinnova la responsabilità del lavoro culturale, perché se certamente il senso di questo sta in quello che facciamo, prima ancora sta nel ritrovare il perché lo facciamo e da questo poi praticarlo, insieme, in un come.
Illustrazioni “Inspired” di Sarah Wickings
