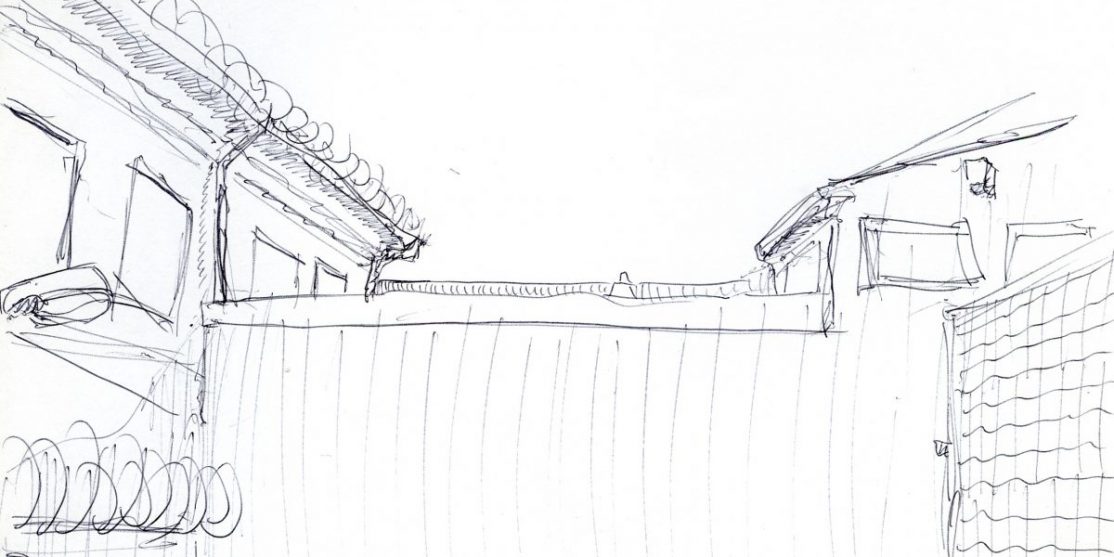MONDO

Incerto fine anno per la Bolivia
Bilancio del golpe boliviano, delle resistenze e dell’incerto compromesso per nuove elezioni
I gruppi legati al MAS boliviano, dopo un tentativo di resistenza attiva attraverso il taglio delle forniture di acqua ed energia alla capitale, sono stati costretti ad accettare la via di nuove votazioni per tornare al potere. Sebbene Morales vanti ancora un’ampia base elettorale, il principale ostacolo a una sua riaffermazione proviene ora dai contrasti interni per succedergli. Andrónico Rodríguez, cocalero e candidato della componente più radicale, si contende la leadership con David Choquehuanca, ex ministro degli esteri, Luis Arce, ex ministro dell’economia, e Diego Pary, già ambasciatore boliviano presso l’OSA.
Intanto i carri armati tornano a sfilare per le strade sudamericane. Quito, Santiago, La Paz, Bogotá. Le metropoli del subcontinente hanno assistito al ritorno dei militari che rimanda ai periodi più bui dell’America Latina. Pochi giorni fa il governo di Jair Bolsonaro, preoccupato che le manifestazioni della regione si diffondano in Brasile, ha evocato il decreto della dittatura che nel 1968 diede inizio alle peggiori repressioni del paese.
È alla luce di questi eventi che va letta la congiuntura boliviana, producendo una riflessione – frammentaria, parziale – che parte dalla presa del potere di Morales per giungere alla situazione attuale. Senza nessuna ambizione di essere neutrale ed equidistante. Criticare ora è posizionarsi più o meno consapevolmente dalla parte sbagliata del dibattito. È prendersela con l’irresponsabilità del derubato quando il ladro è ancora in fuga: un giusto esercizio al momento sbagliato. Che rischia, inoltre, di avere lo spiacevole effetto di rendere i golpisti meno antipatici e di alimentare letture condiscendenti verso il colpo di stato che si sta consumando a La Paz. La critica a Morales, sebbene indispensabile, la lasciamo dunque a momenti più opportuni.
Proviamo invece a ricostruire l’esperienza boliviana al di là di facili entusiasmi fuori tempo; andando oltre le ingenue apologie dell’indigenismo ma allo stesso tempo valorizzando i notevoli traguardi di un popolo che si trova ora conteso tra giunte militari e squadracce fascio-evangeliche.
L’ascesa di Morales in Bolivia si inserisce nel più ampio processo del giro a la izquierda del subcontinente latino-americano. Frutto della frustrazione causata dal modello neoliberale delle decadi precedenti, poco importa se la svolta izquierdista abbia avuto inizio con il Caracazo venezuelano del 1989 o con l’insorgenza zapatista del ’94: a partire dagli ultimi anni dello scorso millennio gli espulsi dalla macchina produttiva neoliberale hanno incontrato coloro che in quella macchina non erano mai entrati, dando vita a uno straordinario ciclo di insurrezioni popolari. La «società politica dei subalterni», come la chiamerebbe Partha Chatterjee, univa le esperienze conflittuali rurali a quelle urbane; univa i cocaleros boliviani e i sem terra brasiliani ai piqueteros argentini. È dallo scoppio generato dalle politiche neoliberali e le insurrezioni contro di esse che hanno preso forma quei governi progressisti che avrebbero da lì a poco dominato la politica latino-americana.
L’esperienza boliviana è quella in cui, all’indomani della vittoria elettorale di Evo Morales nel dicembre del 2005, il rapporto tra governo e movimenti si è presentata nelle forme più originali e creative. Quando nel 2000 il governo di Hugo Banzer Suárez avviava il progetto di privatizzazione dell’acqua con il consorzio Aguas del Tunari, gestito dalla multinazionale Bechtel che assunse la gestione del servizio idrico, centinaia di migliaia di persone invasero le strade di Cochabamba contro il governo, obbligato a rivedere le sue decisioni. Ma più indicativa è l’insurrezione del 2003, che ebbe come conseguenza la fuga del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, succeduto a Hugo Banzer Suárez dopo la breve parentesi di Jorge Quiroga Ramírez. Quando il governo dichiarò la sua intenzione di esportare gran parte del gas naturale verso Stati Uniti e Messico attraverso i porti cileni un sollevamento popolare si è scatenato compatto nella città strategica di El Alto e nelle province circostanti. Una fortissima repressione causò più di 80 vittime, ma le mobilitazioni portarono all’abbandono di Sánchez de Lozada che scappa all’estero cacciato dal popolo, non dai militari. Il responsabile del massacro indigeno, l’allora vicepresidente e ormai noto Carlos Mesa, dopo aver assunto la carica fu a sua volta costretto alle dimissioni nel giugno 2005, a seguito di tre settimane di disordini causati dal non adempimento dei risultati del “referendum per il gas” del luglio precedente. Fu la potenza destituente degli indigeni aymara e quechua, dei sindacalisti cocaleros, dei movimenti sociali ad aprire le porte al governo Morales che, grazie a loro, avrebbe vinto le elezioni di dicembre.
L’inedita forma di governance post-neoliberale che ne è venuta fuori è stata dichiaratamente antimperialista e antiliberista, ma nel contesto di quello che García Linera ha più volte definito – con una buona dose di onestà intellettuale – capitalismo andino-amazzonico. Che il post-neoliberalismo sia una forma di capitalismo nel senso marxista del termine è evidente, ma ha il merito di aver potenziato forme di economia comunitaria a partire dalla consapevolezza che il socialismo non si costruisce per decreto ma dal movimento reale della società.
Il progetto boliviano si è mosso dalla stesura di una nuova costituzione che dal 2009 privilegia un modello economico-sociale solidale che sfugge all’egemonismo neoliberale senza necessariamente ricorrere a precoci ipotesi di socialismo del XXI secolo. Ma presenta importanti novità anche da un punto di vista decoloniale. Il “farsi Stato” dei gruppi subalterni ha permesso ai dannati della terra la possibilità di prendere voce. La concezione plurinazionale che la costituzione indigenista ha assegnato allo Stato boliviano ha sfidato radicalmente la concezione egemonica ed eurocentrica dello Stato-nazione come spazio geopolitico omogeneo in cui le differenze etniche, culturali e religiose risultano oppresse. Offrendo un interessante case study per gli studiosi postcolonial e percorribili soluzioni pratiche alle spinte autonomiste dei vecchi colonizzatori.
Il laboratorio boliviano è oggi sotto assedio, minacciato da un colpo di stato sui generis che si presenta come costituzionale, promette elezioni ma non le indice. Aizzata da Carlos Mesa sulla base di presunti brogli elettorali, le redini della rivolta sono presto passate nelle mani di ambigue figure a capo dei comitati civici. Tra queste, quella di Fernando Camacho è significativa e illustra piuttosto efficacemente quali tipi di personaggi si celino dietro al rovesciamento di Morales. Dirigente della squadrista Unión Juvenil Cruceñista, rampollo della jeunesse dorée bianca di Santa Cruz, Camacho fa parte di quella cerchia che, per intenderci, non mastica foglie di coca e fa affari a Panama. Difficile non cadere in parallelismi con Guaidó in Venezuela, probabilmente tirato fuori dallo stesso cappello; con la differenza che qui la retorica cristiana della destra è ancora più forte e fa sì che Camacho entri scortato nel Palacio Quemado e si inginocchi davanti una bibbia che lui stesso aveva portato. Lasciando da parte l’immaginario coloniale a cui questi episodi rimandano, è la natura stessa dell’attuale governo ad interim a inquietare. Un governo civico-militare razzista e fondamentalista.
Difficile non analizzare la situazione attuale dal punto di vista delle risorse presenti sul territorio. Principale giacimento del pianeta, quello di Salar de Ujuni è la perla boliviana che attira turisti da tutto il mondo. Ma attira anche quelle imprese transnazionali che, nell’era degli smartphone e in pieno tracollo dei combustibili fossili, vedono il litio come il nuovo petrolio. Se si aggiunge che, in un sistema internazionale riscopertosi multipolare, la Cina è il principale investitore nell’area nonché tra i pochi paesi con le competenze necessarie alla produzione di batterie, risulta più semplice comprendere perché gli Stati Uniti appoggino attivamente le oligarchie revansciste boliviane. Non è un caso che lo stock di aziende come la Tesla – pionieri nell’industria automobilistica elettrica ed escluse dal mercato boliviano – sia impennato i primi giorni di novembre, seguendo con macabra razionalità il numero di indigeni uccisi.
Ma la geopolitica, come spesso accade, rischia di essere riduzionista se presa da sola. Il programma post-neoliberale di Morales e Linera ha finanziato notevoli programmi sociali ma allo stesso tempo salvaguardato la proprietà privata della borghesia nazionale, il tutto garantendo una crescita al 6%. Insomma, un socialismo vincente che doveva essere arrestato prima che potesse fare breccia in una regione dagli equilibri politici in assestamento.
L’elezione di Obrador in Messico e di Fernández in Argentina hanno segnato un punto di svolta per l’America Latina, soprattutto se viste alla luce della scarcerazione di Lula e alle mobilitazioni che da sinistra stanno sfidando le formule del FMI in tutti i territori. È difficile dire se quello che sta avvenendo in Bolivia sia una convulsione – il colpo di coda della destra liberale – o un dispositivo che ci segnala una pericolosa svolta militarista del liberismo sudamericano. L’esito delle rivolte che stanno percorrendo l’America Latina sarà indicativo in questo senso. Ma negare l’esistenza di un colpo di stato in Bolivia significa non cogliere l’importanza dei modelli comunitari alternativi che il laboratorio boliviano ci ha fornito nel corso di questi anni. E significa soprattutto non cogliere le ripercussioni che il golpe può avere sull’intera regione. Il riferimento non è solo ai grandi media delle società occidentali, che nascondono dietro lo schermo democratico un’autoproclamazione senza quorum e militari che “suggeriscono” le dimissioni al presidente in carica. Ma anche a quella sinistra internazionale che coi cadaveri ancora in strada non può fare a meno di puntare il dito sugli errori di Morales. Modello economico estrattivista, dubbie politiche ambientaliste, atteggiamento caudillista, cooptazione dei movimenti sociali, derive machiste. Sono critiche che abbiamo fatto e che faremo, e che spiegano inoltre il motivo per cui alcuni settori popolari abbiano gradualmente preso le distanze dall’ex Presidente. Sono critiche giuste, eppure poco adatte a un presente in cui è necessaria una presa di posizione forte e unitaria contro il colpo di stato boliviano e la controffensiva liberal-autoritaria di cui fa parte. Così come la presa del potere di Morales ha fatto parte a pieno titolo della svolta progressista latino-americana, il suo rovesciamento rappresenta oggi la risposta autoritaria alle vittorie della sinistra in Messico e Argentina. Almeno ora, e facendo proprie le esigenze decolonial, tentiamo di difendere e non giudicare con una visione eurocentrica del socialismo i processi di cambiamento latino-americani, pieni di errori eppure ancora capaci di fornirci utili suggerimenti.
E adesso?