cult

CULT
ĖJZENŠTEJN 70
Per celebrare l’anniversario dei settant’anni della morte, uno speciale a più voci con critici cinematografici, curatori, studiosi di cinema su Sergej M. Ėjzenštejn per provare a ripensare la persistente attualità del grande regista sovietico
L’11 febbraio 1948, 70 anni fa, moriva a Mosca Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Non solo il più grande e originale cineasta sovietico degli anni Venti e Trenta, il regista de La corazzata Potëmkin e di Ottobre, ma anche uno dei più grandi pensatori e teorici dell’immagine di tutto il Novecento. In una breve ma intensissima e rocambolesca carriera dove ha attraverso il cinema, il teatro, la fotografia, il disegno, la filosofia, ha vissuto in Russia, in Francia, in Messico e negli Stati Uniti, Ėjzenštejn ha sviluppato un vero e proprio pensiero sul montaggio la cui importanza e ricchezza sono ben lungi dall’essere esaurite anche a distanza di un secolo. Dall’essere una semplice tecnica cinematografica per mettere in sequenza delle immagini, il montaggio diventa per Ėjzenštejn un modo per pensare il legame tra continuità e discontinuità, storia e struttura, immagine e pensiero: un modo per pensare il “nuovo” non come una creazione ex nihilo, ma come qualcosa che prende forma tra i conflitti e le contraddizioni del reale. Un’idea dialettica del cinema e dell’immagine per nulla pacificata ed estremamente rilevante anche per il complesso e contraddittorio panorama visivo attuale.
Per ribadire l’attualità teorica e pratica di Ėjzenštejn nel Settantesimo anniversario della sua morte abbiamo chiesto a sei critici cinematografici, curatori, studiosi di cinema, di scriverci una breve suggestione sul leone di Riga che partisse da una sequenza, da un film, da un aneddoto o da un scritto, a cui abbiamo aggiunto una nota bio-filmografica a cura di Ambra Lancia. Ne è venuto fuori un collage ricchissimo dove emerge un’immagine sorprendente e per certi versi poco conosciuta di Ėjzenštejn, frequentatore dei surrealisti a Parigi, estimatore di Walt Disney a Los Angeles e della sua “contestazione originale dell’immobilità metafisica”, teorico di un “cinema a quattro dimensioni” e addirittura incuriosito da una versione joyciana del Capitale di Marx. Segno che al laboratorio di pensiero che è nato da questo pensatore e regista sovietico sarà necessario continuare a ritornare anche per i tempi a venire. (p.b.)
 Potëmkin, spostare il punctum
Potëmkin, spostare il punctum
di Roberto Silvestri
Montaggio, tonale, ritmico… come contrasto che produce concetti, diceva Ėjzenštejn. Non per la contemplazione del mondo, ma per l’azione nel mondo. Chi scrisse con lui La corazzata Potëmkin, aggiungerà nel 1926: «gli spettatori devono essere sedotti dallo schermo. I loro riflessi vanno addormentati e sopraffatti da nuovi stimoli. Tuttavia, i vecchi e i nuovi riflessi devono avere alcuni punti in comune, perché la dimostrazione di cose poco conosciute o del tutto sconosciute a uno spettatore impreparato è accompagnata da una forte tensione sulla sua percezione, motivo per cui egli manifesta sentimenti di insoddisfazione, sfiducia, freddezza e vera e propria animosità». Merito anche della fotografia di Tissé, ma sembra già Spielberg. Combattere le vecchie idee con le nuove esige riflessi scondizionati, tecniche visuali di seduzione inedite. Prendiamo la scena che più di tutte ha scandalizzato (perfino il rimosso maschilista di Paolo Villaggio). È il punctum – anche se la sequenza è piuttosto trascurata – del Potëmkin. Non la scena del telone, del tutto inventata («la verità non è che uno strumento del verosimile»), ma quella della giovane oratrice rivoluzionaria che, nel porto, invita Odessa alla solidarietà e alla ribellione.
Flash-back. Nel febbraio 1921 Lenin andrò al funerale dell’anarchico Kropotkin che in Memorie di un rivoluzionario (1899) si concentrava sulla pratica didattica, molto costruttiva, dei nichilisti russi dopo le dure repressioni zariste seguiti agli attentati terroristici. Insegnare ai contadini (da poco liberati dalla schiavitù) a leggere e a scrivere, prendendo coscienza dei propri diritti, fu l’obiettivo strategico di un capillare movimento organizzato che costituì lo scheletro e l’anima del futuro partito bolscevico. Furono soprattutto giovani donne, traditrici di classe dell’aristocrazia colta, le animatrici di quell’imponente moto di ribellione, paziente e ben congegnato, precedente alla lunga marcia dentro le istituzioni che portò alle rivoluzioni del 1905 e del 1917. Non è dunque sorprendente trovare alle origini de La corazzata Potëmkin, progetto rievocativo e esempio possibile di “proletarizzazione degli schermi”, una donna, la co-sceneggiatrice armena del film, Nina Agadžanova-Šutko, sedicenne nel 1905 ma dal 1907 membro del partito socialdemocratico russo, 6 arresti e due esili, rivoluzionaria di professione ma anche musicista, storica e letterata. «Piccola, occhi azzurri, schiva e incredibilmente modesta, aveva la straordinaria capacità di raccogliere attorno al suo piccolo samovar un gran numero di ego feriti e di vite abusate dal destino e di metterli sulla via della ragione restituendogli la calma della creatività» – scrisse Ėjzenštejn – «Ognuno ha acquistato fiducia, grazie a lei. Eravamo tutti necessari per la rivoluzione, ognuno a suo modo, individuale, particolare, e persino goffo». Esistevano ancora i commissari del popolo, a controllare dal basso il vertice. Il Pcus di lì a poco li azzerò.
 «It’s catharsis, man! Very classic!»
«It’s catharsis, man! Very classic!»
di Rinaldo Censi
Sono i primi mesi del 1929 quando Ėjzenštejn si accinge a comporre un testo commissionatogli da El Lissitzky e Sophie Küppers, sua moglie. L’hanno invitato a partecipare a una esposizione che si aprirà a Stoccarda nel mese di maggio: Film und Foto. Tra i collaboratori, László Moholy-Nagy, Hans Richter (che si deve occupare della selezione dei film). Lo scopo della mostra è quello di segnalare le nuove interazioni tra arti plastiche: pittura, cinema, architettura, fotografia, ma anche pubblicità, grafica. Il termine “avanguardia” è sulla bocca di molti. Il testo che Ėjzenštejn scrive si intitola provvisoriamente: “Stuttgart”. La sua vicenda è complessa, tortuosa: conosce versioni differenti e traduzioni a volte insoddisfacenti, tali da rendere incomprensibili le sue tesi.
 Sarà l’atmosfera d’avanguardia, il fiato sul collo costruttivista, ma in questo testo Ėjzenštejn prende definitivamente le distanze dalle idee di montaggio esposte da Kulešov e Pudovkin. Il montaggio non svolge un pensiero tramite la successione di pezzi ripresi. «Il montaggio – scrive – non è un pensiero composto da pezzi che si succedono bensì un pensiero che trae origine dallo scontro di due pezzi indipendenti l’uno dall’altro». Questi due pezzi indipendenti non sono “inquadrature” (blocchi di spazio-tempo): piuttosto fotogrammi. Varie sono le possibilità che emergono da questa collisione: dinamismo, disgiunzione, sproporzione, contrappunto cromatico, vibrazione tonale. Sono stimoli. Eccitatori. Nello stesso anno (1929) Ėjzenštejn lavora a un testo intitolato “Cinema in quattro dimensioni”, dove è possibile leggere: «Questi stimoli sono eterogenei per quel che riguarda la loro “natura esterna”, ma la loro essenza di riflessi fisiologici – fisiologici in quanto percepiti psichicamente – li lega in una ferrea unità. Non è che il processo fisiologico di un’attività nervosa superiore». Possiamo trovare qui riferimenti a quel regime estatico a lui così caro?
Sarà l’atmosfera d’avanguardia, il fiato sul collo costruttivista, ma in questo testo Ėjzenštejn prende definitivamente le distanze dalle idee di montaggio esposte da Kulešov e Pudovkin. Il montaggio non svolge un pensiero tramite la successione di pezzi ripresi. «Il montaggio – scrive – non è un pensiero composto da pezzi che si succedono bensì un pensiero che trae origine dallo scontro di due pezzi indipendenti l’uno dall’altro». Questi due pezzi indipendenti non sono “inquadrature” (blocchi di spazio-tempo): piuttosto fotogrammi. Varie sono le possibilità che emergono da questa collisione: dinamismo, disgiunzione, sproporzione, contrappunto cromatico, vibrazione tonale. Sono stimoli. Eccitatori. Nello stesso anno (1929) Ėjzenštejn lavora a un testo intitolato “Cinema in quattro dimensioni”, dove è possibile leggere: «Questi stimoli sono eterogenei per quel che riguarda la loro “natura esterna”, ma la loro essenza di riflessi fisiologici – fisiologici in quanto percepiti psichicamente – li lega in una ferrea unità. Non è che il processo fisiologico di un’attività nervosa superiore». Possiamo trovare qui riferimenti a quel regime estatico a lui così caro?
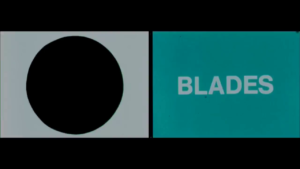 Ottobre e La linea generale sono gli esempi che servono da puntello alla sua argomentazione. Ma se c’è qualcuno che è stato in grado di andare fino in fondo a queste ipotesi, questo è Paul Sharits. T.O.U.C.H.I.N.G (1968), Razor Blades (1965-68) o Epileptic Seizure Comparison (1976), ad esempio: sono assalti ai sensi, portati facendo scontrare metricamente i fotogrammi. Ne emerge un’onda cromatica, una percussione flicker. Questi film sanno di distruzione e violenza; lavorano “fisiologicamente” il centro nervoso: lo amplificano, lo scuotono. Ne emerge pure una strana sensualità, un’armonia cromatica: «Voglio strutturare queste opere non solo per rappresentare dei sentimenti negativi, ma anche per creare le condizioni di una trascendenza estatica della coscienza ordinaria», sosteneva Sharits. Non era un po’ l’obiettivo di Ejzenštejn?
Ottobre e La linea generale sono gli esempi che servono da puntello alla sua argomentazione. Ma se c’è qualcuno che è stato in grado di andare fino in fondo a queste ipotesi, questo è Paul Sharits. T.O.U.C.H.I.N.G (1968), Razor Blades (1965-68) o Epileptic Seizure Comparison (1976), ad esempio: sono assalti ai sensi, portati facendo scontrare metricamente i fotogrammi. Ne emerge un’onda cromatica, una percussione flicker. Questi film sanno di distruzione e violenza; lavorano “fisiologicamente” il centro nervoso: lo amplificano, lo scuotono. Ne emerge pure una strana sensualità, un’armonia cromatica: «Voglio strutturare queste opere non solo per rappresentare dei sentimenti negativi, ma anche per creare le condizioni di una trascendenza estatica della coscienza ordinaria», sosteneva Sharits. Non era un po’ l’obiettivo di Ejzenštejn?
Film di Sharits: capita che qualcuno li trovi sgradevoli. Gli rispondiamo come ha fatto una volta lui, a Parigi: «It’s catharsis, man! Very classic!» *
* Per la storia del testo “Stuttgart”, vedi F. Albera, Eisenstein et le Constructivisme russe, L’Age d’Homme, Losanna, 1990; per le citazioni di E. S.M. Ėjzenštejn, “Drammaturgia della forma cinematografica”, in Il montaggio [a cura di P. Montani], Marsilio,Venezia, 1992 e S.M. Ėjzenštejn, “Cinema in quattro dimensioni”, in La forma cinematografica, Einaudi, Torino, 1986; per le citazioni di Sharits rimandiamo a J.-C. Lebensztejn, “Entretien avec Paul Sharits, précédé de Mémento”, in Écrits sur l’art récent. Brice Marden, Malcolm Morley, Paul Sharits, Aldines, Paris, 1995.
 Ėjzenštejn e Painlevé a Parigi
Ėjzenštejn e Painlevé a Parigi
di Marie Rebecchi
All’inizio degli anni Trenta, nel corso del suo soggiorno parigino (da novembre 1929 a maggio 1930), le vicende intellettuali e personali di Ėjzenštejn s’intrecciano in un primo momento con quelle del fotografo e regista Jean Painlevé, noto per i suoi documentari sulla fauna sottomarina, e più tardi con quelle di Georges Bataille e del gruppo di intellettuali e antropologi che animavano la rivista Documents (1929–1930). Poco dopo il loro incontro a Parigi, Ėjzenštejn e Painlevé stringono una forte amicizia, come dimostra la corrispondenza che hanno mantenuto durante i viaggi di Ėjzenštejn negli Stati Uniti e in Messico (1930–32), fino al suo ritorno in Unione Sovietica.
Nel corso dei loro rendez-vous, Painlevé accompagna Ėjzenštejn in un grand tour parigino: dalla piazza del Palais Royal alla Comédie Française. Painlevé ricorderà così la flânerie parigina: “L’ho portato anche al teatro La Cigale per vedere un eccezionale film americano Red Christmas. In seguito, abbiamo girovagato per la fiera di Clichy … e ci siamo fatti scattare la nostra foto nell’aereo finto.”
La corrispondenza tra i due permette di cogliere, da un lato, l’influenza dei film di Painlevé sul pensiero antropologico di Ėjzenštejn degli anni Trenta, e dall’altro, di riconsiderare il viaggio di Ėjzenštejn a Parigi, e gli scambi con alcune figure di spicco del surrealismo “eterodosso” vicine a Georges Bataille (Painlevé incluso), come un momento decisivo del percorso biografico e intellettuale del regista sovietico. Si potrebbe così avanzare l’ipotesi che alcuni film scientifici di Painlevé, come quello intitolato Mouvement du protoplasme d’elodea Canadensis (1927), abbiano ispirato la teoria di sul “protoplasma”, fondata sull’idea che gli organismi primordiali, che non hanno ancora raggiunto una forma stabile, siano capaci di assumere qualsiasi forma, in una continua serie di metamorfosi e trasformazioni; idea che è a fondamento del saggio di Ėjzenštejn su Walt Disney, pubblicato a più riprese nel corso degli anni Quaranta, e che sarà integrato nelle riflessioni contenute in Metod, la sua opera fondamentale rimasta inedita fino al 2002 e oggi in corso di pubblicazione in inglese, tedesco e italiano.
 Ėjzenštejn e Disney
Ėjzenštejn e Disney
di Mariuccia Ciotta
“La sua arte è magnifica e allegra, scintilla di forme ricercate e brilla di una purezza accecante,” Ėjzenštejn scova tra i fotogrammi disneyani la “metamorfosi infinita,” il mutare delle creature che passano da una all’altra, “contestazione originale dell’immobilità metafisica,” tanto che la sua “opera sorpassa tutte le altre che ho potuto conoscere.” La creatura esce da sé, rompe gli argini delle linee che la contengono, il suo contorno si fa tremolante, vibra tutto come se l’anima volesse uscire dal corpo…. Ėjzenštejn è rapito dall’ex-stasi disneyana e davanti alla silly symphony Merbabies vedrà “la rivolta dello stato di cose esistenti.” Ai suoi studenti insegna l’uso non rappresentativo della musica nei film disneyani e si entusiasma davanti al dinamismo acustico-visivo-cromatico, all’ “ordigno sinestetico,” macchina delle emozioni che li accomuna. Ėjzenštejn vede in Walt Disney un operatore nel campo dell’arte moderna e un inventore di macchinati futuribili, come gli altoparlanti stereofonici usati per Fantasia, e che non riuscì a realizzare per La Cavalcata delle Valchirie al Teatro Bolschoi di Mosca. Sperimentazioni parallele. Persino Ivan il Terribile arrossisce per un afflusso di colore al volto secondo lo stato confusionale dei Tre porcellini. E ogni linea si intreccia con i disegni deformi, terrificanti e gloriosi dei nuovi mondi in sintonia tra loro. La Russia rivoluzionaria di Ėjzenštejn e l’America del New Deal di Disney. Eppure la relazione tra il regista de La corazzata Potëmkin e il papà di Mickey Mouse resta sotto silenzio. Immortalati a braccetto accanto al piccolo Studio di Los Angeles al numero 2719 di Hyperyon Avenue, anno 1930, i due guardano ammirati il Topo, che avrà l’onore di un “provino” eseguito da Ėjzenštejn durante il soggiorno californiano. Un frammento di venti secondi da inserire in un progetto dell’artista dell’avanguardia russa El Lissitzky che immaginava un set mentale tridimensionale. Cinema del pensiero.
 Ogni stacco un colpo di scalpello
Ogni stacco un colpo di scalpello
di Roberto Manassero
Mi è capitato di far vedere a degli studenti alcune sequenze di La corazzata Potëmkin: le donne che salutano la corazzata dalla città, i piedi, l’ombello, la scalinata, ovviamente la culla e poi alla fine i leoni di marmo. Su questi ultimi ho anche citato Kozincev e cercato di spiegare (sempre che ne sia capace) ciò che il regista ed ex collaboratore di Ėjzenštejn intendeva quando ha scritto che il cinema del suo maestro non può essere comparato con immagini umane, e solo quei tre leoni sono in grado di adempiere al compito di riassumerla… Insomma: la reazione di chi vedeva per la prima volta un pezzo di un film di Ėjzenštejn (figuriamoci vederlo per intero) fu che di quei leoni nemmeno s’era accorto; o se l’aveva fatto, il passaggio era stato comunque così rapido da non far pensare a un possibile significato. Quei leoni così famosi, dunque, al di là dell’attenzione o dell’interesse del pubblico, oggi rischiano di non avere più valore, di non essere nemmeno notati. E non per colpa di Ėjzenštejn, credo, ma per le mille ragioni per cui oggi non ci si accorge di parecchie cose che passano su uno schermo. Se oggi un regista dovesse chiedere a un’immagine inanimata di assumere simbolicamente il senso di un film, probabilmente le darebbe più tempo. Ėjzenštejn, invece, a ogni sua immagine dava l’opportunità di farsi strada da sé nel film; la mostrava nella sua nudità di marmo, di stoffa (nella scena magnifica della fucilazione mancata sul ponte della nave, con il lenzuolo che resta sullo schermo qualche secondo di troppo per essere bianco, vuoto, ma non abbastanza per diventare straziante), di carne putrida o di carne ferita. Ogni stacco un colpo di scalpello sulla superficie del film: un gesto singolo che partecipa a una creazione complessiva, pensata e realizzata come una statua. Credo intendesse questo, Kozincev, quando dava tutto quel peso ai leoni. Credo sia questo che oggi si debba recuperare di Ėjzenštejn, mostrando i suoi e fermandone il furore.
 Il Capitale… di James Joyce
Il Capitale… di James Joyce
di Pietro Bianchi
È possibile creare un’immagine del capitalismo? È possibile dare forma visiva a uno degli oggetti non-totalizzabili per eccellenza, che però regola la totalità dei rapporti sociali e delle nostre forme di vita? Sergej Ėjzenštejn ci provò. O quanto meno spese una buona fetta del suo tempo a pensare a come farlo. Il risultato sono una ventina di pagine scritte tra l’autunno del 1927 e la primavera del 1928 sull’onda dell’entusiasmo per la realizzazione di Ottobre nelle quali si alternano divagazioni dispersive a vere e proprie illuminazioni teoriche e dove emerge l’abbozzo di un progetto ambizioso quanto folle: fare un film su Il Capitale di Karl Marx.
Ėjzenštejn ebbe l’idea di farsi aiutare da un’opera che a prima vista sembrava lontanissima da Marx: l’Ulisse di Joyce. Nella nota del 6 aprile 1928 scrive che «Il primo abbozzo strutturale del Capitale consiste nel prendere lo svolgimento banale di un avvenimento assolutamente privo di riferimenti. Diciamo ‘la giornata di un uomo’ […]. E gli elementi di questa catena sono momenti di partenza per la formazione di associazioni. […] Per orientarci possiamo prendere qualcosa di simile dall’Ulisse. Joyce può aiutare la mia intenzione». Spiegherà poi che si riferiva a un capitolo dell’Ulisse dove dal problema di come fare bollire una teiera partono tutta una lunga catena di associazioni e divagazioni riguardo a dove venga l’acqua, quale sia il funzionamento degli impianti idrici, come arrivi a casa di Bloom etc. Ciò che dunque affascina il regista di Riga è il “metodo”, cioè l’incedere interrogativo che fa sì che la banalità dell’oggetto immediato venga “aperta” verso i diversi livelli di mediazione che hanno reso possibile il suo apparire qui e ora. Come ha notato Fredric Jameson, l’idea di Ėjzenštejn si basa su «una versione marxiana dell’associazione libera freudiana – la catena causale che riporta la superficie dell’esperienza e della vita quotidiana alla stessa fonte della produzione». E in effetti non è molto diverso dall’argomentazione di Marx ne Il Capitale, dove si parte dall’immediatezza della merce, ma ben presto si spiega che ciò che appare concreto e immediato è in realtà prodotto dall’astrazione concreta del valore, che implica un complessa organizzazione della produzione, un certo sviluppo del sistema del credito, del commercio, del mercato mondiale ecc.
L’utopia di Ejzenštein era quella di usare le immagini per produrre in modo diretto, quasi corporeo, attraverso un sistema un po’ bizzarro di associazioni libere visive un affetto: quello della comprensione intellettuale del modo di produzione capitalistico. L’arte didattica doveva essere una produzione a mezzo di immagini di stimolazioni fisiche, tra cui quella intellettuale; e questo film doveva essere uno strumento didattico per fare comprendere anche al contadino analfabeta o all’umile operaio come funzionava il modo di produzione capitalistico. Per fargli comprendere insomma che lui in quell’immagine ne era già incluso e che lo sguardo non è un problema di contemplazione, ma semmai di posizione. Perché se «il cinema ‘antico’ riprendeva una azione da molti punti di vista. Quello nuovo monta un punto di vista da molte azioni». Il problema de Il Capitale non era quello di guardarlo, ma di trovare il punto di vista giusto per agire.
