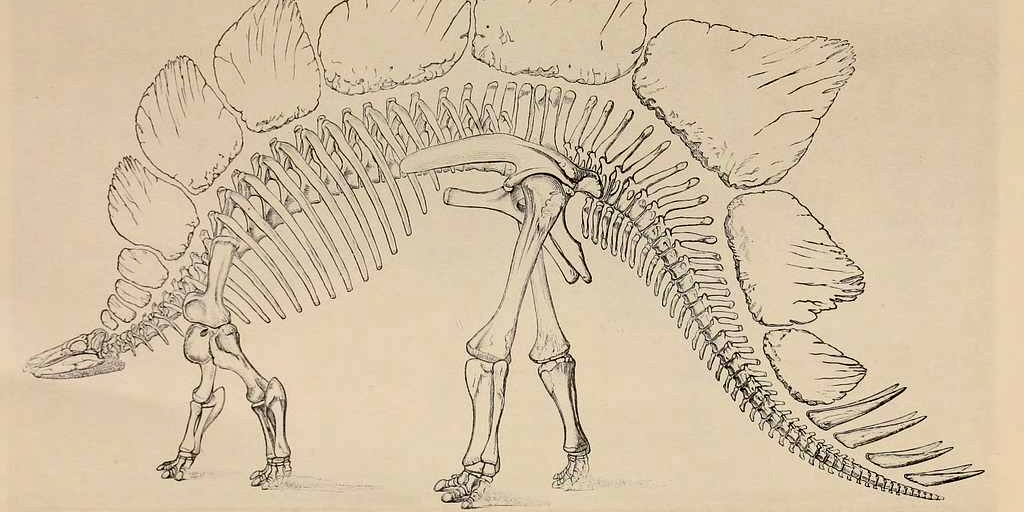ITALIA

CPR di Torino: una storia di migrazione, tra doppio carcere e doppia assenza
Tra il 7 e l’8 luglio viene ritrovato il corpo senza vita di un uomo. È un migrante di origine bengalese, in stato di trattenimento presso il Centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di Torino.
Un uomo di origine bengalese, Faisal Hossai, di 32 anni, è deceduto ieri presso il CPR di Torino. Secondo quanto riportato da alcune testimonianze, l’uomo era stato posto in isolamento per ragioni non ancora chiarite, nonostante tale disposizione punitiva non sia prevista all’interno di queste tipologie di strutture. Alla notizia della morte del compagno del centro, di cui ancora erano ignote le cause, alcuni migranti hanno iniziato una protesta che ha causato piccoli incendi in alcuni moduli della struttura. A svolgere le indagini sono state la squadra mobile della questura di Torino e la procura, al termine delle quali è stata esclusa qualsiasi ipotesi delittuosa e il decesso è stato associato a un arresto cardiaco.
Dalle prime ore di lunedì 8 luglio, i reclusi del centro hanno messo a fuoco materassi e mobili, mentre in serata attorno alle mura del CPR si sono raccolti numerosi solidali. Da dentro arrivavano forti le voci delle persone rinchiuse e il grido “libertà” ha accompagnato lo svolgersi del presidio. La polizia ha risposto sparando lacrimogeni dentro al CPR e al tentativo di blocco da parte dei manifestanti di una delle strade adiacenti sono partite delle violente cariche.
Il giorno successivo i manifestanti erano più numerosi e dopo aver bloccato la strada sono partiti in corteo attorno al quartiere per poi tornare di fronte al CPR e protestare contro le condizioni tristemente note di queste strutture di detenzione.
Gli abusi e le violenze all’interno dei CPR non sono storia nuova e da anni vengono denunciate da chi le subisce o da chi ne è testimone. Ma il trattamento dei reclusi, le continue violazioni e storie tragiche che si sono consumate all’interno di questi luoghi rappresentano una contraddizione talmente netta con lo stato di diritto che spesso sono state ignorate dalla politica istituzionale. Di fronte al vergognoso silenzio delle istituzioni competenti le persone trattenute nel CPR di Corso Brunelleschi stanno portando avanti dal mese di giugno tentativi per mettere in luce il volto oppressivo e violento che contraddistingue queste strutture, figlie di un sistema che con lo scorso decreto legge Minniti-Orlando e con l’attuale decreto Salvini ha posto le basi normative per estendersi in tutte le regioni italiane e che ha visto aumentare il periodo di trattenimento fino a 180 giorni.
Il CPR è di fatto un luogo di confinamento per migranti sprovvisti di regolare titolo di soggiorno, che si trovano al loro interno con lo status di trattenuti o di “ospiti”. La loro presenza corrisponde sotto innumerevoli aspetti a una vera e propria detenzione: la privazione della libertà personale e un trattamento coercitivo sono la cifra di questa permanenza forzata. A tutto questo si aggiunge il senso di segregazione e reclusione che comincia molto prima della misura punitiva dell’isolamento nei casi in cui il soggetto vada punito o “protetto”, in quanto alle persone è proibito ricevere visite e il diritto alla difesa legale viene reso sempre più arduo. La situazione degli ospiti verte in situazioni preoccupanti, sia dal punto di vista della vita quotidiana, che scorre senza alcuna attività che impegni le ore della giornata, il che comporta delle evidenti ripercussioni sulla salute psicofisica di quanti vi dimorano anche oltre sei mesi, sia per quanto riguarda le condizioni materiali degli ambienti, lasciati in condizioni di deterioramento strutturale e igienico.
A sua volta, il CPR è solo uno dei luoghi preposti al trattenimento, identificazione e smistamento dei migranti. La storia tormentata dell’accoglienza in Italia si infoltisce di sigle vecchie e nuove: alle prime procedure d’identificazione e smistamento effettuate negli hotspot, si passa alla prima accoglienza nei Cara (centri d’accoglienza per i richiedenti asilo), Cpa (centri di prima accoglienza) e Cpsa (centri di primo soccorso e accoglienza). L’alternativa a quest’ultimi, nello specifico per coloro i cui requisiti non permettono di fare domanda di protezione, i cosiddetti clandestini, gli irregolari, è il CPR, un tempo CPT (centri di permanenza temporanea), poi CIE (centri di identificazione ed espulsione), in attesa del rimpatrio.
I Centri di trattenimento, con le loro varie ridenominazioni, realizzano in Italia lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Il CPR si delinea pertanto come deposito umano dove vengono ammassati tutti coloro la cui mobilità viene interrotta da una categorizzazione artificiale che stabilisce chi sia meritevole di migrare e chi rappresenta, per la sua stessa esistenza in territorio italiano, il nemico perseguitabile di una guerra ormai dichiarata contro lo straniero.
I casi di torture e maltrattamenti nelle varie strutture destinate ai migranti dopo l’approdo in Italia sono numerosi e spesso denunciati da organizzazioni solidali, non governative, o dagli stessi ospiti. A loro volta tali torture assumono varie forme, alcune convenzionali e collaudate, altre meno appariscenti e subdole: dal mancato soccorso in caso di malattia o malessere, alle varie forme di proibizione arbitraria o vessazioni. La cultura della violenza tipica delle strutture detentive non vive quindi solo di norme ma di pratiche che ledono la dignità umana. La stessa storia di Faisal ci riporta un caso emblematico in cui le necessità di una persona vengono trattate secondo una logica punitiva e discriminatoria. Secondo alcune fonti giornalistiche, era stata diffusa la notizia che Faisal fosse stato vittima di uno stupro e successivamente costretto all’isolamento nella piccola struttura dell’Ospedaletto. Un episodio a sua volta realmente accaduto, ma che coinvolge un’altra persona trattenuta nel CPR e che forse, senza la morte di Faisal, sarebbe rimasta sepolta tra le mura asfissianti delle celle. Sta di fatto che, in maniera illegittima, Faisal viene posto in isolamento, dove verrà lasciato per più di due settimane. La cella d’isolamento è da sempre il luogo dove viene scontata la sanzione disciplinare per eccellenza, dove vengono rinchiuse le persone difficili o i detenuti più a rischio. È proprio in questi spazi vuoti e disadorni che l’essere umano si trova in un “secondo carcere”, dove la propria psiche subisce la privazione definitiva attraverso l’allontanamento da stimoli e socialità.
Là dove la privazione della libertà non è ufficializzata o riconoscibile, tutto tace. A restituire dignità a quanti vengono abbandonati nei luoghi di reclusione sono quanti continuano a denunciare questi abusi. Dall’8 al 9 luglio presidi e proteste si sono susseguiti sotto il CPR, sedati poi dall’intervento delle forze dell’ordine. Non è però un caso isolato. L’estate scorsa, il centro era stato danneggiato da un incendio doloso. Alcune delle persone recluse nel Cpr sono salite sui tetti, in segno di protesta per le condizioni nelle quali erano costrette a vivere. In seguito alcuni moduli abitativi vennero dati alle fiamme da ragazzi maghrebini reclusi da oltre un mese e mezzo nel centro. Qualche mese fa, l’avvocato Cristiano Prestinenzi ha definito la situazione nel CPR «una grave violazione di diritti inalienabili dell’individuo riconosciuti dalla Costituzione, dai trattati internazionali e, più in generale, dai principi basilari su cui si regge uno stato democratico». Il riferimento era ad un uomo ospite del centro, trattenuto da oltre un mese al CPR, che non riusciva ad avere la documentazione sanitaria che lo riguardava.
Questo fatto di cronaca è un indicatore di un problema politico che coinvolge molti aspetti della nostra quotidianità, a partire dalla capacità di decodificare la realtà e declinare il conflitto oltre l’istintività o l’addomesticazione mediatica. Simili episodi racchiudono sempre un insieme di segnali interpretativi: la storia di Faisal si iscrive in un contesto che vorrebbe definirsi come la normalità del percorso del migrante dentro i confini nazionali, un percorso studiato a norma per irrobustire barriere fisiche e simboliche, determinare spazi d’esclusione e rafforzare linguaggi accusatori.
La storia di Faisal si pone nella lunga lista di persone costrette in un regime migratorio devastante che ridimensiona la narrazione dell’esistenza e della morte, mostrandosi come parabola dell’invisibilità a cui molti soggetti migranti sono destinati e determinando quell’immagine di “doppia assenza” (dalla propria società d’origine e da quella d’arrivo) descritta dal sociologo Abdelmalek Sayad. L’approccio allo straniero, meritevole all’accoglienza o clandestino irregolare, dissimula, attraverso un complesso di disposizioni normative, la definizione arbitraria del concetto d’accoglienza, caratterizzato da modalità predominanti basate sul concetto di ordine e di produttività, che spesso si risolvono in meccanismi d’esclusione, mercificazione e negazione della soggettività politica delle persone migranti.
Le proteste che da anni interessano i CIE di tutta Italia e che spesso scaturiscono da episodi isolati non sono mai casi circoscritti. Le rivendicazioni hanno un obiettivo più generale che attacca l’approccio costrittivo e il clima di disciplinamento di queste strutture. Ci troviamo davanti all’applicazione di una precisa logica che traduce il diritto a migrare in una colpa da espiare con il carcere, per cui dopo la prima selezione di chi è assimilabile a un’ideale di normalità e produttività, verrà estratto chi invece deve essere punito, respinto ed espulso.