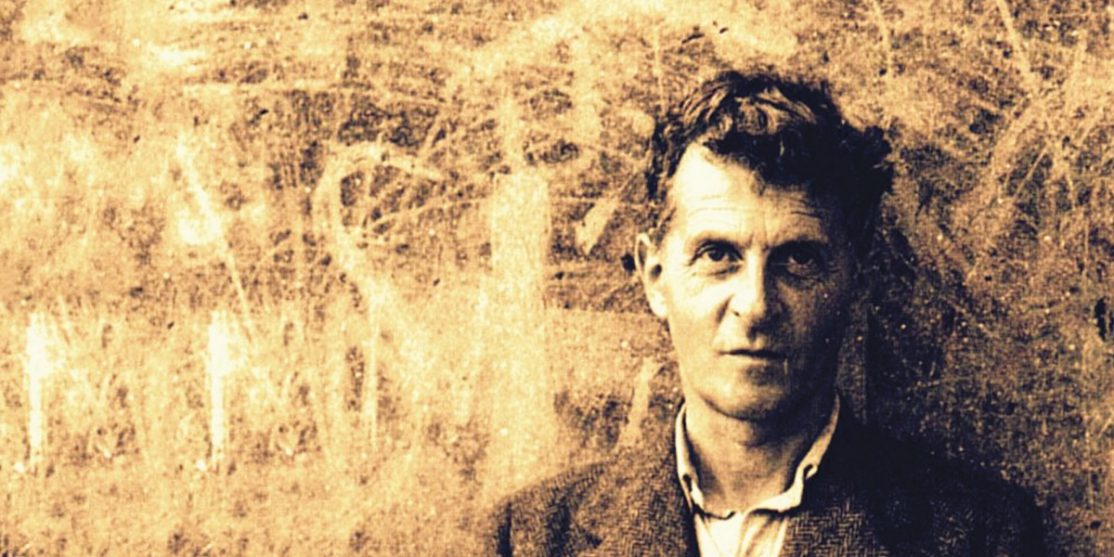ROMA
C17: Critica dell’economia politica

Cos’è diventato il Capitale nel XXI secolo? Come intendere la “singolarità” del capitalismo neoliberale? Si tratterà per un verso di qualificare – su scala globale – la nuova composizione del lavoro e dello sfruttamento. Ma anche, chiaramente, la composizione del Capitale stesso, tra estrazione del valore e finanza. Per l’altro di percorrere gli antagonismi e la produzione di soggettività (ambivalente) che segnano das Kapital contemporaneo.
Intervengono: Bret Neilson, Ceren Özselçuk, Christian Marazzi, Franco Berardi “Bifo”, Silvia Federici, Kaushik Sunderan Rajan, Riccardo Bellofiore.
1. Aggiornare la critica
Condizione e finalità della critica dell’economia politica borghese è, per Marx, l’esistenza delle classi e la loro incessante lotta: attraverso la «scoperta» dello sfruttamento, la critica marxiana rende visibile la società divisa in luogo dell’individuo isolato e la storia in luogo dell’eternità delle categorie dell’economia politica. Tuttavia, il nuovo paradigma economico-politico «borghese» oggi dominante ha radicalmente modificato il suo oggetto e le forme attraverso cui mistifica il conflitto di classe: alle classi sociali è stato sostituito l’individuo proprietario, alla legge del valore-lavoro quella del valore-utilità, fondando l’origine dell’economia sullo scambio di mercato anziché sulla produzione. In che modo una critica dell’economia politica adeguata al tempo presente deve confrontarsi con queste modifiche nell’oggetto della scienza economica?
2. Crisi e lotte
La crisi economica internazionale ha ormai perso il suo statuto di eccezionalità e costituisce anzi un nuovo modo di regolazione istituzionale, che si rafforza tanto più quanto i motivi della crisi vengono lasciati inalterati. Alcuni economisti mainstream hanno ripreso lo scenario della secular stagnation. Ma ciò che essi non possono e non vogliono vedere è il rapporto tra lotte e crisi economica. Storicamente, sul finire dell’Ottocento e più di recente nella crisi del ’29, sono sempre state le lotte a interrompere la congiuntura della crisi, imponendo nel contempo le condizioni per una ristrutturazione complessiva dei rapporti economici e sociali, e aprendo a fasi di radicali mutamenti istituzionali. In che modo è possibile ripensare oggi la relazione tra lotte, riforme e ristrutturazione capitalistica?
3. Globalizzazione e interdipendenza
Se per Marx la costituzione del mercato mondiale è una tendenza fin dall’inizio immanente allo sviluppo capitalistico, l’attuale globalizzazione dell’economia sembra inverarla fino al punto della sua massima visibilità. Tuttavia, l’uniformazione globale del mercato ha portato anche alla luce nuove forme di segmentazione dello spazio economico mettendo in discussione le teorie classiche della «divisione internazionale del lavoro». Le coordinate con le quali si sono a lungo analizzate le relazioni di gerarchia e dipendenza sulla scena mondiale, risultano da un lato indebolite, e dall’altro, sembrano caratterizzare dall’interno i singoli spazi regionali, nazionali e urbani. Quanto l’eterogeneità dello spazio geografico ci aiuta a comprendere le mutazioni del rapporti fra le diverse forme di sfruttamento e la diffusione di spazi economici alternativi?
4. Riproduzione sociale
Diversamente dall’economia classica e dalle versioni più recenti della teoria economica dominante, per Marx il soggetto che vende la forza lavoro sul mercato non è un soggetto disincarnato ma coincide con il corpo vivente nella sua definizione più ampia ed estesa. A partire da queste premesse e superando i limiti dell’analisi marxiana, la critica femminista ha posto la «riproduzione sociale» e il lavoro domestico come base per un ripensamento complessivo del lavoro, mostrando l’esistenza di attività essenziali per il funzionamento del capitalismo, benché non retribuite e non riconosciute socialmente. In che termini il paradigma della riproduzione sociale può, oggi, presentarsi come un asse fondamentale della critica dell’economia politica anche oltre la sua stretta associazione con la dimensione di genere e il lavoro domestico?
5. Economia collaborativa
I discorsi sull’«economia collaborativa» si sono particolarmente diffusi con il prolungarsi della crisi. Alcuni autori vedono nelle tecnologie di rete e nelle pratiche di condivisione una tendenza spontanea al superamento dell’economia di mercato e dello stesso capitalismo. Contro questa concezione irenica del mutamento sociale sembra risuonare il giudizio che Marx ed Engels espressero sui socialisti utopistici: «Al posto dell’attività sociale deve subentrare la loro individuale azione inventiva; al posto delle condizioni storiche dell’emancipazione, subentrano condizioni immaginarie; al posto dell’organizzazione progressiva del proletariato in classe, deve subentrare un’organizzazione della società macchinata per l’occasione». Quanto la condivisione e la cooperazione, potenziate dalle tecnologie di rete, vanno pensate come oggetto di una nuova valorizzazione capitalistica e quanto come emersioni di nuove prassi istituenti centrate sul Comune?
6. Capitale finanziario
All’origine del ciclo neoliberale è possibile collocare il radicale cambiamento della funzione del capitale finanziario globale. Non più «capitale fittizio», ovvero produzione di moneta a mezzo di moneta, senza alcuna mediazione con le fasi della produzione capitalistica, bensì capitale effettivamente produttivo, capace di svolgere una funzione ordinatrice e gerarchizzante rispetto a tutte le altre «porzioni di capitale». La cosiddetta finanziarizzazione dell’economia ha comportato una trasformazione delle principali relazioni monetarie, come quella del debito. L’indebitamento – pubblico e privato – si presenta sempre più come una delle più rilevanti forme di assoggettamento sociale di produzione del soggetto neoliberale. Se il nuovo «uso capitalistico» del debito pubblico mette in questione la relazione tra spesa pubblica e ruolo delle banche centrali, il debito privato interroga alla radice la trasformazione della relazione salariale. In che modo l’esercizio del credito da parte delle banche si collega allo sfruttamento derivante dalla relazione salariale?