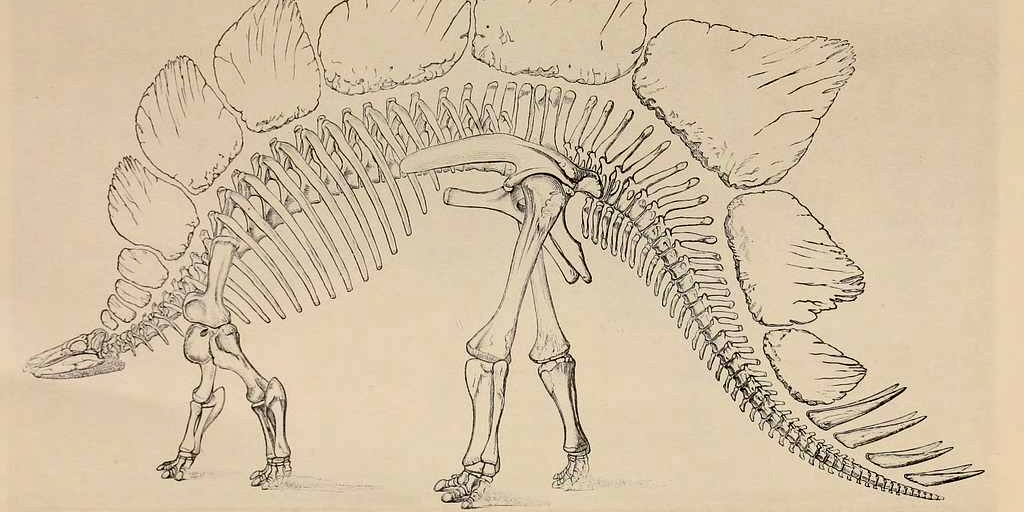ROMA
C’è chi piange sulla città coloniale

Riflessioni collettive sull’ultima tornata elettorale.
In un lucido saggio del 2015 che analizzava la forma della politica romana, studiandone i germi antichi che – da destra e da sinistra – possono spiegare l’origine di Mafia Capitale, il democratico Walter Tocci chiamava Roma città coloniale. L’espressione, che sta a segnalare la somiglianza di Roma più alle metropoli sudamericane che alle capitali nordeuropee, nel segno di una crescita urbanistica abnorme e rapidissima, malata, è mutuata dalla letteratura comunista di Insolera: l’autore di quella Roma Moderna che – nei decenni prima della caduta del Muro – aveva costituito il vangelo di ogni militante piccista capitolino e la cui ultima edizione aveva visto la partecipazione di Paolo Berdini; lo stesso Berdini a cui Virginia Raggi ha deciso di affidare l’assessorato all’urbanistica e – con esso – la battaglia contro i palazzinari, contro i signori del cemento e delle mazzette, in nome e per conto dei 770mila elettori che nell’urna hanno detto all’avvocata Raggi, a Virginia: vai te, cambia tutto. Ma quell’espressione, Roma città coloniale, cita in realtà un verso di Pasolini scritto per il centenario dell’Urbe: «Non si piange su una città coloniale / eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole / calante / e fu spietata».
Spietata. Così è stata la tornata elettorale: immensamente spietata. Spietata nei confronti di Matteo Renzi, del Partito della Nazione, del Partito Democratico. Spietata contro quel blocco di potere neoliberale, arrogante, violento, sordo, mafioso. Spietata contro la sua forma antica: Piero Fassino a Torino, simbolo di un apparato rossastro che si nutre di nostalgie del fordismo, quello della città-vetrina e impoverita, quello della TAV a tutti i costi. Spietata contro la sua forma moderna, rottamatrice: Roberto Giachetti a Roma, radicale, radicato saldamente tra Parioli ed Esquilino (meno altrove), renziano per scelta e anti-mariniano per professione, un po’ smart-city e un po’ questore, un po’ Lorenza Baroncelli e un po’ Francesco Tagliente (e però vi ricordate che fighe le Olimpiadi di Roma ’60?).
Spietata contro la sua non-forma: Valeria Valente a Napoli, incapace di ricevere neppure i voti di scambio, tanto da costringere i dem partenopei a dare inutili indicazioni di voto alla destra peggiore del Mediterraneo, quella di Lettieri. Spietata contro il centro-sinistra, che vince solo a Milano, solo laddove dismette ogni ambiguità e si fa nitidamente centro-destra, con Beppe Sala e con Expo, a chiarire l’equivoco ancora troppo arancione (suo malgrado) di Pisapia, in un ballottaggio che poteva benissimo ridursi a un pari o dispari, tale l’identità dei concorrenti. Nonostante i tentativi di certa stampa, in prima fila la Repubblica dell’insider trader De Benedetti, che ha usato ogni arma a disposizione per evitare che il colpo all’establishment arrivasse troppo forte, la botta è arrivata. La stessa Repubblica che il day after tomorrow, ha dato prova di un capolavoro di trasformismo quando il gioco era già scaricare il renzismo e ridare spazio agli applausi di Concita De Gregorio per la vittoria delle donne dei 5 Stelle. Di questa spietatezza delle urne, di questo calcio in faccia a Matteo Renzi, agli autori del Jobs Act, della Buona Scuola, dello Sblocca Italia, c’è da festeggiare. Festeggiare, senza remore.
No, nessuna ambiguità, per carità: non abbiamo vinto «noi». A Roma non ha vinto l’anticapitalismo, non ha vinto un’ipotesi di alternativa radicale alle politiche neoliberali. Non ha vinto l’europeismo radicale. Non ha vinto il sogno di abbattere i confini e le frontiere. Non ha vinto la sfida del sindacalismo sociale. Non ha vinto il progetto di costruzione di autonomie locali dotate di potere di veto. Non hanno vinto le istituzioni del comune. Non ha vinto un neonato potere costituente capace di produrre nuovo senso, nuove comunità, nuovi valori, nuove norme. Non ha vinto la mobilitazione organizzata e cosciente dei precari, dei senza casa, degli sfruttati, degli impoveriti, dei migranti, dei lavoratori poveri. Non ancora.
Eppure questo voto marca un altro segno, ci impone di cercare un nuovo senso. Un senso chiaramente che non può affermarsi univoco, lineare, compatto, come d’altronde non univoca, né lineare, né compatta è un’analisi materialista. Fino alla scorsa domenica era semplice riferirsi al consenso elettorale del Movimento 5 Stelle alludendo alla capacità, propria di un qualsiasi agglomerato populista, di convogliare i voti che scaturiscono dalla rabbia e dall’insoddisfazione, dal disincanto fino al qualunquismo. Dopo gli ultimi risultati elettorali gli stessi organi d’informazione sembrano costretti a dismettere questa lettura, non più adeguata a descrivere la complessità dell’attuale situazione sociale e politica. Non sembra più possibile infatti derubricare il consenso elettorale del movimento di Grillo a mero voto di protesta: unica forza in grado di conservare significativamente il numero di voti, il Movimento 5 Stelle sembra per la prima volta esser riuscito a consolidare un proprio bacino elettorale. A dispetto della politica del governo Renzi, che ha definitivamente disgregato il partito rendendolo irriconoscibile a quelle fasce sociali che in passato ne costituivano il core elettorale.
Significherà qualcosa quella mappa di Roma che colora la distribuzione geografica (leggi: economica, sociale) del voto al Movimento 5 Stelle e a Virginia Raggi, che conquista la città consolidata fuori le Mura Aureliane, e si contende con la destra di Meloni le periferie più estreme, verso e oltre il Gra. Un voto di parte dei senza parte: l’espressione – più inedita che mai – della ricerca di un’altra chance, di una possibilità di cambiamento, di un’altra opportunità, di fronte alla disillusione per tutte le promesse tradite, dalla destra e dalla sinistra. Al di là dell’analisi politologica dei flussi elettorali, c’è un sentimento, un’intensità in questo voto, passioni felici e tristi tutte da capire, ascoltare, interpretare. Sono le passioni di un pezzo di città, fino a ieri privo di uno spazio politico, che tenta di riprendersene uno, fosse solo premiando i 5 stelle per vendicarsi di chi ha governato la città negli ultimi vent’anni. Lo fa talvolta con convinzione, talvolta con scetticismo, quasi sempre con rabbia: lo fa perché ha poco o nulla da perdere. Nel ballottaggio – dispositivo che costitutivamente implica la polarizzazione massima del dibattito politico – quel pezzo di città sceglie di sparigliare le carte, di ribaltare il tavolo, di assestare un colpo (si spera) definitivo agli equilibri di un sistema politico in coma irreversibile, stoppando la pellicola di un film già visto, identico a se stesso, cento e cento volte.
Il nemico, in quel voto, sono soprattutto le élites, i soliti noti, quelli che stanno lì da sempre o i loro eredi, i blocchi di potere inscalfibili, inarrivabili, irredimibili. C’è un utilizzo completamente strumentale del voto, che abbandona qualunque essenzialismo del momento elettorale: non si aderisce alla promessa della rappresentanza, si pratica come obiettivo la vendetta contro chi ha detenuto il potere negli ultimi 25 anni, vi può essere così in nuce la promessa della costruzione di un altro possibile.
Crediamo che questo voto segni soprattutto una riapertura del campo democratico, finora chiuso dall’arroganza della narrazione renziana che sembrava invincibile e che invece si scopre oggi vulnerabile (in Italia quanto in Europa). Ma questa riapertura del campo democratico – impossibile, conviene ripeterlo, fino al perdurare del blocco di consenso renziano (effettivo o presunto) in assenza di movimenti di massa – non attiene soltanto al rapporto tra quel blocco governativo e lo spazio politico-sociale della sua opposizione: attiene anche, oggi più di ieri, al cambio di fase che si è ora prodotto rispetto al Movimento 5 Stelle e grazie ad esso, al suo interno e al suo esterno.
Dinamopress ha scelto di leggere e criticare il grillismo, sin dalla sua nascita, per i suoi aspetti più deteriori: la forma aziendalistica del partito-nonpartito-movimento, fondata su assetti proprietari; l’uso televisivo della rete, come dispositivo di propaganda più che di partecipazione; l’ambiguità degli enunciati politici, che immediatamente segnava lo scadimento dal post-ideologico al qualunquista. Ma oltre, e molto più di questo, nel Movimento 5 Stelle abbiamo osservato – e fermamente criticato – la loro funzione indiscutibile di congelamento delle possibilità della mobilitazione sociale: la lenta e inarrestabile affermazione di un soggetto politico in grado di stornare le istanze anti-sistema, anti-élite, anti-governative verso quella opzione elettorale, espressamente alternativa e non parallela (né collaterale, né) a quella della mobilitazione sociale, ha riaffermato l’efficacia dello schema opinione pubblica/rappresentanza, rinnovandolo certo, ma riconducendolo alla più classica delle forme di verticalizzazione. In altre parole, la dirompente affermazione elettorale non ha prodotto alcuna soggettivazione, non si è cioè basata, né ha prodotto, alcun corpo collettivo. Il voto si è nutrito (e ancora oggi continua a nutrirsi) di una sostanziale atomizzazione sociale. In molti casi gli elettori di Grillo si presentano come soli e atomizzati. Manca il momento della socializzazione, anche di quella negativa, basata sulle passioni tristi.
Ci sembra che il passaggio del Movimento 5 Stelle al governo delle grandi città, da un lato, e la modificazione evidente ed effettiva della sua forma (e dunque strategia) politica, dall’altro, costituiscano de facto un passaggio di fase o meglio lo costringano ad esso. Proprio dalla natura di quel voto, soprattutto dall’altissimo livello di aspettativa riposto in esso, può infatti scaturire la liberazione di istanze molecolari nella società. Istanze scomposte, multiformi, sperabilmente vigorose; istanze probabilmente contraddittorie, democratiche e/o decisioniste, progressiste e/o reazionarie, garantiste e/o giustizialiste; in ogni caso, istanze liberate dalla decennale ibernazione nella sfera dell’opinione. La capacità del Movimento 5 Stelle di catalizzare (in determinati contesti metropolitani) queste istanze, destabilizzando il quadro politico, è la sua caratteristica oggi più interessante, specie per chi non ha mai smesso di proporsi di ri-politicizzare e riattivare la società. Lo è molto molto di più della sua funzione – pure incontestabile – di canalizzazione dei flussi elettorali: di quella funzione, cioè, a cui prioritariamente (se non unicamente) guardano coloro i quali – tardivamente armati degli strumenti neoliberali della scienza politica classica – si affrettano a leggere nel “fenomeno Raggi” la nemesi del nuovo «partito pigliatutto».
Oltre e contro la meteorologia dei flussi elettorali, c’è infatti la constatazione dello spostamento irreversibile del baricentro del discorso politico dall’asse destra/sinistra all’asse alto/basso. Uno spostamento in linea con la ridefinizione delle forme della politica in tutta Europa e in tante parti del mondo; uno spostamento non certo neutro e tuttavia (come è ovvio) neppure naturalmente teso all’affermazione di istanze di emancipazione. Uno spostamento, insomma, che consegna ai movimenti sociali urbani – e unicamente a loro – il compito di codificare esattamente quel basso. Codificare il basso, cioè interpretare politicamente, concretamente, materialmente questa spinta anti-elitista. Solo in questa maniera, solo con questo obiettivo si può ingaggiare una dialettica sana, produttiva, con il Movimento 5 Stelle, senza esserne subalterni né invidiosi: senza, cioè, prenderli fuori tempo massimo a referenti di un’opzione di alleanza politica; senza vedere in loro il campo per un’operazione di entrismo; senza osservarli come l’espressione di un mero (sempliciotto, sprovveduto) potere destituente, magari sfoggiando il peggior pasolinismo sociologico d’accatto. ll basso è uno spazio che dobbiamo necessariamente qualificare da pratiche sociali e conflittuali, che disegni la rottura tra gli ultimi e chi detiene il potere sulla nostra città, non semplicemente lo iato tra un popolo di indistinti “cittadini” e la classe politica.
Potere destituente che, peraltro, va anch’esso riorganizzato e organizzato, facendo leva su quanto di politicamente più ghiotto esso offre – da oggi, da domani – a Roma e altrove: ossia, precisamente, la frattura di blocchi di potere urbano, delle pratiche collusive, del neocorporativiso mafioso o mafiosetto, che nei flussi di denaro dall’Amministrazione al privato (privato imprenditoriale, privato cooperativo) ha stabilito il proprio dominio rendendo di fatto limitatissimi gli spazi e le possibilità della negoziazione sociale. Approfondire quella frattura, per riaprire quegli spazi, può e deve essere il canale per rilanciare il conflitto, e dunque per dare nuove gambe e nuove braccia agli esperimenti di sindacalismo sociale e di pratiche del diritto alla città.
Pratiche del diritto alla città: rinegoziare del debito delle città; riconoscere i beni comuni urbani e concepire un nuovo uso del patrimonio pubblico come vettore di partecipazione, come nuova forma del possesso (contro l’ingiustizia della proprietà privata); inaugurare una gestione dal basso, condivisa, dei servizi pubblici essenziali, nell’unione (e non nell’ostilità reciproca) di lavoratori e utenti; disegnare una nuova urbanistica, capace di rendere viva la vita metropolitana, di stringere (e non di allentare) i legami sociali; intendere il diritto alla mobilità come il diritto di abitare spazi ampi, tagliando il tempo di lavoro e allungando il tempo di vita; garantire il diritto alla casa; rilanciare la cultura per assicurare a ciascuno il livello di bellezza cui ha diritto. Elementi programmatici, concreti, utopici, da rivendicare ed ottenere domani, che informano la direzione e il senso di un nuovo municipalismo. E in questo la straordinaria affermazione di Luigi de Magistris a Napoli, vera e potente anomalia sul piano nazionale, rappresenta un laboratorio con cui, dalle prossime settimane, confrontarsi produttivamente a partire dal piano delle lotte metropolitane.
Ci sono – grossomodo – due modi di intendere il programma politico, l’avventura neo-municipalista. Due versioni per interpretare le forme della politica metropolitana. La prima è, per così dire, una versione debole. Si tratta della riproposizione (fuori tempo massimo) di quella che tra gli anni Novanta e gli anni Duemila si evocava come: «riappropriazione dei nessi amministrativi». Si trattava, in sostanza, della collocazione di “rappresentanti” del movimento all’interno dei partiti di sinistra, al fine di contribuire alla moltiplicazione della “offerta” politico-istituzionale: si tratta evidentemente – a fronte della scomposizione del quadro politico – di una via identitaria verso l’ambizione municipalista. Una specie di vetero-municipalismo, funzionale forse a un’altra ipotesi, ugualmente tardiva e fallimentare, l’utilizzo delle città come trampolino di lancio verso il quadro nazionale.
Esiste poi una versione forte del neo-municipalismo, che si fonda – anzi scommette – sul superamento degli antichi dualismi che bloccano la produzione del nuovo: sociale e politico, negoziazione e autogoverno democratico. Tutte le esperienza di municipalismo radicale degne di questo nome (ma degne soprattutto della sfida che l’oggi e gli elettori del Movimento 5 Stelle lanciano a tutti noi) si collocano al confine di queste distinzioni, partendo dall’assunto della crescente disgiunzione tra funzione di governo ed esercizio del potere. Esse lavorano programmaticamente sulla moltiplicazione di contropoteri, a partire dai quali esercitare conflitto e negoziazione e, al contempo, sviluppare piattaforme programmatiche e istituenti. Contropoteri che, su quelle piattaforme, rifiutano la cantilena della partecipazione come mantra, esercitano potere di veto e di proposta, di controllo e di innovazione, potere normativo e potere liberatorio. Per essere chiari: il tentativo di «Roma non si vende – Decide Roma» e della sua «Carta di Roma Comune» sono esattamente questo tentativo, il nostro tentativo. La priorità non è porsi il problema dell’internità, o dell’alleanza, con la sfera amministrativa – senza però neppure limitarsi all’opposizione: la priorità è porre le basi per una nuova pianificazione diffusiva e decentrata dello spazio urbano.
Un immediato terreno di verifica, dopo la tornata elettorale, è la campagna per il No al disegno di riforma costituzionale, e per il No alle politiche sociali del Governo Renzi. Non dobbiamo sottovalutare l’effetto che, l’interminabile marzo francese, sta producendo anche in Italia, tra i lavoratori, tra i giovani precari, tra gli studenti. Effetto che può essere occasione di riapertura del campo della sperimentazione di pratiche di sindacalismo sociale e di democrazia reale. Costruiamo da subito la campagna, sociale e tecnopolitica, per un NO Costituente.
No, noi non piangiamo sulla città coloniale. Chi piange, oggi, finalmente, è il colonizzatore che sente di perdere il proprio dominio. Noi ridiamo del suo pianto. Organizziamo la città post-coloniale. Scriviamo la storia che ancora ha da passare «sotto questi cornicioni col colore del sole». Splendente.