cult

CULT
The Best of 2017. I film
Il ritorno al cinema di Soderbergh, Scorsese con un progetto lungo trent’anni, e poi il musical death-metal-religioso di Dumont e le storie d’amore di Guadagnino e Hong Sang-soo. Ecco i film che ci sono piaciuti di più del 2017 (che per la maggior parte vedremo in Italia il prossimo anno)
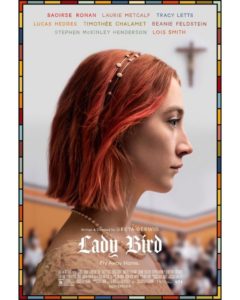 10. Lady Bird (Greta Gerwig, Stati Uniti)
10. Lady Bird (Greta Gerwig, Stati Uniti)
Sacramento, anno scolastico 2002/2003, ovvero la quintessenza della provincia americana, che per una volta non viene per nulla estetizzata ma consegnataci in tutta la sua normalità aspra e disincantata fatta di collegi cattolici e di povertà da middle class in crisi: quella che si vergogna di fare le spese nei negozi di vestiti di seconda mano e non si può permettere di comprare un cellulare ai figli. Lady Bird, folgorante esordio alla regia di Greta Gerwig, è però molto più di questo e molto più del coming-of-age che sembrerebbe essere a prima vista: è una riflessione sul desiderio di libertà (non solo adolescenziale) di quando si vorrebbe della provincia da cui si viene, della propria condizione sociale, della propria famiglia e persino del proprio sé negare tutto, fino a inventarsi un proprio nome. “Il mio nome dunque non sarà più Christine, quello che mia madre mi ha voluto dare, ma Lady Bird”. Ma la libertà non è solo negativa (la libertà da qualcosa), è anche e soprattutto riconoscere il proprio posto nel desiderio che l’altro ha avuto per noi, e cambiare così la propria posizione soggettiva nel mondo. In una delle più belle rappresentazioni di un rapporto tra madre e figlia, senza (quasi…) il bisogno di risolvere tutto con la riconciliazione e il riconoscimento reciproco, Lady Bird è davvero il Boyhood di quest’anno e una delle riflessioni più dense, a dispetto del registro leggero da commedia, sull’adolescenza dai tempi di Freaks & Geeks.
 9. L’Amant d’un jour (Philippe Garrel, Francia)
9. L’Amant d’un jour (Philippe Garrel, Francia)
Terza parte di una trilogia che il regista ha definito “freudiana” dopo La jalousie del 2013 e L’Ombre des femmes del 2015, anche L’Amant d’un jour dura soli 75 minuti ed è stato girato in bianco e nero e in cinemascope, con sostanzialmente la stessa troupe e gli stessi sceneggiatori degli altri due film. Questa volta si tratta della storia di Jeanne (Esther Garrel), poco più di vent’anni, che a seguito di una delusione amorosa torna a vivere dal padre, e scopre che lui si è messo insieme a una ragazza che ha la sua stessa età. Il posto strutturale della figlia e dell’amante sembrano dunque sovrapporsi all’interno della stessa casa. Garrel costruisce con L’Amant d’un jour uno studio di un trittico relazionale e di un incrocio di desideri, e come spesso fa nei suoi film sovrappone livelli relazionali e generazionali diversi che si vengono a condensare in un’unica immagine. Perché l’immagine per Garrel è sempre “verticale”, va in profondità e va a cogliere un oggetto assente, nel momento del suo ritrarsi: non esiste l’oggetto d’amore nella sua presenza; non esiste una storia d’amore al presente. Nasce da qui l’ossessione dei suoi film per Nico, per la Jean Seberg in Les hautes solitudes, per le comunità utopiche post-sessantottine nel momento del loro riflusso esistenziale: l’affetto fondamentale del cinema di Garrel è infatti quello della malinconia. E tuttavia non se ne compiace, e anzi in questi ultimi tre film – che andrebbero visti in sequenza uno dopo l’altro – l’approccio si fa più formale, lo sguardo più razionale, le problematiche più nitide, e il regista francese firma tre dei suoi film più riusciti degli ultimi decenni.
 8. I Love You, Daddy (Louis CK, Stati Uniti)
8. I Love You, Daddy (Louis CK, Stati Uniti)
La spettacolare deflagrazione pubblica della carriera di uno dei più geniali comici degli ultimi anni – colpevole, come ammesso da lui stesso, di diversi casi di sexual misconduct – non ci deve far perdere di vista come in realtà nell’opera di Louis CK il tema della dimensione solitaria, masturbatoria ed essenzialmente autocentrata della sessualità maschile fosse già ampiamente presente ben prima che le accuse contro di lui apparissero sulle pagine del New York Times. In questo film, girato in bianco e nero e in 35mm a mo’ di tributo al Manhattan di Woody Allen, sembra che il caso Weinstein e le stesse accuse che di lì a poco travolgeranno Louis CK fossero già tematizzate e commentate con il consueto disincanto e gusto del paradosso delle sue opere migliori. Vediamo un uomo che fa l’attore e l’autore televisivo, ricco, solo e divorziato, con una figlia di 17 anni che vive con lui solo per strappargli dei soldi e per godere di appartamenti di lusso, jet privati e feste con attori famosi (da cui la continua frase ripetuta da lei “I love you, daddy” ogni volta che riesce a strappare al padre qualche contraccambio materiale). L’incapacità di essere un padre, un professionista, un marito, un compagno – ovvero la definitiva catastrofe del maschile – non viene mai “salvata” dalla risata: è come se il joke che normalmente serviva a esporre l’elemento di paradosso si fosse ormai disincarnato fino a non lasciare nient’altro che il nudo disincanto, e un senso soffocante di solitudine. E in questo senso I Love You, Daddy è davvero l’opera definitiva (e probabilmente conclusiva, almeno così per come l’abbiamo conosciuto) dell’intera carriera di Louis CK.
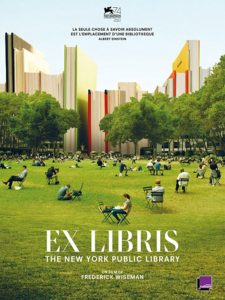 7. Ex Libris – The New York Public Library (Frederick Wiseman, Stati Uniti)
7. Ex Libris – The New York Public Library (Frederick Wiseman, Stati Uniti)
“Le biblioteche sono i pilastri della nostra democrazia” diceva Toni Morrison, e Fredrick Wiseman sembra non pensarla molto diversamente dato che presentando questo film ha detto che la biblioteca è la più democratica di tutte le istituzioni, quella che accetta tutti senza differenza di classe, status, razza e i cui servizi non vengono erogati in cambio di denaro. Democrazia, si sa, è un parola scivolosa eppure è chiarissimo che cosa voglia dire democrazia alla New York Public Library, la più grande istituzione bibliotecaria americana seconda solo alla Library of Congress e soggetto di questo splendido film: democrazia è ciò che nomina un processo di inclusione e di messa in discussione delle diseguaglianze sociali che attraversano la società americana. Wiseman, come spesso accade nei suoi film, decide di adottare un approccio corale e collettivo, dove si passa dalle biblioteche dell’alto Harlem, come la Macomb’s Bridge Library, dove le bibliotecarie conoscono i ragazzi per nome, all’enorme e un po’ spersonalizzante sede centrale di Manhattan dove avvengono la maggior parte delle discussioni dell’amministrazione e dove gli “incontri con gli autori” riguardano super-star del mondo della cultura del calibro di Richard Dawkins e Edmund de Waal. Questo Wiseman così positivo nei confronti dei soggetti dei propri documentari è infatti uno dei portati degli ultimi anni, in cui il regista americano si è messo a raccontare alcune delle migliori istituzioni dell’America “progressive” e ad adottare un approccio più costruttivo nei confronti delle istituzioni. Fino a fare, come in questo film, delle vere e proprie apologie del lavoro sociale e dell’intelligenza collettiva messi a valore all’interno delle istituzioni pubbliche.
 6. Song to Song (Terrence Malick, Stati Uniti)
6. Song to Song (Terrence Malick, Stati Uniti)
“Volevo qualcosa di vero. Nulla sembrava vero” dice Faye, la protagonista interpretata da Rooney Mara all’inizio del film: è il richiamo all’immediatezza dell’esperienza, al godimento, alla verità della sensazione corporea come unica forma di realtà. È l’idea secondo cui – sempre per usare le parole della protagonista – “qualunque esperienza [sia] meglio di nessuna esperienza”. Song to Song, strana storia di un ménage à trois all’interno della scena musicale di Austin, riporta Malick alle riflessioni filosofiche (dal consueto sapore heideggeriano) che hanno caratterizzato i suoi ultimi film: che cosa vuol dire “essere se stessi” all’interno di un mondo schiacciato sull’eterno presente, dove anche il godimento della sessualità è diventato spersonalizzato e anonimo? Come è possibile dare un senso al proprio stare al mondo, anche di fronte alle espressioni di cinismo più disincantato (incarnate nel film dal personaggio mefistofelico di Michael Fassbender)? C’è senz’altro una dimensione sfacciatamente inattuale in questa insistenza su domande metafisiche anche all’interno di esperienze sociali così platealmente superficiali come è la scena musica di Austin, così come in Knight of Cups era stata l’industria di Hollywood. Eppure ormai Malick è capace di fare un cinema che parla solo a sé stesso, e che non ha nessuna misura se non quella della propria straordinaria ricerca visiva.
 5. Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Bruno Dumont, Francia)
5. Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (Bruno Dumont, Francia)
A pensarci a freddo non può che essere l’idea di un pazzo: adattare in forma di musical due testi dello scrittore cattolico Charles Péguy sull’infanzia di Giovanna d’Arco, con una partitura assurda quanto può essere quella folk-elettronica (ma con più di un’incursione death metal) del musicista Igorrr (scritto così, con tre r). Eppure è proprio quello che ha fatto Bruno Dumont col suo Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs dell’ultimo Festival di Cannes. Ambientato non in Lorena, come la storia prevede, ma nelle zone vicino a Calais e Boulogne-sur-mer e girato unicamente con attori non professionisti, Dumont prende “alla lettera” i testi di Péguy, senza alcuna distanza ironica, riuscendo come già aveva fatto in P’tit Quinquin e Ma Loute a usare il registro grottesco come dispositivo di disidentificazione rispetto al reale. I suoi film riescono così a sospendere ogni forma di verosimiglianza non tanto per andare verso il fantastico quanto per rendere più astratte e minimali le proprie storie. Il risultato è che Giovanna d’Arco, interpretata prima da una bambina di 8 anni e poi da un’adolescente di 13, è protagonista di un romanzo di formazione all’esperienza mistica intesa come un’esperienza di rottura dalla propria appartenenza a questo mondo. La mistica non è una figura irenica e pacificante, non è portatrice della buona novella di pace, anzi è colei che separa il mondo da se stesso, rompendo le false unità e ogni sentimento di adattamento e di quietismo. Un vero e proprio capolavoro, trascinante come un musical e tagliente come un testo di mistica religiosa, ad un tempo inattuale e pop. Ma che soprattutto riesce a non somigliare a nient’altro che a se stesso.
 4. On the Beach at Night Alone (Hong Sang-soo, Corea del Sud)
4. On the Beach at Night Alone (Hong Sang-soo, Corea del Sud)
Solo nel 2017 il regista sud-coreano Hong Sang-soo ha girato ben tre film: Claire’s Camera, con Isabelle Huppert e Kim Min-hee e The Day After, che era in concorso al Festival di Cannes. Ma è questo On the Beach at Night Alone che ci ha letteralmente rapito quando l’abbiamo visto in concorso alla scorsa Berlinale. Il film, tutto giocato sul punto di vista della sua protagonista femminile Younghee (Kim Min-hee), si chiede: come è possibile rimanere fedeli a un amore che non è stato in grado di durare, quando il mondo, che a partire da quell’incontro aveva preso corpo, è scomparso ed è arrivata la reazione del mondo di prima? E in effetti On the Beach at Night Alone è a tutti gli effetti un film post-apocalittico, dove dopo la fine di un amore vi è un mondo vuoto, freddo, dove vige una luce opaca e dove persino gli amici sembrano invecchiati (“Come ti trovo male Myungsoo, sei sicuro di stare bene?”), dove regna la ripetizione, e dove il proprio desiderio non può più trovare luogo. Nella scena più bella (probabilmente non solo di questo film, ma di questo interno anno cinematografico) Younghee se ne va da sola in spiaggia (da cui il titolo al film) e si adagia per terra. Sogna di incontrare la troupe di un film dove c’è proprio lui, il regista che l’ha lasciata. E di fronte a tutta la troupe del film a tavola i due sembrano dirsi finalmente quello che pensano su quanto sia successo. Hong Sang-soo mostra perfettamente che cos’è l’asimmetria dei punti di vista di un amore: lui le dice di essersi innamorato perché lei è bella, mentre lei poco prima nel film aveva detto esattamente il contrario. Ma quando lui le legge un passo di un libro, dove si dice che innamorarsi è qualcosa di più alto della felicità e dell’infelicità (è quindi qualcosa che non si “misura”, tantomeno con il metro del vantaggio o del benessere personale) e le confessa il dolore e il rimpianto di quelle che gli è successo lui è concentrato sulle parole, su quello che dicono – dice ai suoi colleghi accanto “non è un passo bellissimo?” – mentre lei è quasi in trance e lo guarda senza proferire parola. Gli chiede soltanto “ma davvero mi vuoi regalare questo libro?” Quello che conta insomma per Younghee è il gesto d’amore, il segno di qualcosa che si faccia supporto di un desiderio (è il desiderio è sempre, per definizione, un desiderio di “nulla in particolare”), mentre lui è concentrato sulle parole, è insomma concentrato – come spesso accade ai maschi – sul sapere, non sul desiderio. Perché forse – sembrerebbe dirci questo film – non c’è modo di far sì che il desiderio si integri perfettamente nel mondo dove siamo, nei suoi ritmi regolati, nelle sue liturgie e nei suoi saperi. Forse perché non è possibile desiderare senza voler in qualche modo sconvolgere il mondo in cui si è.
 3. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino, Italia)
3. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino, Italia)
L’altro grande film sul desiderio di quest’anno è passato anch’esso alla Berlinale ed è stato fatto da Luca Guadagnino. Persino i più scettici sul lavoro di questo regista si sono dovuti ricredere, per un’opera matura, personale e trascinante, che ora sta giustamente raccogliendo diversi riconoscimenti negli Stati Uniti nella stagione degli awards (e che probabilmente avrà anche diverse chance ai prossimi Oscar). Call Me By Your Name, produzione americana ma girato completamente in Italia in Lombardia, è una storia d’amore ambientata negli anni Ottanta e parla di una famiglia cosmopolita, ricca e colta che passa l’estate in una grande casa aristocratica nella Pianura Padana (dalle parti di Crema). Il padre è un professore americano d’archeologia, la madre è francese di origini italiane, ma il nostro punto di vista sarà quello di Elio, ragazzino di diciassette anni in una delle classiche fasi “di transizione” che hanno tutti gli adolescenti a quell’età. Quest’atmosfera familiare amorevole e tranquilla viene sconvolta dall’arrivo di Oliver, trentenne americano, ricercatore universitario, in vacanza di studio in Italia e ospite del professore d’archeologia. Ma quello che sconvolge di più è naturalmente il suo corpo, bello e scolpito come può essere quello di Armie Hammer, la sua dimestichezza nel muoversi nel mondo, il suo modo di ballare, di rapportarsi alle ragazze, in una parola la sua bellezza. Guadagnino segue l’avvicinamento di Elio e Oliver, li guarda mentre si guardano l’un l’altro, mentre si innamorano l’uno dell’altro. E per una volta Guadagnino sacrifica l’estetizzazione del suo cinema per una storia d’amore e di formazione tra le più belle che si siano viste al cinema ultimamente.
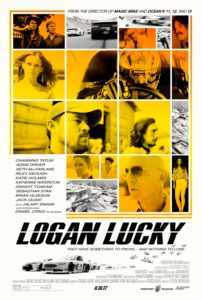 2. Logan Lucky (Steven Soderbergh, Stati Uniti)
2. Logan Lucky (Steven Soderbergh, Stati Uniti)
Logan Lucky, l’attesissimo ritorno al cinema di Steven Soderbergh, è davvero il film politico del 2017 capace di guardare al mondo working class del Sud degli Stati Uniti (siamo tra il North Carolina e la West Virginia) non dal punto di vista della sua miseria, della sua marginalità o arretratezza, ma dal punto di vista del suo riscatto. Come dovrebbe sempre fare il cinema: andare a tirare fuori dalle maglie del reale la virtualità della sua potenziale trasformazione. E quindi ribaltare i colori scuri e de-saturati che piacciono tanto al paradigma vittimista dei film drammatici di oggi, e virarli in una tavolozza sgargiante, coloratissima e iper-saturata: gialla, blu, porpora, arancione. Non è questo di Soderbergh puro entertainment d’evasione come hanno detto in molti, ma semmai un cinema che è capace di dare realtà all’immaginazione e di mettere sullo schermo il mondo come potrebbe essere. O come vorremmo che fosse. Cinema politico dunque nel senso più alto e nobile che gli possiamo dare. I Logan allora – i due fratelli protagonisti del film, ex-veterani mutilati dall’Iraq, o costruction worker licenziati per colpa dei costi dell’assicurazione sanitaria – che hanno la nomea di essere degli sfigati, in questo film davvero upside down noi ce li immagineremo come lucky. Perché bisogna essere fortunati per mettere a segno una delle rapine più inverosimili a cui si possa pensare: rapinare l’autodromo di Charlotte in North Carolina durante la Coca-Cola 600 (una delle gare più importanti del circuito del campionato NASCAR) con tutti gli occhi dell’America addosso. E per farlo naturalmente useranno l’ingegno della working class: tutto quell’insieme di conoscenze, astuzie e piccoli sotterfugi che solo un muratore che ha lavorato alle manutenzioni di quel circuito – e che quindi conosce ogni anfratto di quel luogo dall’interno – può avere. Perché è naturalmente possibile mantenere la working class in povertà, non pagarle gli ospedali, o mandarla in guerra e farla tornare mutilata, come accade davvero nell’America di oggi di Trump, ma non è possibile fare a meno del suo lavoro. Con la possibilità che questa poi lo usi per i suoi interessi e non per quelli del padrone.
 1. Silence (Martin Scorsese, Stati Uniti)
1. Silence (Martin Scorsese, Stati Uniti)
Tratto dal romanzo di Shusako Endo, Silence è il progetto “della vita” per Martin Scorsese, al quale stava lavorando da quasi trent’anni, e in un certo senso il suo film definitivo sul cristianesimo. Ma non è un film che fa una fiera professione di fede, semmai tratta della sua perdita; dell’abiura delle proprie convinzioni; del vacillamento del senso del mondo. Siamo nel 1637 nel momento più violento delle persecuzioni anti-cristiane in Giappone, e due gesuiti portoghesi, Padre Rodrigues e padre Garupe (“un esercito di due persone”), vanno alla ricerca del loro maestro, padre Ferreira, di cui da anni si sono perse le tracce e che pare abbia abiurato la propria fede, rinnegato Cristo e che ora viva da buddista secondo i costumi giapponesi. All’inizio i due predicano la fede a dei villaggi di poveri pescatori che vivono di nascosto dalle persecuzioni e a cui bastano dei legnetti a forma di croce o delle pagliuzze legate insieme perché immediatamente diventino oggetti venerabili. Ma ben presto i due missionari gesuiti capiscono che il vero cuore dell’esperienza cristiana non è quello di dire a colui che vive l’insensatezza del mondo che la vita ultraterrena lo ricongiungerà con l’Uno del senso. Mentre i pescatori cristiani vanno incontro alle persecuzioni cristiane con coraggio perché sanno che l’esistenza dei martiri è un’esistenza di grazia, Padre Rodrigues inizia a capire che colui che è davvero fedele al messaggio cristiano è Kichijiro: il “Giuda” del racconto. Colui che rinnega la Fede, sputa sulla croce, vende Rodrigues all’inquisitore ma contrariamente a tutti gli altri è sempre costantemente inquieto, nervoso, penitente e severo. È l’unico che vive il Cristianesimo come perenne e irrisoluta inquietudine. È lui il vero oggetto-scarto, disprezzato e rifiutato dai giapponesi, da Rodrigues e persino dai villaggi di poveracci. Perché la fede di Scorsese non è quella buona che unisce in una comunità, ma è l’idea che il cristianesimo sia – come diceva Chesterton – “una spada che separa e mette in libertà”: è un gesto divisivo che ha spezzato l’universo lo ha ridotto in mille anime viventi, che sono il segno della libertà dell’uomo e nello stesso il marchio dell’incompletezza ontologica dell’universo. È il cristianesimo insomma che ha detronizzato il Dio come signore del mondo e custode del senso pieno dell’universo e l’ha gettato nel negativo della storia. È come se ci fosse nel cuore stesso del cristianesimo un dubbio riguardo a Dio. E infatti come già nello splendido L’ultima tentazione di Cristo il vero salvatore non può che essere chi, come Giuda o come Kichijiro, assume fino in fondo il dramma di una Fede che non ricongiunge con il mondo mentre tutti gli altri trovano un modo per riuscire a ricucire lo strappo della “spada di Cristo”. Non c’è modo di vivere in pace in un modo dove l’unica presenza di Dio ha la forma del silenzio. Non si tratta di avere una Fede che porti la pace, né che ricongiunga con il senso. Si tratta di pregare con la consapevolezza del non-senso del mondo. Si tratta dunque di “pregare con gli occhi aperti”, come viene detto in un punto del film. Con gli occhi aperti su un mondo dove la presenza del divino ha non né immagine né voce. E dove dunque qualunque ricerca idolatrica di Dio non può che avere una risposta. Quella del silenzio.
