cult
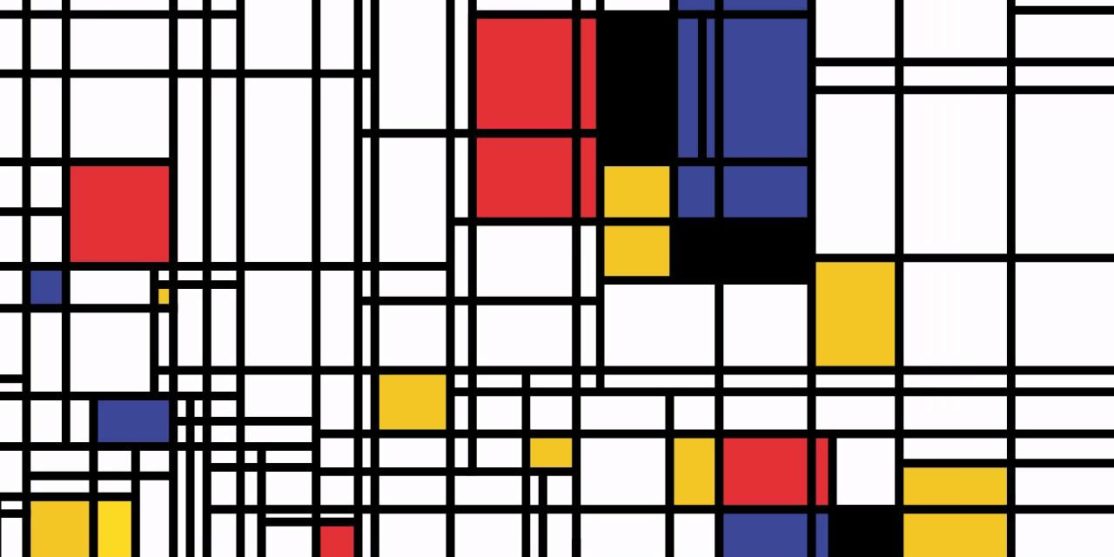
CULT
Le risorse istituenti del diritto
Il libro “Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività” (a cura di Francesco Brancaccio e Chiara Giorgi, Roma, DeriveApprodi, 2017) prova a rispondere alla questione che cosa è un’istituzione?
A dispetto della molteplicità dei contributi, Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività (a cura di Francesco Brancaccio e Chiara Giorgi, Roma, DeriveApprodi, 2017) è una raccolta di testi che varia sullo stesso tema e mira a osservare da angolature differenti il medesimo scorcio. Come si costruisce una griglia interpretativa della contemporaneità una volta che le categorie politiche del Novecento non valgono più? Che forma ha la cooperazione sociale quando abbandoniamo la forma-stato? Come si attiva il comune al netto della prospettiva sovrana?
Che questa sovranità non sia una fasciatura della mente (di cui ancora non ci siamo liberati) più che una trappola inesorabile? Se si coglie bene, così si tengono insieme i vari pezzi del puzzle che compone Ai confini del diritto.
Ci si interroga allora su che forma seguire, di che strumenti dotarsi, cosa svincolare, per poter operare questo distacco e contemporaneamente fare tesoro dell’esperienza costante e sorprendente di nuove “formazioni sociali” – per usare un termine caro ai costituenti.
La sfida che viene messa in campo suona inedita, o quanto meno potentemente nuova a orecchie use a un refrain troppo militante. Al centro della reinvenzione sociale ci sarebbero, infatti, niente di meno che le istituzioni. Oggetto tanto di vituperio quanto di osanna, esse non trovano la loro cornice di senso né qui né lì. O, forse, sarebbe meglio riferirsi più che alle istituzioni alla pratica di istituire, quell’instituere che magistralmente viene illuminato da Paolo Napoli, alla ricerca di una concezione materialistica delle istituzioni.
A ben vedere, affrontare il tema equivale a inoltrarsi in un terreno pieno d’insidie e in una questione che spezza i confini disciplinari. Se “istituzione” è il lemma usato per definire il processo attraverso cui un’istituzione si forma, esso indica allo stesso tempo il risultato di tale processo. “Istituzione” coincide poi con la struttura preordinata al mantenimento di ciò che è stato istituito. L’ambiguità si fa evidente: nella prima accezione, l’istituzione rimanda a un gesto creativo, positivo, costruttivo. Instituere, d’altronde, ha un’etimologia chiara: fondare, stabilire nell’uso, dare inizio a cose di pubblica utilità destinate a durare stabilmente. Si istituiscono norme di diritto, feste, cerimonie, organi politici e commissioni. Se instituo restituisce il senso di un gesto creativo, il suo contrario è quello di abolire, smantellare, porre fine a tale creazione. Ecco che la distanza tra il linguaggio di uso comune e la radice etimologica si fa dilemma. Quel che generalmente s’intende per “istituito” o, ancor più chiaramente, quel che si designa con l’aggettivo “istituzionale” pare rinviare piuttosto a ciò che è fisso, statico, imperturbabile, se non immaginato come pressoché imperituro. L’istituzione è allora vista come un Moloch che non si presta più a essere inscritto nella prassi sociale, che non concede più spazio a nuove forme.
Sulla scorta dell’insegnamento deleuziano, che, fra l’altro, ispira la preziosa introduzione dei curatori Francesco Brancaccio e Chiara Giorgi, la sfida è invece quella di cogliere che con l’istituzione si soddisfa una tendenza, ma l’istituzione, una volta istituita, non determina la tendenza che l’ha generata. Se si parte logicamente dall’istituzione sarà facile dire che il denaro c’è perché sono necessari gli scambi, il matrimonio perché i rapporti sessuali possano essere assicurati, l’aperitivo perché è un’idea geniale per risolvere la fame che incalza nel tardo pomeriggio. Il problema è che questo è un ragionamento fallace, poiché ci fa perdere di vista il fatto che al posto di quelle istituzioni potenzialmente ve ne possono essere e se ne possono creare mille differenti. E, quindi, vale il ragionamento secondo cui un certo bisogno può essere soddisfatto mediante una certa istituzione, ma non vale l’inverso, ossia che quell’istituzione lì esiste in quanto necessitata da quel determinato bisogno. Non sono le tendenze a essere sociali: sono i mezzi per la loro soddisfazione a esserlo, ossia le istituzioni. E queste, proprio in quanto inventate, sono originali e sono sociali. «Bisogna ritrovare l’idea che l’intelligenza sia una cosa sociale più che una cosa individuale»[1], la quale si esprime sotto forma di invenzione di istituzioni!
Con una precauzione: la pone Pierangelo Schiera quando si chiede in che ordine del mondo rinnovare, se lo scopo è quello di rinnovarlo – è doveroso dubitare della presenza di tempi e luoghi in cui i bisogni non sono tradotti in istituzioni – quelle che l’Occidente ha definito tali.
Il diritto è senz’altro quel campo della prassi e del sapere che pare più naturalmente incline a forgiare istituzioni. A patto che si colga un dato storico imprescindibile, ossia che il diritto non è affatto ontologicamente ancella statale.
«E se, in questa situazione, il diritto non è più diritto dello Stato, che cos’è? E’ una macchina estranea che tuttavia rispecchia determinazioni ontologiche reali. Quando perciò si insiste sulla “dissipazione” del diritto statuale, non si dice che esso sia superato come campo di lotta o come luogo dove si costruiscono nuovi istituti e nuovi valori. Ciò che è stato superato è la certezza e l’efficacia del diritto statuale. Se perciò vogliamo creare nuovo diritto, dobbiamo creare nuove macchine e nuovi valori» (Toni Negri, p. 36).
A far da parallelo alla disgiunzione fra diritto e stato c’è, poi, la frammentazione interna di ciò che unitariamente si assume come “Stato” – questione su cui gettano luce Sandro Mezzadra e Brett Neilsen sostenendo che «l’affermazione dell’unità continua a costituire un tratto distintivo dello Stato e della sua contesa legittimità. In realtà, la tensione tra la disarticolazione dell’unità statale e la sua continua riaffermazione definisce il campo nel quale oggi lo Stato opera» (p. 51).
Ma diritto e stato sono talmente sganciati l’uno dall’altro che i diritti sono precisamente l’invenzione che può consentire l’opposizione al dettato sovrano. Se pare inverosimile un mondo in cui i diritti sono applicativamente universali, altrettanto impensabile è una società che non instauri costantemente lotte per «quel bisogno di eguaglianza e di mutuo riconoscimento che ha trovato nell’universalismo dei diritti una potente espressione» (Pietro Costa, p. 103) e che trova nella parola “democrazia” il significante vuoto che consente la ricomposizione di claims frammentari (Raúl Sánchez Cedillo).
Con un gesto simile di apertura all’a-venire, Augusto Illuminati conduce il lettore per un viaggio genealogico aldilà di una temporalità lineare, in cui antiche esperienze del comune spagnole e italiane dialogano con quelle odierne: «non si tratta di resurrezione di un percorso interrotto, ma di riattivazione di una tradizione di emancipazione e di accoglienza» come dimostrano Madrid, Barcellona, Napoli e Roma, assorellate a dimostrazione che «l’unica possibile alternativa non populista alla dittatura fatiscente della finanza risieda non in improbabili sovranismi di ritorno o in cittadinismi retorici ma in un discorso federativo, ancorato principalmente alle comunità urbane» (p. 112). In questo senso, e a partire dalla crisi, va ripensato il costituzionalismo moderno – secondo Gaetano Azzariti – per «costruire la democrazia costituzionale nei grandi spazi» (p. 138).
Non c’è da temere. Nel campo sociale si sperimentano già pratiche che incarnano le risorse istituenti diffuse, e che sono un sussulto per quell’incessante intelligente sperimentazione collettiva che il diritto è capace di scrivere.
[1] G. Deleuze, Istinti e istituzioni, trad. it. a cura di U. Fadini e K. Rossi, Milano, Mimesis, 2000, p. 32.
