cult

CULT
La città sa parlare?
In esclusiva per DinamoPress il nuovo saggio di Saskia Sassen tratto dal libro Fare Spazio (ed. Mimesis) a cura di C. Bernardi, F. Brancaccio, D. Festa e B. M. Meninni. Una sperimentazione collettiva sui temi del comune e del diritto alla città a partire dalla collaborazione tra la LUM, l’Istituto Svizzero di Roma e il Nuovo Cinema Palazzo.
Leggi l’introduzione del libro
Leggi l’indice
La parola è un elemento fondante delle teorie sulla democrazia e sulla politica. Come concetto, ha conosciuto espansioni e contrazioni di significato. Tuttavia, a quanto ne sappia e come altri sembrano confermarmi, non si è ancora arrivati a ipotizzare che la città possa parlare. Sostenere, come farò in questo saggio, che le città possano prendere parola, sebbene in modo ben diverso rispetto ai cittadini e alle corporation, significa per diversi aspetti confrontarsi con una questione trasversale tanto al diritto quanto all’urbanistica. La tematica non è affrontata in nessuno dei due ambiti di studio, soprattutto se non intendiamo limitare la nozione di parola alla sola sfera del governo urbano, né definire quanto la città dice attraverso le categorie del diritto. Pertanto, per indagare il problema, occorre allargare il campo analitico ove concettualizzare entrambe le cose, la parola come la città.
Le città sono sistemi complessi, sebbene incompleti. Ed è in tale incompletezza che si dà la possibilità del fare – il fare urbano, politico, civile. Caratteristiche, queste, che non appartengono alle sole città, ma che sono al contempo necessariamente iscritte nel dna dell’urbe – nella cityness, nell’essere città. Ogni città è diversa, come diverse sono le discipline che la studiano. Eppure, se l’oggetto d’indagine è l’urbano, non si potrà fare a meno di prendere in considerazione tre aspetti essenziali: l’incompletezza, la complessità, e il poter fare. Essi potranno darsi nel tempo e nello spazio in un’enorme varietà di formati urbanizzati specifici.
Alla luce di tale diversità, la ricerca urbana non ha bisogno di riconoscere la forma pura, astratta, di questi tre concetti essenziali – la complessità, l’incompletezza e il fare. Per lo più, chi si occupa di investigare o interpretare l’urbano lo fa attraverso nozioni specifiche del proprio campo di studio o appellandosi alla propria immaginazione, oltre a considerare i tratti concreti delle città che osserva. Eppure, quelle tre caratteristiche astratte saranno sempre presenti se è di urbe che si tratta, e non semplicemente di un’area ad alta densità di edifici di tipo specifico – lunghe schiere di case, o piuttosto di fabbriche o uffici. È per questo che una vasta zona residenziale suburbana non è una città, come non lo è un polo gestionale. Perché il concetto di città funzioni in termini analitici, dobbiamo saper essere concettualmente selettivi.
In questo testo, applicherò queste caratteristiche delle città a un’indagine sperimentale. Ipotizzerò che possano verificarsi eventi e condizioni in grado di rivelare alcune cose circa la capacità delle città di rispondere sistematicamente – di controbattere. Permettetemi di offrire una prima immagine di quanto ho in mente, attraverso un banale esempio: un’automobile, un mezzo fatto per andare veloce, esce dall’autostrada ed entra in città. Finisce in un ingorgo, non solo di auto, ma anche di persone che vanno e vengono. D’un colpo, la macchina è menomata: fatta per andare veloce, vede la sua mobilità arrestarsi. La città ha parlato.
Procedendo per approssimazioni, potremmo pensare a una simile presa di parola come a una capacità urbana, dove capacità è un termine ormai consolidato, mentre l’aggiunta dell’aggettivo urbana è una scelta insolita, che introduco per dare il senso di quella miscela sfuggente di spazi, persone e attività specifiche, soprattutto commerciali e civiche. Un termine che cattura la fisica sociale e materiale della città. Visto in questi termini, il concetto di capacità urbana diviene terra di confine analitica – né mero spazio urbano, né sole persone[1]. È la loro combinazione in circostanze ben determinate, in contesti densi, a fronte di potenzialità e attacchi specifici, che può generare la presa di parola. Si tratta di capacità urbane che possono manifestarsi in tutta una serie di situazioni e forme. E nel momento in cui ciò accade, si fanno parola.
Rendere giustizia a tutti gli aspetti di questo processo in un così breve testo sarebbe impossibile: mi limiterò a illustrare gli assi portanti del ragionamento. Il primo riguarda la città come sistema complesso e incompleto che rende possibile il fare, conferendo alle città stesse lunga vita. È combinando complessità e incompletezza che le città sono riuscite a sopravvivere a sistemi più potenti di loro, ma anche più formali e chiusi – Stati-nazione, regni, società finanziarie. L’altro asse del discorso riguarda la miscela delle diverse capacità urbane interpretabili come presa di parola e che, a loro volta, segnalano in senso più ampio la possibilità che le città possano esprimersi, sebbene attraverso una parola informale e generalmente non riconosciuta in quanto tale.
Il fondamento razionale di questa ipotesi sulla città e sulla parola ruota attorno a due considerazioni. Da una parte, la città resta uno spazio cruciale per le pratiche materiali di libertà, con tutte le sue anarchie e contraddizioni, nonché uno spazio dove chi è senza potere può farsi sentire, farsi vedere, fare politica. Dall’altra, queste caratteristiche delle città sono messe a repentaglio dagli intensi processi di de-urbanizzazione delle stesse, per quanto dense e urbane ci possano sembrare. Tra i fattori di minaccia, basterà citare le disuguaglianze e le privatizzazioni estreme, le nuove forme di violenza urbana, la guerra asimmetrica, i sistemi di sorveglianza di massa. Tuttavia, per accorgersi di tutto ciò bisognerebbe dedicare tempo ad ascoltare, e sperare di capire, quanto dice la città – e del resto se abbiamo dimenticato cosa sia l’ascolto, figuriamoci la comprensione. In quanto segue, esploreremo alcuni dei modi in cui la città prende parola.[2]
Tattiche analitiche
Quando mi confronto con riflessioni sperimentali di questo genere, devo prendermi la libertà di ricorrere a ciò che chiamo tattiche analitiche. Il metodo è troppo limitante. Una di queste tattiche consiste nell’operare ai margini di potenti spiegazioni che, sebbene meritino di essere prese sul serio, sono pericolose. La prima mossa consiste quindi nel chiedersi cos’è che la spiegazione lascia in ombra, visto che getta una luce così intensa su taluni aspetti della questione. Per esplorare la possibilità che le città siano dotate di parola, non posso ripararmi dietro le potenti spiegazioni su cosa sia la città. È una presa di parola che si dà nella terra di mezzo: non si tratta semplicemente della città come ordinamento materiale e sociale, parliamo di una capacità urbana sfuggente – né pienamente materiale, né del tutto visibile.
Un’altra tattica, in parte derivante dalla prima, attiene alla necessità di destabilizzare attivamente i significati. Una destabilizzazione che mi permette di vedere o comprendere quanto resta fuori dalle grandi narrazioni che spiegano un’epoca o organizzano un campo di studi, e che in tempi di rapide trasformazioni ritengo particolarmente necessaria.
Così, l’ipotesi stessa che la città sia dotata di parola porta a destabilizzare l’idea che la città sia una condizione evidente di per sé, che si contraddistingue per densità, materialità, folle di persone e per le loro interazioni multiple. È l’idea della città come schiacciante dato di fatto che occorre destabilizzare. Ciò che mi preme è indagare piuttosto la possibilità che, laddove persone, aziende, infrastrutture, edifici, progetti, immaginari e quant’altro si dispiegano interattivamente su un territorio delimitato, possa verificarsi qualcosa di paragonabile a una presa di parola: resistenze, intensificazione delle potenzialità – in breve, la possibilità che la città risponda.
Complessità e incompletezza: il fare possibile
Le città sono un luogo strategico per la produzione di nuove norme e identità. Hanno dimostrato di esserlo in diverse occasioni e parti del mondo, e in condizioni profondamente differenti. È per questa ragione che, sebbene a lungo segnate dal razzismo, dall’odio religioso, dalla spinta a espellere i poveri, le città si sono dimostrate storicamente capaci di mettere ordine al conflitto attraverso il commercio e l’attività civica. Un fatto, questo, che contrasta con la storia dello Stato-nazione moderno, che nel tempo ha teso a militarizzare il conflitto stesso.
Le condizioni che permettono alle città di formare norme e identità e trasformare i conflitti in rinnovato civismo variano nel tempo e nello spazio.
I cambiamenti epocali, come l’attuale passaggio alla dimensione globale, possono spesso generare capacità urbane di nuovo tipo. Oggi, con la globalizzazione e la digitalizzazione – e tutte le specificità che esse comportano – molte condizioni sono, ancora una volta, cambiate. La globalizzazione e la digitalizzazione hanno effetti di disturbo e destabilizzazione su ordinamenti istituzionali che vanno ben oltre le città. Tuttavia, la sproporzionata concentrazione e intensità in cui queste nuove dinamiche si danno negli spazi urbani, e in particolare nelle città globali, costringe a produrre nuove risposte e forme d’innovazione, soprattutto da parte dei più potenti e dei più svantaggiati, per quanto animanti da ragioni profondamente diverse.
Alcune di queste norme e identità giustificano forme estreme di potere e disuguaglianza. Altre sono specchio di un’innovazione forzata: è il caso noto di quanto accade nei quartieri popolati da migranti o nelle baraccopoli delle megacittà. Inoltre, se nelle città globali le trasformazioni strategiche sono più acuite e concentrate, molti cambiamenti possono anche trovare origine (nonché diffusione) in città che non costituiscono centri di potere e disuguaglianza estrema.
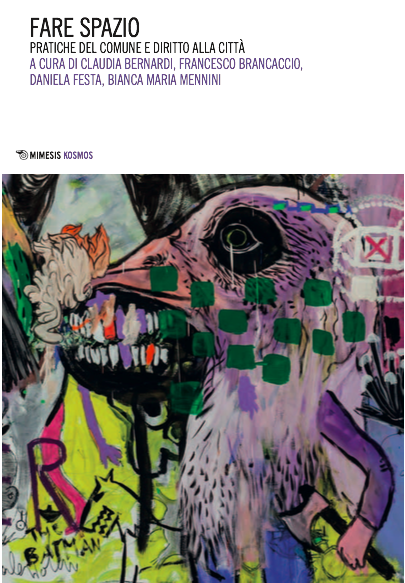
Le città non sono sempre la sede privilegiata dove produrre nuove norme e identità, o innovazioni istituzionali in senso generale. Ad esempio, tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, in Europa e gran parte dell’emisfero occidentale le sedi strategiche per fare innovazione, attraverso il contratto sociale e le possibilità di prosperità per il ceto medio e la classe operaia offerte dalla produzione industriale e dal consumo di massa, sono state le fabbriche e i governi statali. In questo senso, la mia lettura della città fordista è per molti aspetti in sintonia con quanto sostenuto da Max Weber circa la città moderna e il fatto che questa, a differenza delle città europee del Medioevo, non costituisca uno spazio d’innovazione. Nel caso del fordismo la dimensione strategica, che vede le città perdere d’importanza, è quella nazionale, ma mi trovo in ciascun caso in sintonia con Weber nel pensare che storicamente sia stata la grande fabbrica fordista, come lo sono state le miniere, a costituire lo spazio d’innovazione: lo spazio di formazione di una classe lavoratrice moderna e di un progetto di sindacalismo rivoluzionario. In sostanza, la città non è necessariamente il luogo principe per la produzione di norme e identità.
Nell’era globale, le città tornano a emergere come spazio strategico per il cambiamento culturale e istituzionale. Tale strategicità di alcune città dell’oggi è essenzialmente dovuta a due condizioni, entrambe specchio di processi di trasformazione aventi effetti destabilizzanti sui precedenti modi di organizzare il territorio e la politica. La prima riguarda il cambiamento di scala rispetto ai territori strategici in cui si articola il nuovo sistema politico-economico e, quindi, anche il potere, quantomeno in taluni aspetti. La seconda è l’indebolimento della dimensione nazionale come contenitore del processo sociale, a seguito delle diverse dinamiche di cui la globalizzazione e la digitalizzazione sono portatrici. Il verificarsi di queste di due condizioni comporta tutta una serie di conseguenze per le città; ciò che conta, ai fini del nostro ragionamento, è che queste emergono come spazio strategico per processi economici di grande portata e attori politici di nuovo tipo – anche processi e attori non urbani.
Ai fini della mia riflessione, è importante distinguere gli spazi ritualizzati, e riconosciuti in quanto tali, dagli spazi non ritualizzati o non trattatati in questo modo. Nella tradizione europea occidentale, la nostra esperienza di urbanità consiste principalmente in una serie di pratiche e condizioni che il tempo e lo spazio hanno contribuito ad affinare e ritualizzare. Così, in questa nostra – in parte immaginata – tradizione europea, la passeggiata[3] non è una passeggiata come le altre, e la piazza[4] non è una piazza qualunque. Entrambi i termini sono intrisi di significati e di ritualità aventi una genealogia propria, ed entrambi contribuiscono alla creazione di un dominio pubblico attraverso la ritualizzazione.
Nel tempo e nello spazio, la storia ci offre anche fugaci immagini di una dimensione ben diversa, meno ritualizzata e scarsamente, se non affatto, intrisa di codici. È lo spazio del fare per chi non ha accesso a mezzi e strumenti consolidati. Nel corso dei miei studi, mi sono dedicata al recupero concettuale di un simile spazio, che chiamo «la strada globale». [5] Un luogo che racchiude in sé un numero esiguo, se non nullo, di quelle pratiche o di quei codici ritualizzati che la società tutta è in grado di riconoscere: uno spazio aspro, che può facilmente risultare incivile.
La città, e soprattutto la strada, è un luogo dove chi è senza potere può fare storia, in modi che nelle zone rurali sono impensabili. Non che sia l’unico spazio dove ciò sia possibile, ma è senz’altro un luogo strategico in tal senso. Nel momento in cui coloro che non hanno potere si manifestano, si rendono visibili gli uni agli altri, la loro condizione può mutare di natura, e ciò permette di operare una distinzione tra le diverse tipologie dei senza potere.[6] Non si tratta infatti di una condizione semplice e assoluta, riducibile all’impossibilità di esercitare alcuna forma di potere. In determinate circostanze, chi è senza potere può trovarsi in una condizione complessa, perché racchiude in sé la possibilità del fare politico, del fare civile e del fare storia. Un fatto, questo, che segnala una differenza tra l’essere senza potere e l’invisibilità/impotenza. Molti dei movimenti di protesta che abbiamo visto emergere in Medio Oriente, in Nord Africa, in Europa, negli Stati Uniti e altrove, ben esemplificano la questione. Quei manifestanti potrebbero anche non aver conquistato alcun potere: restano dei senza potere, eppure fanno storia e fanno politica.
Ciò comporta una seconda distinzione e una critica all’idea diffusa che qualsiasi cosa buona accada a chi è senza potere costituisca una forma di empowerment. Riconoscere che l’essere senza potere è una condizione che può farsi complessa rende concettualmente possibile affermare che chi è senza potere può fare storia anche senza conoscere empowerment alcuno, e che quindi il suo operato avrà un impatto anche se questo non dovesse manifestarsi nell’immediato ma solo a distanza di generazioni. Come ho avuto modo di discutere dal punto di vista storiografico in altra sede,[7] la storia fatta dai senza potere tende a dispiegarsi lungo un arco temporale ben più esteso rispetto a quella dei potenti.
Le capacità urbane: precedono la parola e la rendono comprensibile
Se la città è dotata di parola, che forma o tono avrà? La città in che lingua parla? E come possiamo comprenderla, noi che parliamo un’altra lingua e con voce a dir poco cacofonica?
Un primo, piccolo, passo sta nel postulare che questa presa di parola attiene alla capacità urbana di alterare, plasmare, provocare, invitare, e che tutto ciò avviene sempre in nome della valorizzazione o tutela della natura complessa e incompleta della città stessa. Permettetemi, per essere più chiara, di sviluppare questo punto esasperando un po’ i toni: se si vuole indagare la possibilità che la città parli, è a mio avviso insufficiente pensare alla stessa esclusivamente come a un dato di fatto.
La questione della parola non può essere ridotta a questo, sebbene il problema vada riconosciuto ed esplorato in termini analitici. Vale a dire, il problema è il completo appiattimento della città quale entità fattuale, mentre ai fini dell’analisi sarebbe opportuno far emergere gli elementi di diversificazione. Questo schiacciamento non aiuta a comprendere l’interazione tra questa stessa entità fattuale e le azioni che le persone compiono, ossia la dimensione del fare, di un fare collettivo che coinvolge spazio urbano e persone. Ad esempio, in città nell’ora di punta si finisce per urtarsi camminando, e magari qualche bottone si strappa, qualche piede viene calpestato. Ma in centro città, nell’ora di punta, nessuna di queste azioni sarà percepita come un affronto personale, a differenza di quanto potrebbe avvenire in un piccolo quartiere, dove rappresenterebbero delle provocazioni belle e buone.
A rendere un simile meccanismo possibile è un codice non detto proprio di questo spazio tempo: non è infatti uno spazio in sé, ma è costituito da persone che si trovano in centro nell’ora di punta. Si tratta di una capacità che dobbiamo saper nominare, e che rappresenta una forma di produzione collettiva frutto dell’intersecarsi di tempo/spazio/persone/pratiche di routine. A me piace pensarla come capacità urbana – dove la centralità urbana si dà attraverso ambienti edificati, pratiche di routine, e un codice intrinseco e condiviso. Una capacità che permette una serie di interazioni e sequenze complesse e che, così facendo, assume significati precisi.
Non si tratta solo dei risultati che produce, è il lavoro in sé di costruzione del pubblico e del politico nello spazio urbano a rappresentare un elemento costitutivo della cityness, dell’essere città. Le città forgiano nuove soggettività e identità in modi che non sarebbero possibili, ad esempio, nelle zone rurali, o in un Paese intero. C’è una sorta di fare pubblico che può intralciare le narrazioni consolidate e rendere in tal modo comprensibile quanto espresso dal locale e da chi è ridotto al silenzio, finanche nel contesto di ordinamenti visivi che mirano a ripulire lo spazio urbano. La prima ondata di gentrification a Manhattan ne è un esempio: un ordinamento visivo del tutto nuovo che non riuscì, per un certo lasso di tempo, a rendere invisibili i senza tetto che produsse. Oppure pensiamo all’immigrato che fa il venditore ambulante a Wall Street e che, nello sfamare qualche trafelato professionista della finanza, altera il panorama visivo del mondo degli affari con l’odore intenso delle sue salsicce arrosto. Esempi, questi, in cui ho l’impressione di vedere la città controbattere, modificando gli effetti perseguiti da eleganti modi di ordinare il campo visivo. All’estremo opposto, la socialità della città può far emergere ed evidenziare l’urbanità del soggetto e del contesto e diluire i significanti più locali o essenziali; quando le città si trovano ad affrontare grandi sfide, il bisogno di nuove solidarietà può produrre un simile spostamento.
Attraverso le mie ricerche, ho avuto modo di constatare come le componenti fondamentali della cityness siano il risultato dei duri sforzi compiuti per superare quei conflitti e razzismi che possono segnare epoche intere.[8] L’urbanità aperta che ha storicamente reso le città europee luoghi di cittadinanza estesa è frutto di tale dialettica. In termini più generali, movimenti composti dai gruppi più disparati, animati da rimostranze di ogni tipo, possono riuscire a coalizzarsi a prescindere da quanto profonde siano le differenze politiche al proprio interno. È l’interdipendenza di cui si fa esperienza quotidiana nella città a rendere la coalizione possibile: se in città vengono a mancare l’acqua, l’elettricità o i trasporti, il problema riguarda tutti – le differenze sociali o politiche non contano. Nello spazio politico nazionale, riuscire a coalizzarsi è meno probabile e non altrettanto necessario, visto il minor il grado di interdipendenza/dipendenza e la natura maggiormente astratta dello spazio stesso. I raggruppamenti parziali che si costituiscono nelle città possono arricchire il dna del civismo cittadino: sono meccanismi che alimentano la formazione di un soggetto urbano, anziché definibile in termini religiosi, etnici o di classe. Si tratta di alcune delle caratteristiche che fanno della città uno spazio di grande complessità e diversità.
Le grandi città che si trovano al crocevia dei processi di migrazione ed espulsione su vasta scala si sono spesso dimostrate, e continuano a dimostrarsi, luoghi capaci di accogliere un’enorme varietà di gruppi. Un’accoglienza che è spesso legata agli sforzi per divenire città in senso sempre più avanzato – e che ha come alternativa solamente la segregazione spaziale che de-urbanizza la città. Vale peraltro la pena notare che quando le città riescono a imboccare questa strada con successo creano le condizioni per una convivenza pacifica spesso molto duratura. Convivenza non significa necessariamente uguaglianza e rispetto reciproco: a interessarmi, qui, sono quelle caratteristiche e quei vincoli intrinseci alle città che generano interdipendenza anche a fronte di profonde differenze religiose, politiche, di classe e di altra natura. Le considero quindi capacità urbane simili a quelle infrastrutturali o sotterranee, i cui effetti sono in parte legati alle necessità di manutenzione di un sistema complesso, segnato da grandi diversità e incompletezze. È grazie a tutto questo che la città parla.
L’esempio più immediato e familiare che si possa fare è forse quello delle fasi di convivenza pacifica in città con forti differenze religiose al proprio interno, a riprova di come tali differenze non siano necessariamente portatrici di conflitto. E non parliamo solo del noto caso della Spagna degli Asburgo e di quella dei Mori, così ammirate per la coesistenza tra religioni diversissime, la prosperità diffusa e i governanti illuminati. Penso anche al bazar della Città Vecchia a Gerusalemme come luogo secolare di convivenza commerciale e religiosa. All’inizio dell’ottavo secolo, durante il califfato degli Abbasidi, Baghdad era una fiorente città polireligiosa, e persino sotto il brutale regime di Saddam Hussein è stata un luogo dove minoranze religiose spesso radicate da secoli, come la comunità cristiana e quella ebrea, vivevano in relativa tranquillità.
Ma la storia insegna anche che questa capacità può venire distrutta, come d’altronde è spesso avvenuto. Una distruzione che porta inevitabilmente alla de-urbanizzazione e ghettizzazione dello spazio urbano. Così, in netto contrasto con il passato, Baghdad è oggi una città dove regna il regime di fatto della pulizia etnica e dell’intolleranza – un regime catapultato dalla disastrosa e illegittima invasione statunitense. Un caso tra i tanti che dimostra come uno specifico evento esogeno, un fenomeno a tutti gli effetti de-urbanizzante, può rapidamente trasformare la differenza religiosa o etnica in fattore di conflitto. Un cambiamento di prospettiva di cui gli individui si trovano a fare esperienza diretta, o che essi stessi innestano. La logica sistemica nella Baghdad di Saddam Hussein era quella dell’indifferenza verso minoranze come quella cristiana ed ebrea: non era questione di tolleranza da parte dei suoi abitanti, né di governo illuminato.
Si direbbe che l’indifferenza sistemica, in molti casi, funzioni come una sorta di capacità sotterranea che viene messa all’opera: una forma di civismo che non si fonda su cittadini tolleranti e governanti illuminati, ma deriva dall’interdipendenza e dalle interazioni che si danno nel contesto dell’esistenza materiale ed economica della città. Viceversa, la rottura del meccanismo si palesa come vortice rovinoso di conflitti letali e pulizie etniche che de-urbanizzano la città e saccheggiano questa capacità urbana.
Le capacità urbane, nelle loro diverse versioni, sono riscontrabili in una molteplicità di casi, alcuni più sfuggenti di altri. Uno di essi riguarda la ripetizione, che è una caratteristica di fondo degli ambienti urbani costruiti come anche dell’universo economico e tecnico in cui siamo immersi più in generale. Tuttavia, nelle città, la ripetizione diventa produzione attiva di moltiplicazioni e iterazioni. Il contesto urbano, inoltre, disarticola il senso stesso di quella ripetizione.
La città è piena di ripetizioni, che vengono però continuamente afferrate e fatte proprie dalle specificità e dalle condizionalità dei diversi spazi urbani. Autobus, cabine telefoniche, appartamenti o uffici, per quanto complessivamente omogenei possano sembrare, assumeranno significati e funzioni diverse nei vari spazi che compongono una città. Ciò evidenzia come la diversità degli ambienti urbani possa conferire una caratterizzazione propria anche agli elementi più standardizzati, rendendoli parte di uno specifico quartiere, spazio pubblico, centro storico. Passando a un grado di complessità superiore, notiamo la profonda diversità che può contraddistinguere i quartieri di una città quanto all’aurea che emanano, ai loro suoni e odori, alle coreografie delle persone che quel quartiere attraversano e a coloro che vi saranno più o meno benvenuti. In sostanza, la ripetizione in città può essere qualcosa di molto diverso dalla ripetizione meccanica riscontrabile nella catena di montaggio o nella riproduzione di una grafica. Spingendomi un passo oltre, vorrei avanzare l’ipotesi che casi come questi esemplifichino una capacità a cui mi piace pensare come capacità di parola.
Un modo più sfuggente di prendere parola è manifestare la propria presenza. Nei miei studi ho interpretato questo manifestarsi come una forma di riscatto da parte di soggetti o eventi minacciati dal silenzio dell’assenza, dall’invisibilità, dall’estromissione virtuale/rappresentativa dal corpo della città. Sono particolarmente interessata a comprendere come i gruppi e i progetti a rischio d’invisibilità, per via dei pregiudizi e delle paure che albergano nella società, riescono a segnalare la propria presenza a se stessi, ad altri come loro, nonché ad altri diversi da loro. Ciò che mi preme è afferrare un aspetto specifico di questo meccanismo: la possibilità di manifestare una presenza dove regnano il silenzio e l’assenza. Una variante di questa manifestazione di presenza è il terrain vague, un’area sottoutilizzata o abbandonata che giace nel dimenticatoio, tra grandi infrastrutture e costruzioni architettoniche. Il terrain vague non è un fenomeno esclusivamente odierno: sebbene in contesti diversi, e con specificità variabili, è esistito anche in passato. Questa così sfuggente terra di mezzo costituisce, a mio avviso, una componente essenziale dell’esperienza del vivere urbano, che rende comprensibili ai nostri occhi le transizioni e instabilità proprie di determinate configurazioni spaziali. Finanche nella città più densamente costruita vi sarà terrain vague. Poiché si contraddistinguono visivamente come spazi sottoutilizzati, sono spesso luoghi densi di ricordi che rimandano ad altri ordinamenti visivi, a presenze del passato, che alterano la sostanza del loro essere, all’oggi, nient’altro che aree sottoutilizzate. Si tratta quindi di spazi carichi di significato, proprio perché non utilizzati. Come avviene per i ricordi, questi luoghi entrano a far parte della vita interiore della città, del suo presente, ma si tratta di un’interiorità che vive al di fuori dell’utilitarismo dominante orientato al profitto, con il suo modo di organizzare lo spazio. È il lotto vacante che permette a chi ha la sensazione di vivere circondato dalla città di entrare in connessione con quest’ultima, in un’epoca di rapide trasformazioni: uno spazio vuoto da riempire di ricordi, nonché un luogo dove attivisti e artisti possono realizzare i propri progetti. Questa manifestazione di presenza è una forma di parola.
Forze de-urbanizzanti
Grazie alla loro natura complessa e incompleta, le città hanno storicamente sviluppato la capacità di sopravvivere agli sconvolgimenti, riuscendo, in una certa misura, a mettere in campo la propria risposta e ad arginare le tendenze de-urbanizzanti. Ma non vi riescono mai del tutto. Il potere, che si tratti di élite, politiche di governo, o innovazioni nel panorama architettonico, può sovrastare il discorso della città. Un meccanismo riscontrabile nella logica delle grandi opere, nelle strade di scorrimento veloce che tagliano in pieno lo spazio urbano, nella natura estrema dei processi di gentrification che quello spazio privatizzano, nel proliferare di grandi conglomerati caratterizzati dalla bassa qualità delle abitazioni e dall’assenza di attività commerciali e luoghi di lavoro, e in molti altri casi. Tutti esempi di tendenze de-urbanizzanti attualmente in corso.
Viviamo in un’epoca in cui il senso consolidato delle cose sembra vacillare. La città, così grande e complessa, con tutte le sue diversità, è la nuova zona di frontiera. Ciò è particolarmente vero nel caso della città globale, un luogo parzialmente plasmato a immagine e somiglianza della rete transfrontaliera di città in cui è inserita. Nella città globale, attori provenienti da diversi mondi hanno la possibilità di incontrarsi, ma senza chiare regole d’ingaggio. Se un tempo la frontiera era costituita dagli scampoli d’impero più remoti, oggi attraversa le grandi e complesse città in cui viviamo. Ad esempio, le pressioni delle imprese globali a favore della deregolamentazione, delle privatizzazioni e di nuove politiche monetarie e di bilancio si sono in gran parte concretizzate e sviluppate proprio nelle città globali. È la strada scelta dagli imprenditori mondiali per costruire l’equivalente del fortino militare lungo la frontiera tradizionale: la loro rete di fortini è il regime di regolamentazione su cui devono poter contare, città dopo città, ovunque nel mondo, per garantirsi margini di manovra su scala globale.[9] È un attacco feroce alla città e alle capacità di cui dispone per continuare a esserlo.
Nelle mie ricerche sul tempo presente,[10] ho individuato tre scenari che possono provocare la de-urbanizzazione di una città. Il primo è il drastico aumento delle disuguaglianze più disparate, che può innestare radicali processi di espulsione – dalle case e dai quartieri, dagli stili di vita del ceto medio. Una tendenza che può farsi particolarmente acuta e visibile nelle città, dove gli spazi di lusso e povertà si amplificano. Il secondo scenario riguarda l’edificazione di nuove città, ivi comprese le cosiddette città intelligenti, spesso costruite a mero fine di profitto. Allo stato attuale, sono ben seicento le città in corso di edificazione o progettazione. A destare particolare preoccupazione, su questo fronte, è il ricorso intensivo a sistemi intelligenti chiusi per il controllo di interi edifici. Se consideriamo quanto in fretta le tecnologie divengono oggi obsolete, intere porzioni di queste nuove città rischiano di avere breve vita. Una sfida a mio avviso interessante, sotto questo profilo, sarebbe quella di cercare di urbanizzare le tecnologie in questione, affinché possano contribuire all’urbanità di simili aree. Il terzo scenario, infine, riguarda i sistemi di sorveglianza di massa, oggi oggetto di collaborazione tra diversi Paesi – soprattutto Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Un punto, quest’ultimo, che vorrei discutere più in dettaglio nelle prossime righe.
Nel luglio 2012 il «Washington Post» ha pubblicato, in tre puntate, i risultati di un’inchiesta giornalistica durata due anni, intitolata Top Secret America.[11] Stando all’inchiesta, sono ben 1.271 gli enti governativi, nonché 1.931 le aziende private, che fanno parte di questa America top secret, per un totale di circa 854.000 persone, di cui 265.000 contractor privati, dotate di nulla osta di sicurezza ai massimi livelli – sarebbe a dire, circa una volta e mezzo la popolazione di Washington.[12 Sono le persone che lavorano per i programmi di lotta al terrorismo, la sicurezza nazionale e l’intelligence, nelle circa 10.000 sedi disseminate su tutto il territorio nazionale. Di queste, 4000 si trovano nella zona di Washington e occupano una superficie complessiva pari a circa 1,6 milioni di metri quadri – ovvero circa tre volte il Pentagono o 22 volte lo United States Capitol.[13]
Dentro tutti questi palazzi, potenti computer raccolgono enormi quantità d’informazioni derivanti da intercettazioni telefoniche, osservazioni satellitari, e altri strumenti di sorveglianza impiegati per monitorare persone e luoghi tanto internamente quanto esternamente agli Stati Uniti. Ogni giorno, la National Security Agency intercetta e immagazzina 1,7 miliardi di email, messaggi istantanei, indirizzi IP, telefonate e altri stralci di comunicazioni, selezionandone una piccola parte da archiviare in settanta diverse banche dati. [14] Parte di queste informazioni andrà poi a finire nelle decine di migliaia di rapporti top secret che gli analisti del campo producono ogni anno, ma a cui solo un numero estremamente esiguo di persone ha integralmente accesso – e peraltro il volume di questi rapporti è talmente grande che molti non vengono mai letti.[15]
Questo intero apparato di sorveglianza opera per garantire la nostra sicurezza. Nel nome della sicurezza, siamo tutti sotto sorveglianza, sarebbe a dire che siamo tutti considerati sospetti – sempre per la nostra sicurezza. La domanda sorge spontanea: nelle circostanze date, noi cittadini chi siamo diventati? I nuovi abitanti delle colonie?
Le città, con tutte le loro diversità e anarchie, con la loro capacità innata di contrastare le tendenze de-urbanizzanti, divengono uno spazio strategico per combattere l’idea che tutti debbano essere ridotti al rango di persone sospette. La città è il luogo dove è possibile, operando dietro le quinte della più familiare facciata della separazione e del razzismo, riuscire a sviluppare una sorta di convergenza strutturale che si elevi a dimensione sociale, permettendo a soggetti appartenenti a comunità profondamente diverse tra loro di unirsi per contrastare il predominio della sorveglianza. La possibilità che ciò si verifichi non cade dal cielo, ma richiede un duro lavoro. Ciò nonostante le città, così eterogenee e complesse, sono un luogo strategico dove una simile possibilità può materializzarsi.
Conclusioni
Perché è importante riconoscere l’esistenza delle capacità urbane, nonché la possibilità che costituiscano una forma di parola, con tutto il peso che l’affermazione comporta? Perché le capacità in questione sono proprietà sistemiche che permettono alla città di continuare a esserlo, ovvero di restare uno spazio complesso che prospera nella diversità e tende a mettere ordine al conflitto attraverso forme rinnovate di civismo. Inoltre, si tratta di capacità ibride – frutto della miscela tra la fisica materiale e sociale della città. Un’interdipendenza che comporta la continua trasformazione di entrambe queste sfere, con periodi di stabilità e continuità che si alternano a periodi di grandi sconvolgimenti, quale la fase in cui ci troviamo attualmente, iniziata negli anni Ottanta.
Non si tratta di antropomorfizzare la città. Si tratta di comprendere una dinamica sistemica capace di contrastare forze che hanno effetti distruttivi sul suo dna – un dna che, lo ripetiamo, costituisce l’essenza dell’essere città, con tutte le sue diversità. In situazioni limite, la città permette a chi è senza potere di fare storia e quindi di effettuare un salto critico – in cui l’essere senza potere da mera condizione diviene una complessità, e la possibilità di manifestare la propria presenza e fare storia entrano in gioco.
Ma queste capacità delle città non sono illimitate, e la storia ci offre esempi sia di città che si sono dimostrate capaci di sopravvivere a sistemi più rigidi e formali, sia di potenti forze de-urbanizzanti messe all’opera. Nella fase attuale, tra di esse troviamo le forme di disuguaglianza estrema, la privatizzazione dello spazio urbano con i diversi meccanismi di espulsione che ne conseguono, la rapida espansione dei sistemi di massa per sorvegliare i cittadini delle democrazie più avanzate del mondo. Tutte forze che riducono la città al silenzio e distruggono le capacità urbane.
Traduzione a cura di Eva Gilmore
———–
Note:
[1] Cfr. S. Sassen, Territorio, autorità, diritti, cit., cap. 8.
[2] La parola (speech) è qui intesa in senso giuridico astratto, come ad esempio quando si afferma che le corporation hanno facoltà di parola, per citare la sentenza Citizens United v. Federal Election Commission della Corte Suprema del 2010. Questa ha riconosciuto alle corporation il diritto a sostenere spese di natura politica in virtù del Primo emendamento sulla libertà di parola. Le città, come le corporation, non si esprimono con voce umana – parlano a modo loro.
[3] In italiano nell’originale (N.d.T.).
[4] In italiano nell’originale (N.d.T.).
[5] S. Sassen, The Global Street: Making the Political, in «Globalizations», n. 8, vol. 5, 2011, p. 565-571.
[6] Cfr. Id., Territorio, autorità, diritti, cit., capp. 6 e 8.
[7] Ivi, capp. 2, 3 e 6.
[8] Ivi, cap. 6.
[9] Ivi, cap. 5.
[10] Id., Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy, Belknap Press, Cambridge MA 2014.
[11] D. Priest, W.M. Arkin, A Hidden World, Growing Beyond Control, in «Washington Post», 19 July 2010; Id., National Security Inc., in «Washington Post», 20 July 2010; Id., The secrets next door, in «Washington Post», 21 July 2010.
[12] Ivi.
[13] Ivi.
[14] Ivi.
