cult
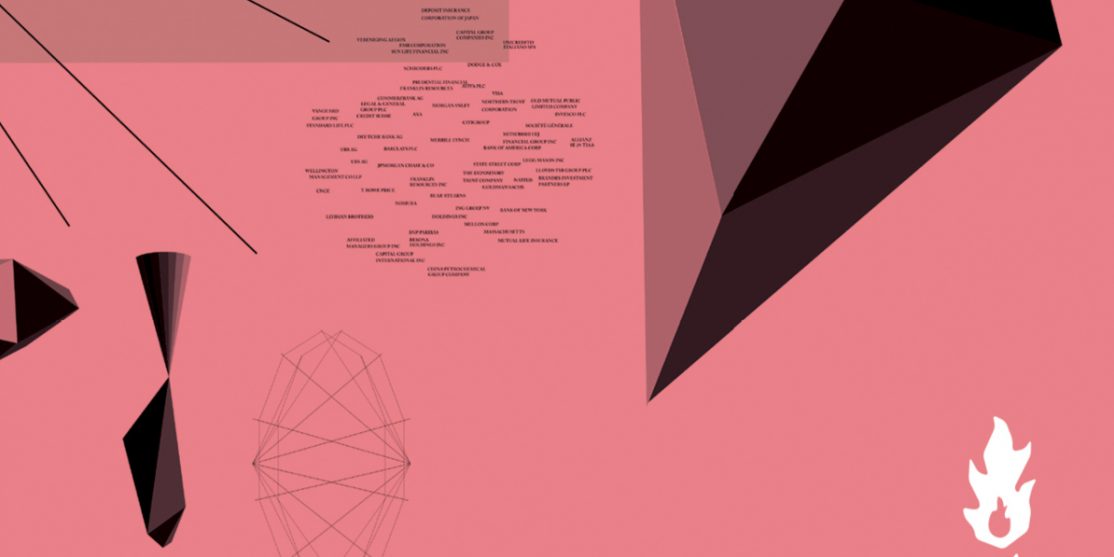
CULT
Contro l’autoritarismo della libertà finanziaria
A inizio settembre è stato pubblicato il nuovo libro di Verónica Gago e Luci Cavallero “Contro l’autoritarismo della libertà finanziaria”. Un manifesto contro il modo in cui, in nome della libertà, la finanza governa la vita della maggior parte della popolazione. Pubblichiamo qui una anticipazione del nuovo libro per gentile concessione della casa editrice Tinta Limón
«Non pensiamo sia una coincidenza il fatto che il concetto di libertà sia al centro del capitalismo finanziario portato avanti dall’estrema destra, a sua volta guidata dalle multinazionali che accumulano ricchezza nella sua forma algoritmica ed estrattiva» scrivono Verónica Gago e Luci Cavallero. In questo libro “Contro l’autoritarismo della libertà finanziaria“, approfondiscono la loro ricerca sui profondi legami tra neoliberismo, autoritarismo e antifemminismo, che trovano nella cosiddetta “libertà finanziaria” il loro concetto-feticcio, il manto sgargiante ma perverso di fronte alla velocità dell’impoverimento e alla crudeltà.
Un saggio in otto tesi
1. L’accumulazione di debito è indice della perdita di potere collettivo da parte də lavoratorə, retribuitə o meno, e della definizione collettiva di chi produce davvero ricchezza sociale. Da qui la sua funzione come dispositivo di pacificazione. Ma questa pacificazione si ottiene attivando un potenziale per il quale il debito esploderà.
Quando il debito diventa obbligatorio e imposto (il debito per vivere che produce terrore finanziario a causa delle continue politiche di austerità) diventa istanza di sovrapposizione tra espropriazione e sfruttamento.
Il debito, in relazione alla specificità presa in considerazione, assoggetta e attiva una forza lavoro che non si limita al salario (non è quindi soggetta a contratto di lavoro), creando stretti legami con il lavoro non retribuito, razzializzato e subalternizzato. Questo innesca le dinamiche di quello che abbiamo definito “estrattivismo finanziario”. Lo sfruttamento della forza produttiva del lavoro (retribuito e non retribuito) trova nel debito uno strumento versatile, che suggestiona positivamente chi è indebitatə, riconoscendone le capacità imprenditoriali.
2. Da quì, il debito allena alla precarietà, infiltrandosi nella riproduzione della vita quotidiana.
Parliamo di “allenamento” alla precarietà quando si verifica una abitudinarietà ma anche un’inventiva quotidiana nel risolvere la mancanza di reddito dovuta all’inflazione e al vivere seguendo l’economia del debito, di modo che la precarietà venga vissuta, attraversata e, allo stesso tempo, ispiri soluzioni alternative che utilizzino gli strumenti finanziari come elementi chiave. Allenamento significa anche, per noi, coltivare abitudini modulate dalle app di transazione finanziaria. In altre parole, gli strumenti della FinTech mitigano la violenza della moneta, scarsa e inflazionata, mentre occupano tempo ed energie per la loro gestione permanente, al punto tale da diventare, insistiamo, abitudine e indirizzamento. È così che intervengono nella definizione delle possibilità legate a questa ripetizione di abitudini e alla definizione dei futuri possibili.
3. Il debito ti costringe a un lavoro finanziario non retribuito permanente.
Questo comporta una gestione non remunerata del debito e, anche, forme di microspeculazione finanziaria quotidiana su piccola scala. Il lavoro finanziario non retribuito ha una doppia dimensione: gestire i redditi scarsi e poco retribuiti e i debiti conseguenti al lavoro di piattaforma e al dover ricorrere ad ogni piccola occasione “speculative”. L’impatto in termini di utilizzo del tempo e di conseguenze sulla salute mentale (a causa di stress, preoccupazioni e ansia) è un elemento centrale. È essenziale riconoscere, quindi, come la normalizzazione della crisi aggiunga una dimensione finanziaria non retribuita al lavoro di riproduzione sociale. Introduce inoltre, sul piano della riproduzione della forza lavoro, una soggettività speculativa con effetti immediati: un “allenamento” alla precarietà che viene superata finanziariamente.
4. Il debito mette in discussione una capacità di agire che si oppone alla vittimizzazione.
Il debito, in quanto strumento neoliberista, richiama, stimola e attiva una propensione all’azione, confinandola al contempo nel quadro dell’individualismo proprietario. Questo punto è fondamentale per comprendere cosa renda così efficace l’appello dell’estrema destra alla “libertà”, attraverso l’allenamento già esistente all’imprenditorialità basata sul debito. Questo porta a un altro punto chiave: quanto risultino sempre più insufficienti certi discorsi politici che, utilizzando il concetto dei diritti (oppure dietro la promessa di uno Stato salvifico che risolve ogni problema), riducono i loro potenziali elettori a “cittadini assistiti” o “vulnerabili”, quasi a voler mettere in primo piano l’incapacità di chi viene assistitə.
La stabilizzazione di forme diffuse di imprenditorialità e di impiego multiplo, insieme alla proliferazione di strumenti finanziari che consentono di superare la quotidianeità della vita in condizioni di estrema precarietà, plasmano una soggettività che si allontana dal vittimismo e si inserisce in quello che abbiamo definito “neoliberismo dal basso”. Il rapporto con il futuro diventa quindi fondamentale in questa eccitazione anti-vittimizzante all’azione, capace di eludere l’etichetta del “parassitismo” utilizzata per categorizzare chi riceve programmi sociali o beneficia delle politiche pubbliche.
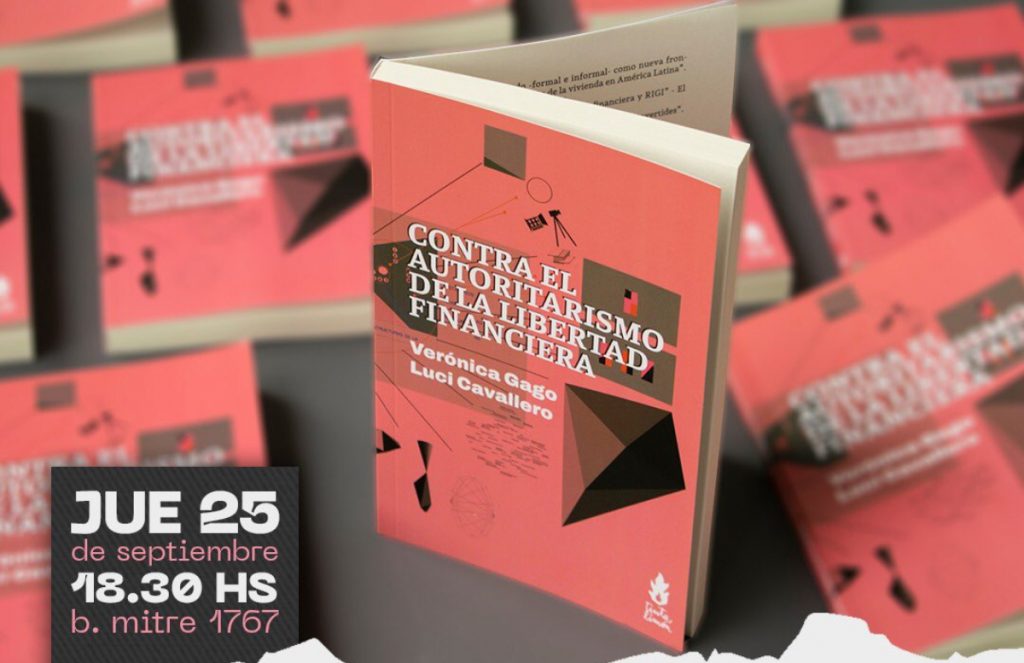
5. Il debito individualizza i costi dell’austerità, intensificando le divisioni classiste, sessiste e razziste.
Il debito è un dispositivo impersonale e al tempo stesso fortemente individualizzato. Come già studiato (per esempio da Nietzsche e da Lazzarato), il debito si individualizza attraverso la colpa e la responsabilità. Ma questa modalità di individualizzazione è anche, da una lettura femminista, una modalità di cancellazione della cooperazione sociale rafforzandone le divisioni di genere, razza e classe. Ridefinendo l’individuo, lo trasforma in creditore-imprenditore, mentre simula la fine dello sfruttamento ma al utilizzandolo al tempo stesso in termini di imprenditorialità individuale. Questa modalità di generare individui attraverso il debito è una dinamica chiave nella produzione di “libertà” che l’autoritarismo neoliberista tradurrà, mobiliterà e utilizzerà come forma di libertà finanziaria. L’austerità, quindi, ricadrà sugli individui che dovranno tradurla in un incentivo alla propria produttività e responsabilità.
6. Il debito come strumento di risoluzione della riproduzione sociale ripropone i dettami della famiglia eterosessuale e la divisione sessista e razzista del lavoro.
Il debito non è astratto; agisce su corpi genderizzati e razzializzati. Il debito è basato, costruito e articolato in base alla divisione sessista e razziale del lavoro. Questo è reso evidente dalle diverse modalità che abbiamo evidenziato: il maggiore indebitamento si riscontra nelle famiglie dove più è presente il lavoro non retribuito; lì si radica l’indebitamento più informale e con livelli più elevati di esposizione alla violenza in caso di mancato pagamento; il tasso di interesse funziona come indice esplicito del razzismo e del sessismo data la conseguente creazione di gruppi sociali “a rischio”, contrariamente a tutte le prove empiriche. Il debito sfrutta e ribadisce i dettami di genere e si articola con essi: chi sostiene il peso delle economie domestiche si assume spesso anche il debito come risorsa per sostenere la famiglia in un contesto di crisi. Il debito mira a catturare, sfruttare e negare la condizione di interdipendenza che donne, lesbiche, trans e persone non binarie hanno tradotto in tecnologie vincolanti che vanno oltre i confini della famiglia eterosessuale.
7. La pandemia ha offerto l’opportunità di ampliare la cosiddetta “inclusione finanziaria”. Questo ha accelerato la digitalizzazione come mezzo di accesso ai sussidi di emergenza e all’estrazione di dati. Le informazioni generate sono state poi utilizzate per monitorare e sanzionare le “transazioni finanziarie” relative a determinati consumi in determinati settori.
È necessario problematizzare la situazione di uno Stato che sembra associare l’inclusione finanziaria (in un momento di emergenza) ai programmi sociali per poi utilizzare le informazioni contenute in quei conti come strumento di penalizzazione delle transazioni finanziarie tra i settori più poveri. Alla fine dei conti, l’accesso ai sussidi condiziona gli utenti verso determinati modelli di comportamento e consumo. La penalizzazione a cui ci riferiamo non è solo selettiva, ma punisce anche le “transazioni finanziarie” effettuate per la sussistenza dopo che tali strumenti (come le app di transazione finanziaria o i portafogli virtuali) sono stati promossi nell’ambito dell’idea di inclusione finanziaria. Questo rivela che la digitalizzazione è uno strumento fondamentale per il controllo dei consumi a favore della penalizzazione che abbiamo segnalato. E tali consumi, penalizzati dalla dollarizzazione, rafforzano la moralizzazione quando si tratta di settori impoveriti e femminilizzati.
8. La stabilizzazione del debito nella gestione della vita quotidiana opera in vari modi, dalla differenziazione dei consumi come forma di resistenza alla precarietà, fino al tentativo, in ultima analisi, di interiorizzare l’austerità. Il debito, inoltre, funziona specificamente in un contesto di inflazione e deregolamentazione.
La retorica dell’austerità utilizzata dal governo “anarco-capitalista” durante la campagna elettorale è entrata ormai nel linguaggio comune interiorizzando il sacrificio sotto il monitoraggio costante del FMI. Così, il debito delle famiglie è diventato paradossalmente un modo di “resistere” e di gestire la precarietà attraverso dispositivi finanziari. Il debito svolge funzioni specifiche in sequenze temporali specifiche. La possibilità di posticipare temporaneamente gli effetti dell’aggiustamento strutturale ha creato le condizioni per la privatizzazione in ogni famiglia degli impatti dell’austerità.
Oggi, il debito è un acceleratore dell’economia digitale e delle piattaforme. Gilles Deleuze ha demonizzato la moneta per riflettere sulla transizione da una società disciplinare a una società di controllo. Ha affermato che «la vecchia talpa monetaria è l’animale degli ambienti di internamento, mentre quello delle società di controllo è il serpente monetario». Cosa possiamo dire sui portafogli virtuali, sul credito algoritmico e sul debito come moneta popolare? Quale tipo di animale potrebbe essere all’altezza dei loro standard e delle loro dinamiche? Senza ombra di dubbio, l’avvoltoio.
Articolo pubblicato sul sito della casa editrice indipendente Tinta Limón Ediciones, che ringraziamo per la gentile concessione. Traduzione in italiano di Michele Fazioli per DINAMOpress
Immagine di copertina: particolare della copertina del libro. Immagine di copertina di Alicia Herrero. Saggi su un tribunale. Al potere dell’economia politica, Parque de la Memoria, Buenos Aires (2019).
SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS
Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno
