approfondimenti
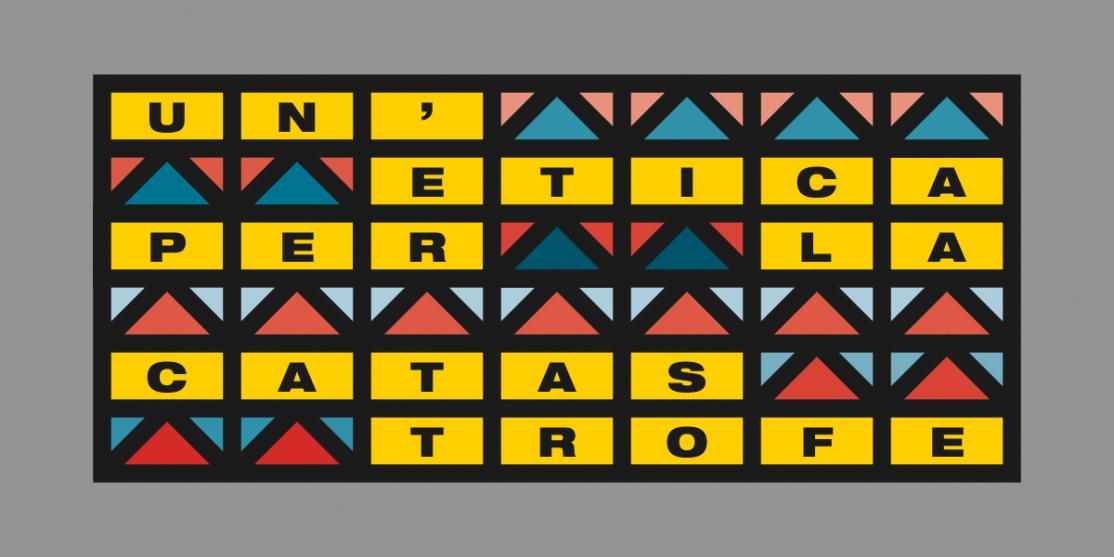
CULT
Un’etica per la catastrofe
Parole e immagini sul bordo dell’abisso. Assemblaggi, linee di condotta, approssimazioni e abbozzi per il mondo da conquistare, quello da salvare, quello da fare
A Marina, la ragazza del mare.
Catastrofe.
Scrive Walter Benjamin, mentre scappa dai nazisti: «Il concetto di progresso va fondato nell’idea della catastrofe. Che ‘tutto continui così’ è la catastrofe. Essa non è ciò che di volta in volta incombe, ma ciò che di volta in volta è dato. […] l’inferno non è qualcosa che ci attenda, bensì questa vita qui».
La catastrofe per eccellenza, l’inferno, è il capitalismo senza alternative, senza ‘fuori’, senza «disunione». La società borghese, del capitalismo, è stata civilizzata dalla lotta di classe, secondo il ritmo di quattro fratture fondamentali: il 1848 europeo; il 1871 e la Comune di Parigi; il 1917 russo e bolscevico; il 1968 mondiale.
La sconfitta del 1968 sotto i colpi della controrivoluzione neoliberale, l’implosione del blocco sovietico (per il quale, chi scrive, non prova alcuna nostalgia), hanno aperto il campo alla catastrofe che abitiamo da un trentennio. Circa cento anni fa, la sconfitta dei consigli operai, tedeschi e italiani, ha spianato la strada ai fascismi – che, della catastrofe capitalista, sono effetto mostruoso –, all’orrore e alla devastazione senza pari della Seconda guerra mondiale.
Nella catastrofe, prima che diventi abisso e guerra, non esiste più la storia, viene esaurito il possibile: esistono solo dati, fatti, c’è solo il presente, il più forte, quello che vince, il vincente. Chi progetta/programma è un pericoloso mitomane, perché la previsione è sempre imperfetta, perché esiste solo il caso – che, guarda caso, agevola il più forte; chi condivide, e solidarizza, è un narcisista che ha tempo da perdere. Tutto ciò che è reale non ha bisogno di essere razionale, semplicemente c’è, è lì, funziona, ed è bestiale: «l’umana specie è peccatrice» (il male è radicale), «i ricchi ci sono sempre stati», «la guerra piace a molti», «gli uomini hanno sempre stuprato e ucciso le donne», «da che mondo e mondo, ci sono schiavi», ecc.
Michel Foucault amava tradurre laissez faire con «lasciar accadere»: che tutta la merda di cui siamo fatti venga a galla, tarparle le ali sarebbe «coercizione» – direbbe il macellaio Friedrich von Hayek. L’importante è che viga imperioso il diritto privato (il ‘mio’ e il ‘tuo’ prima di tutto, chiariva Bernard de Mandeville), che la verità la imponga il mercato, che ci siano migliaia di giornali, emittenti televisive e social network, magari dello stesso proprietario, che possano però parlare e far parlare in continuazione, dicendo tutto e il contrario di tutto. Parlare sempre, indipendentemente dal contenuto, dall’efficacia dell’enunciato, dalla posizione dell’enunciante: semplicemente parlare, fare rumore, confondere, sporcare le acque – ci torneremo a breve.

Etica.
La società della catastrofe, ovvero il capitalismo senza «disunione», usa e al contempo respinge la morale. Serve la famiglia, serve il patriarcato; senza di loro, bene sapere, il diritto privato è mancante, non funziona come deve: la Corte suprema degli Stati Uniti d’America insegna. Alla base dei contratti, c’è sempre un contratto: è quello sessuale, ha chiarito in modo definitivo Carol Pateman. La «cosa», la proprietà, è anche e soprattutto una «schiava di rango superiore», la moglie.
Che questa barbarie, il matrimonio, sia diventata battaglia fondamentale per l’estensione dei diritti civili, dovrebbe spingerci a essere meno indulgenti col “nuovo” che avanza; anche quando “tatticamente” utile, sa essere atroce, o quasi, come l’arcaico che col “nuovo” non smette di riemergere. Tra il circo delle differenze disarmate, il declino d’Occidente, e la violenza patriarcale e omofoba dei poteri d’Oriente, c’è un sotterraneo legame: liberalismo e autoritarismo hanno un nemico in comune, la democrazia dei molti, la differenza come contropotere – ciò, tra le altre e gli altri, ci hanno insegnato Carla Lonzi, Selma James, Mariarosa Dalla Costa, Lea Melandri, Mario Mieli.
Per un verso, dunque, non c’è mercato efficace senza rispetto della Patria, del padre e della tradizione, anche se la tradizione è condita con un po’ di carnevale delle quote. Per l’altro, il liberalismo non sopporta la morale: chi sa troppo, e ne sa di storia, fa la morale; chi è solidale, e non compete, è un moralista; moraliste per antonomasia sono le femministe; moralista insopportabile è l’antirazzista di turno, colui che osserva il politically correct. Si tratta di un double bind, di quelli che solitamente rendono schizofrenici: «fotti, tira coca, ammazza, stupra, compra in modo compulsivo, indebitati, ma poi – cazzo! – credi nella Patria, sì un eroe in divisa come Zelensky, sposati, lavora dalla mattina alla sera, astieniti, risparmia, credi nei valori, conserva i valori, fatti valere».
Putin, a differenza dell’Occidente difeso da Mr. Biden, è un effetto mostruoso della catastrofe; che scioglie il bind e si limita a pretendere meno, dai suoi sottomessi: odia le checche, le femministe, i drogati, propone eroi, abnegazione, Patria, famiglia e Carl Schmitt. Contro Mr Biden e il tenente colonnello di Dresda, ci vuole un’etica: per affrontare la catastrofe, per venirne fuori, per tornare a respirare. «Regole di comportamento», indica Bertolt Brecht con stile cinese, nel suo Me-ti. Libro delle svolte; convenzioni, istituzioni, bande, criteri, orientamenti, esempi: tutto un brulicare di contropoteri per abitare il mondo prima della fine del mondo, per salvare il mondo a un passo dall’abisso.
Per etica, senza girarci attorno, si intende: parla solo chi mostra, con la propria vita, la verità di ciò che dice; non esiste la legge, con la sanzione, ma solo l’indicazione pratica: «si fa così, e non così, vieni che ti mostro; lo faccio con te». Troppo faticoso? Lo è senz’altro meno di sputare sangue per un salario da fame. L’etica è una politica, e viceversa.
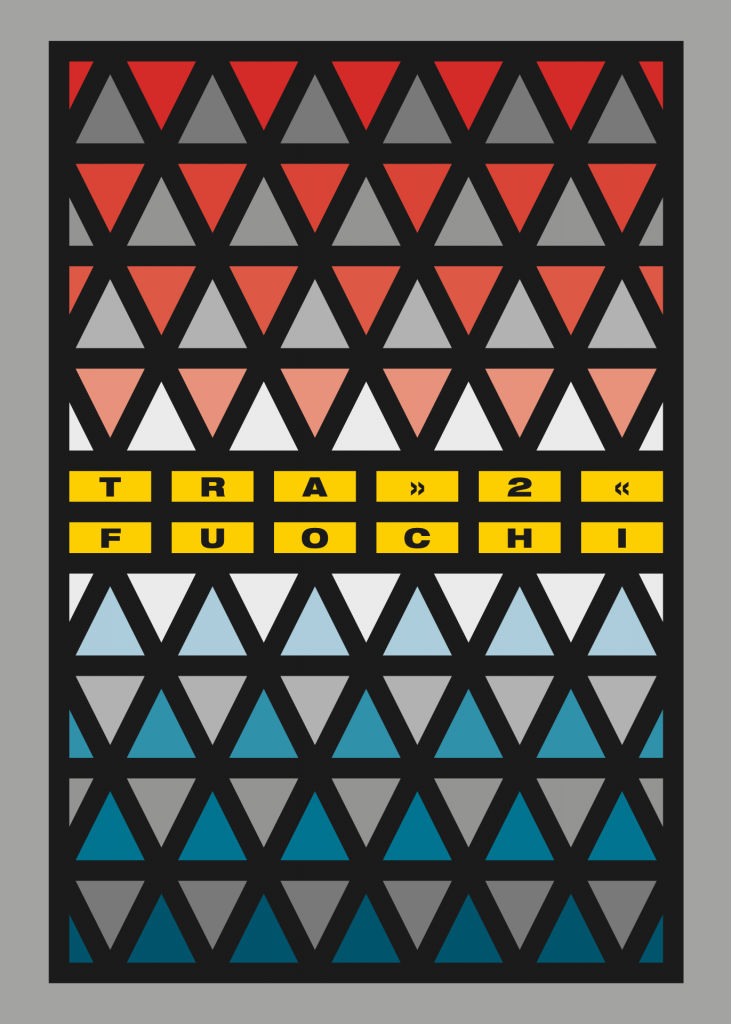
Tra due fuochi.
Così ci sentiamo, questa è la nostra condizione. Sappiamo chi è Putin, a differenza di chi oggi invia armi agli ucraini e che, tempo addietro, aveva ammirazione per il KGB. Il 1968 è contro le invasioni di Budapest e di Praga, contro il PCI che le ha invece sostenute. Ma è anche contro la guerra infame in Vietnam. I due fuochi di allora, del mondo diviso in due, oggi sono senz’altro più di due. «Multipolarismo competitivo», hanno chiarito gli esperti: un modo pacioso per presentare la guerra mondiale in arrivo. Ma tutto sommato i fuochi sembrano essere sempre due, o almeno così vogliono farci credere.
Da una parte la democrazia, quella di Biden e di Johnson; dall’altra, l’autocrazia, quella di Putin e Xi Jinping. Pure Modi e Bolsonaro starebbero dalla parte dei secondi, ma, al pari di Pinochet al tempo, Bolsonaro è amico degli Stati Uniti (Trump e soci nello specifico), soprattutto è un solido alleato del diritto privato e della Patria. E Modi sarebbe bene non si avvicinasse troppo alla Cina – Biden è al lavoro, con risultati non eccellenti a quanto pare. Diciamo dunque che, per adesso, i “cattivissimi” sono Putin e Xi Jinping.
I buoni, quelli che usano combattere per l’umanità attraverso «bombe intelligenti», hanno in odio la democrazia dagli anni Settanta. L’esplosione del 1968, delle lotte di minoranze (donne, studenti, afroamericani, lotte anticoloniali, banlieue) che lo anticipano e lo seguono, genera un «eccesso di democrazia», una proliferazione di «aspettative crescenti», che il capitalismo non può e non vuole sopportare. Svolta monetarista, disoccupazione di massa, decentramento produttivo e globalizzazione degli investimenti, liberalizzazione della finanza, sanciscono l’inizio della controrivoluzione.
C’è da dire che la reazione neoliberale è particolarmente sofisticata: certo, ci sono sconfitte cocenti ed esemplari inflitte al movimento operaio e ai sindacati in genere, i piloti negli USA e i minatori in UK, la marcia dei quarantamila a Torino; ma c’è anche, e soprattutto, lo scambio – in particolare in Occidente – tra edonismo libertario/consumistico e precarizzazione del lavoro. Solo a distanza di quaranta anni, dopo l’erosione del Welfare State, il disastro della tacita permuta di allora si traduce in working poor, depressione generalizzata, aumento dei suicidi, NEET, ecc. A distanza di quarant’anni, sappiamo che il capitalismo senza «disunione», senza «tumulto», è la catastrofe. Nostro compito, pur nella fragilità che ci affligge, è immaginare, accendere e alimentare un terzo fuoco, alternativo e ostile al dispotismo quanto al liberalismo contemporanei.
Destituire il potere di dire ‘Io’.
Si tratta di una frasetta decisiva che Gilles Deleuze riprende da Maurice Blanchot. Mettendoci del suo, as usual. L’enunciato «Io sono infelice» occulta, invece di darne conto, la condizione di cui sto facendo esperienza. Per raggiungere la singolarità del mio affetto, che è semplicemente un modo evenemenziale, nonché effetto di relazione, della comuna potenza di vita che ci attraversa, serve la terza persona singolare: «egli è così infelice».
Usando la terza persona, per parlare di sé, non si pecca di arroganza. Indica Me-ti ai suoi scolari di prender nota sulle cose che fanno come si trattasse di compilare una biografia per la classe in favore della quale si lotta. Vivendo in terza persona, ci si scaglia allora contro la violenza originaria del pronome personale ‘Io’, quella parolina a partire dalla quale, chiariva Kant, l’umana specie – maschia e bianca, ovviamente – si alza al di sopra della natura e la domina, la rende strumento, la sfrutta.
I critici del 1968, siano essi reazionari o rosso-bruni, o semplicemente psicoanalisti amici di Matteo Renzi, domandano spazientiti: ma non è stato proprio quell’anno terribile a convincere donne e uomini che il pronome personale ‘Io’ fosse più importante del ‘noi’? Facendo sfoggio del Pasolini peggiore insistono: non fu proprio Valle Giulia a rendere i poveri viziati e consumisti? La risposta dei migliori di allora è netta: evviva gli operai che volevano più di una macchina e il televisore buono, non fu il Sessantotto a renderli individualisti, ma la sconfitta militare dell’assalto al cielo! A distanza di mezzo secolo, forse è preferibile essere meno sbrigativi.
Vero, la controrivoluzione in Italia è stata anche e soprattutto la carcerazione di massa, i carrarmati a Bologna, le stragi di Stato; tutto ciò, in diversi casi, con la collaborazione del PCI. Ma non è successo qualcosa, forse, anche sul fronte del desiderio? Preme insistere: il Sessantotto non fu il trionfo dell’individualismo libertario, ma delle minoranze. Le minoranze in lotta «dividono l’Uno in due» in modo nuovo, rispetto al passato del movimento operaio: si affaccia nella storia, e prende consistenza, un pluralismo politico nel quale la singolarità di ciascuno brilla in quanto implica, esprimendosi nella prassi, la moltitudine.
Il ‘si’ impersonale, condannato da Martin Heidegger in Essere e tempo, riesce allora a dar conto di una singolarità che non è individuale, di un ‘noi’ da non confondere col popolo, con la comunità, con la piaga dell’identità. Deleuze, andando oltre Blanchot, propone l’evento, campo metastabile carico di energia potenziale, con i suoi punti singolari. Una sorta di «quarta persona singolare»: «si lotta»; «senza riparo, si va incontro a tutti». La controrivoluzione neoliberale ha corrotto la singolarità nell’individuo, l’aumento salariale nel mutuo per comprare casa, la differenza in Platinette. Affinché la corruzione conquistasse la scena, le bombe sui treni e la militarizzazione dello scontro politico hanno fatto la loro parte.
Ma il resto è passato per l’inconscio, una repressione molecolare fatta di immagini, shock, mode, pubblicità, culto dell’unicità, «Milano da bere», vacanze a Ibiza, cocaina; e a seguire, negli anni zero, cocaina, “bolle” social, «apericene», fitness, cuochi «stellati» che si occupano di food e si lamentano perché i giovani lavorano poco, centri benessere e botulino. «Perché io valgo», «tutto intorno a te», «inimitabile, come te»: tra gli slogan della barbarie. Vivere in terza persona, conquistare nella prassi la quarta persona singolare: per farla finita con l’inferno del pronome personale ‘Io’.
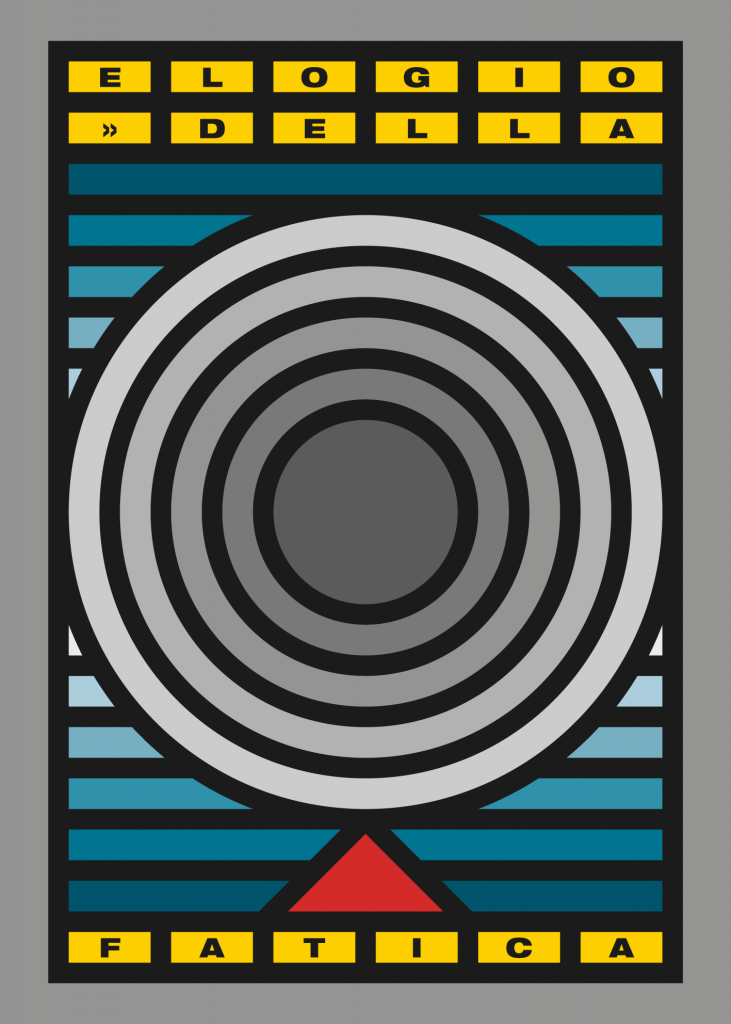
Elogio della fatica.
Trattasi di un oggetto ormai odiato dai più, senz’altro da maneggiare con cura. Se non si sta attenti, infatti, il rischio è confondersi con la celebrazione maschia e nostalgica di Stachanov – a proposito di Donbass. Il tema è un altro: non c’è rifiuto del lavoro sotto padrone, oggi, senza rinnovata capacità di faticare.
Avere fiducia nella vita collettiva, per i gruppi, nonostante tutto; schivare i colpi del risentimento e dell’ingratitudine; ascoltare pazientemente Clara e Robert Schumann; viaggiare stando fermi, educando l’immaginazione; imparare il tedesco; leggere la stampa padronale in più lingue, la mattina al risveglio; fare solfeggio e ripetere l’esercizio, con il pianoforte, centinaia di volte; camminare per ore invece di prendere la macchina, camminare in salita, in montagna e ovunque; studiare sempre, la domenica, negli interstizi, quando possibile; conoscere nel dettaglio il XIX secolo; prendere in considerazione lo studio del sanscrito; dedicarsi, con tenacia, all’inappariscente preparazione di uno sciopero, consapevoli di poter fallire, comunque di non strappare un servizio del Tg3: sono solo degli esempi, se ne potrebbero fare molti, molti altri, di ciò che si intende con fatica, fatica ostile al lavoro salariato.
Il lavoro vivo contemporaneo, passando da un impiego di merda all’altro, è condannato all’abbuffata frenetica, senza misura né differenze: non occorre leggere, ma informarsi a spanne; non serve studiare sul serio, ma stare sul pezzo, conoscere il nuovo che avanza; non serve ascoltare, ma farsi un’idea di massima e passare ad altro; non ci si può perdere camminando in città, perché ogni giornata è (e deve essere) zeppa di appuntamenti incastrati l’uno sull’altro; non serve il passato, occorre fiutare le tendenze, inebriarsi di futuro (senza alternative); gli amici costano, dunque bene, se proprio uno vuole averne, cavarne fuori qualcosa di utile; quando sono necessarie competenze che valgono, quelle tecnico-scientifiche (materie STEM), bene che nulla abbiano a che fare con la politica e la storia; il gusto estetico è soggettivo, tutta la merda che passa va bene, basta che sia giovane, dei giovani, per i giovani. Le fatiche sopra sommariamente indicate, un tempo avevano a che fare con la disciplina rivoluzionaria o con una solida formazione borghese, o con entrambe messe assieme.
Per i proletari, la disciplina rivoluzionaria poteva rendere accessibile, tra mille difficoltà, un uso antagonista della formazione borghese. Disciplina rivoluzionaria e formazione borghese, oggi, sono espressioni vuote. La derisione della disciplina, in nome del disincanto, si accompagna da tempo con la mediocrità diffusa dei «figli dei papà». Si tratta, oggi, di inventare una disciplina che non sia una regola monastica, una cultura proletaria che sia alta più che bassa, oltre il disfacimento della Kultur.
La pazienza del piacere.
È un gioco, il piacere, ma non è uno sport. L’epoca della catastrofe si distingue perché, in essa, ogni gioco è uno sport, una gara. Nel piacere non ci sono vincitori e vinti, non si compete, non ci sono medaglie alla fine. Giocando, si impara a giocare. È una questione di leggerezza, di tempo sospeso, di autoironia, di superficie, di goffaggine e di propensione all’errore. Un gioco prevede delle regole, ma sono, frequentemente, regole che si fanno giocando.
Ciò vuol dire che ogni singolo caso del gioco esige una regola; che sta lì, nel gioco, come la sua virtù. Una regola non è una norma, ma la misura di una composizione: «come ti piace? Così, ti faccio vedere»; «ora non mi va»; «non andare via, continuiamo a giocare». Il piacere ha spesso a che fare con la fatica. Può essere esito di una fatica, ma anche la fatica del gioco. Il gioco è un impegno, è faccenda seria, pretende dedizione. Per giocare, e provare piacere, ci vuole pazienza: saper aspettare, saper assaporare, saper accarezzare.
Chiarisce Benjamin: «ancora una volta», nel gioco dell’infante, è (sempre) la «prima volta». Si ripete l’inizio, si ripete la differenza, una continua variazione sul tema. In questo senso, obiettivo della rivoluzione è fare della vita un gioco, giocando il gioco della vita. E la rivoluzione, allora, chiede fatica e pazienza.
Mira al cuore.
L’amore non è mai scarso, non finisce, semmai si inabissa; può congelarsi, se esposto all’infamia, all’atrocità della guerra. Di quest’ultima, andrebbe indagata l’educazione sentimentale. La guerra educa alla guerra, come il carcere al carcere, lo stupro allo stupro, la rapina alla rapina, la furia patriarcale al patriarcato, ecc. Determinismo rozzo? Può darsi, ma meglio delle cazzate sulla libertà individuale e il libero arbitrio che ci assediano la testa da secoli. Il realismo politico recita: «l’essere umano è cattivo», «in politica l’amore non esiste», «la Storia è un cumulo di macerie». Si tratta invece di affermare che c’è storia perché c’è amore, la vita che combatte la morte, l’istituzione che tiene testa al caos, la misura che compone le forze.
Nell’epoca della catastrofe, l’amore viene relegato alla sfera privata, alla realizzazione di una sessualità appagante, alla vita degli individui; una mescolanza di «sentimentalismo kitsch» e calcolo dell’utilità lo rende ostile alla prassi, alla sfera pubblica. Se invece si volta lo sguardo al mondo diviso dalle rivoluzioni proletarie, immediato il ricorso a Schmitt: «lui sì, che ha colto l’essenza del ‘Politico’, l’inimicizia»; l’amico, se c’è, è semplicemente il nemico del mio nemico. E si presenta un bivio: confondere Lenin con Schmitt o abusare del mito del buon selvaggio, dell’essere umano buono di natura? Ammesso che Schmitt abbia letto correttamente l’antropologia di Helmut Plessner, confondere Lenin con Schmitt è prova di stalinismo etico-politico.
Schmitt, tra l’altro, si è sforzato fino alla fine di pensare nostalgicamente lo Stato della modernità europea contro Lenin (e Mao). Vi è stata in Lenin, indubbiamente, la grandezza di chi sa cogliere il kairos, la capacità di pensare e agire nella congiuntura singolare, ma il problema dell’insurrezione, della lotta armata, è da Lenin sempre radicato nell’azione di massa. Fu così a settembre del 1917, quando buona parte dei bolscevichi titubavano: lo sguardo e le parole di Lenin sono avvinghiati ai fatti di luglio, all’esuberanza dell’azione armata dei proletari di Pietroburgo, non solo, e non principalmente, al pericolo dell’iniziativa repressiva di Kerenskij.
Lenin, come Machiavelli e al contrario di ciò che solitamente si afferma, pensava che «la moltitudine è più savia e più costante che uno principe» (leggi: che gli operai armati fossero più lucidi del Comitato centrale bolscevico). Realismo è politica di massa, altrimenti è trascendenza sovrana. Ciò vuol dire che siamo naturalmente buoni, capaci di amare il prossimo come noi stessi? Evidentemente no. Proprio perché non siamo buoni né cattivi per natura, l’amore è una «macchina da guerra». In che senso? Scrive Me-ti: «l’amore […] è un’attività produttiva. Essa modifica amante e amato, che sia in meglio o in peggio». Un’attività, non un semplice sentimento; che produce nella relazione, ovvero trasforma coloro che si amano, produce soggetti, forme di vita, istituzioni; l’amore, quando produce, combatte affinché le trasformazioni prodotte facciano presa, si diffondano, siano d’esempio. L’amore combatte l’infelicità e l’odio, combatte il mondo dove infelicità e odio sono il nutrimento affettivo per i più. Che ne sarà, dell’esclusività del nostro amore, se l’amore lotta con altre e altri, e contro la tristezza del mondo dato? Finalmente gli amanti, come insegna Me-ti, «costruiscono il loro amore conferendogli alcunché di storico, come se contassero su una storiografia».
Fuori posto.
Camminare lungo sentieri impervi, scegliere di perdersi. L’incertezza carica d’angoscia alla quale siamo continuamente esposti (la crisi economica, la pandemia, la guerra atomica, ecc.), la stessa che funge da tecnica privilegiata per il governo e lo sfruttamento della nostra forza-lavoro, spinge continuamente verso casa, cercare casa ovunque. Casa: nicchie ambientali, gerghi, piccole o grandi patrie, rifugi, vita privata, “bolle”, riti, spiritualismo vario ed eventuale.
L’assenza di bussole ci inchioda, già inchiodati dalla pandemia. Anche quando ci si muove forsennatamente, tentando di recuperare il tempo perduto, il desiderio si aggrappa a quel poco che sembra stabile: una battuta di spirito, quei sorrisi, le stesse danze, con l’ossessione di ritrovarsi, nella speranza che nulla sia davvero cambiato. E in verità non contano tanto neanche i luoghi, ignoti o abituali che siano. Combattere la catastrofe vuol dire, ora più che mai, vivere fuori posto, assaporare l’inquietudine, camminare nel deserto.
Il posto non è semplicemente una posizione «strutturale», quella che ci viene assegnata e che (spesso) ci assegniamo nell’ordine simbolico; non è quasi più il lavoro, non solo perché si lavora dappertutto, ma perché l’impiego è in prevalenza temporaneo, di passaggio. È piuttosto un modo del rapporto: con un certo luogo, con quei volti, con quegli enunciati usuali, con il lavoro o la sua mancanza, con la barbarie quotidiana, con se stessi. Cercare dimora ovunque o, invece, vivere ovunque fuori posto, ovvero fare uso, nella vita, dell’«effetto di straniamento», lo stesso che per Brecht aveva il compito di innovare la tecnica dell’attore, introducendo il materialismo dialettico nel teatro.
Non si tratta, come per l’attore brechtiano, di rendere libero il pubblico, mostrando il personaggio oltre a viverlo. Si tratta, in questo caso, di rendere liberi se stessi, di liberare il mondo dalla catastrofe, facendo emergere increspature dove tutto sembra liscio, alternative dove pare che non ce ne siano, e soprattutto provando dolore e indignazione per la sofferenza altrui, contro l’assuefazione all’orrore – d’altronde, sono proprio questi gli obiettivi del teatro epico. È come se l’immedesimazione del pubblico con i civili sotto le bombe, fabbricata attraverso la TV e la rete, servisse tutto sommato a rendere familiare, e quindi inevitabile, l’Apocalisse: trenta secondi di commozione mista a paura, un bonifico umanitario, poi veloci verso l’aperitivo, ché la vita è già tanto complicata per stare pure a occuparsi della guerra mondiale in arrivo.
Ciò vale per quel che resta della classe media, più o meno liberal o radical (in entrambi i casi, pattume). Per chi crolla nella povertà – relativa e assoluta – già da un decennio, la musica che suona è un’altra: rapidamente, dopo la prima immedesimazione, comincia il fastidio per chi, pur soffrendo, impone un carovita insostenibile. Il «ceto medio riflessivo», la sinistra dei salotti televisivi e dei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche, dovrà darsi molto da fare a convincere chi subirà i colpi più duri dell’inflazione che stiamo combattendo per difendere le nostre libertà, i nostri diritti umani e civili.
Farsi estranei al mondo dato non è mera registrazione dell’eccentricità antropologica. L’indeterminatezza della nostra natura o essenza, la cosiddetta apertura che ci riguarda in quanto specie, in assenza di istituzioni e di conflitti sociali spinge verso la gabbia dell’identità, l’ossessione per la famiglia e la patria, il razzismo guerrafondaio. Effetto di straniamento è la critica, il distacco come combattimento, l’incertezza come orizzonte del possibile: si tratta dunque di un’etica, di una regola di condotta, di una politica. Come per il teatro brechtiano, si tratta di «trasformare la critica in fonte di godimento».
Realismo senza resa.
Dirsi tutta la verità, senza girarci attorno, senza fronzoli («mira al cuore»). Sì, siamo a un passo dalla guerra mondiale, nucleare. La catastrofe quotidianamente cancella la «disunione», silenzia la critica, arruola i buoni sentimenti. Il suo punto d’arrivo, temporaneo ovviamente, è la guerra. Sono, i movimenti sociali, all’altezza di ciò che sta dilaniando l’Europa e il mondo? No. Dirsi questo, dire la verità all’amico, alla compagna, non ha nulla in comune con la rassegnazione. Il realismo non è ostile alla veggenza, all’ebbrezza, al desiderio di produrre nuove istituzioni, di assembleare corpi e segni, di inventare «macchine da guerra».
Riconoscere le lame del mondo e la nostra fragilità, fare i conti col negativo, che non è semplicemente una differenza e difficilmente porta con sé riscatto, non ci consegna mani e piedi alla cupezza del ‘Politico’ con la ‘p’ maiuscola. Lasciamo ai maschi del Sessantotto fare i conti con la loro senescenza; è un colpo duro, per loro, loro che hanno odiato i padri supponendo di poter rimanere figli per sempre; ma non possiamo fare più nulla per aiutarli, li abbiamo ascoltati con fin troppa pazienza. Invecchiano, Carl Schmitt li fa tornare giovani, il ritornello lo conosciamo.
Riconoscere la fragilità, è fondamentale chiarire, non è il lasciapassare della remissività, con tanto di culto della non violenza. Evitare di raccontarsi balle, misurarsi con la sproporzione delle forze – militari, mediatiche, economiche – che l’epoca porta con sé, può invece agevolare diversioni feconde, sperimentazioni inedite, incontri insperati, un accumulo virtuoso di slittamenti molecolari. Non è vero, sarebbe altrimenti più facile, che abbiamo solo le nostre catene da spezzare: il proletariato contemporaneo, anche quando duramente colpito dalla disoccupazione e dall’impoverimento, vive dentro tessuti relazionali complessi, fatti di economia informale e criminale, di welfare comunitario e alternativo, di sussidi e programmi d’assistenza.
Quando si tratta di migranti, i salari da fame per loro previsti in Occidente funzionano, nel paese di provenienza, come gruzzolo buono per sfuggire alla miseria. Forse non è mai esistito un soggetto omogeneo di nome ‘proletariato’, lo stesso movimento operaio ha dovuto fare esperienza dell’uso capitalistico delle migrazioni, della gerarchizzazione della forza-lavoro secondo la linea del colore e del genere, dello sfruttamento minorile, della guerra. Ma oggi più di sempre, con la conquista piena del mercato mondiale, il capitalismo produce differenze e le sfrutta al contempo – Sandro Mezzadra e Brett Neilson, a più riprese, hanno detto ciò che c’era da dire al riguardo; così il black feminism.
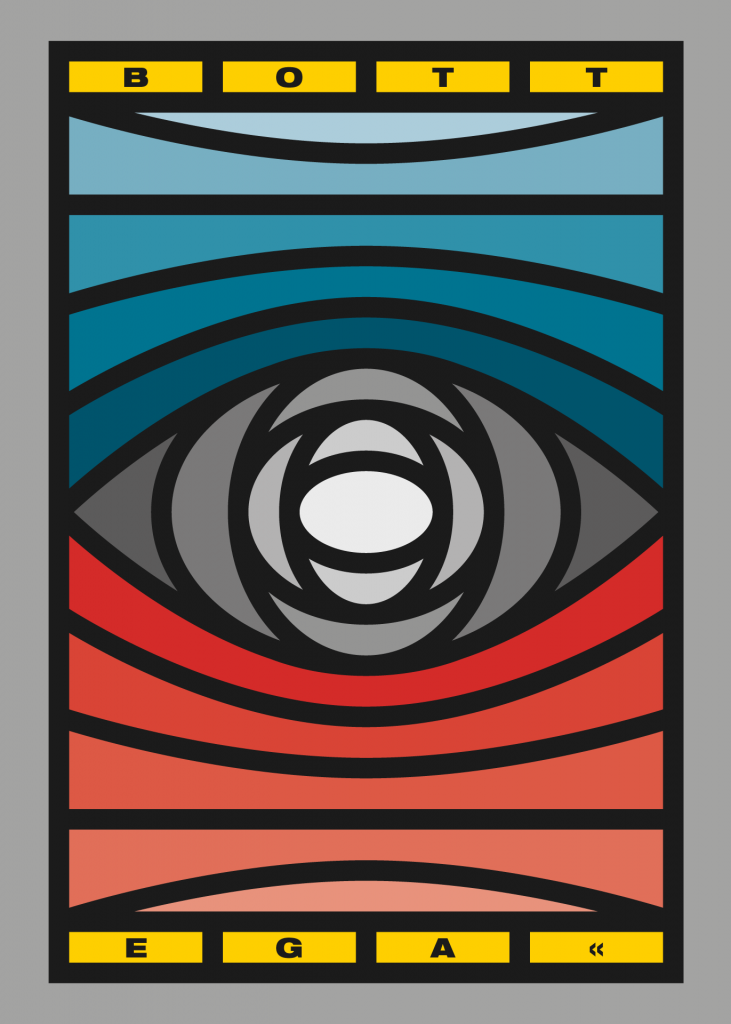
Bottega.
Sono stato fortunato, le mie giornate di bambino felice le ho trascorse in una bottega artigiana, con mio padre e zii, e altri. La bottega è un luogo sperimentale, un esperimento con le pareti attorno, in cui si fa parlando e si parla facendo. Ci sono strumenti, tecniche, conoscenze tacite e quelle che si mostrano, maestri e apprendisti. Le opere del lavoro sono frutto di collaborazione, tra un problema risolto e uno individuato; non esistono autori, solo processi impersonali. La bottega che spiazza la modernità capitalistica ai suoi albori, suggerisce Toni Negri, è quella di Spinoza e Jelles, che molano le lenti, di Schuller e Meyer che sono medici, del mercante De Vries e del birraio Bresser: demiourgoi della «democrazia assoluta». La bottega contemporanea è il «bazar» in cui si costruisce, in modo cooperativo e orizzontale, il codice di Linux.
Nella sua originale versione di Aristotele, Hannah Arendt invece chiarisce che dove vi è lavoro, non vi è opera, dove vi è opera, non vi è politica; solo quest’ultima, che pretende uno spazio pubblico, rende possibile l’esposizione di sé, della singolarità di ciascuna/o. Senza intreccio delle relazioni, senza parola, non vi è agire di concerto; senza agire di concerto, non vi è politica.
Chi agisce politicamente somiglia all’artista esecutore, la sua è un’attività senza opera, il cui fine è nella stessa esecuzione. Arendt aveva torto. Vi è prassi perché salta in aria la distinzione tra parola e tecnica, lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra assemblea e riproduzione della vita. Se è vero che il capitalismo cognitivo, le tecnologie informatiche, hanno già da quattro decenni fatto evaporare le rigide distinzioni di Aristotele e Arendt, non sono di certo venuti meno lo sfruttamento, la riduzione specialistica delle competenze e delle mansioni, la durezza del comando.
Combattere questo nuovo tipo di sfruttamento, però, non vuol dire riscoprire le virtù della politica nella sua bella e disarmata autonomia, nella sua purezza. Significa invece che la battaglia per avere più salario, lavorando meno, per un reddito d’esistenza, per un welfare universale (di cui, bene ricordarsi, ne rimane assai meno anche in Europa, mentre è quasi uno sconosciuto in vaste parti del mondo), deve da subito inventare istituzioni indipendenti. Invenzione artigianale, e non squisitamente artistica: nessuna creazione ex nihilo, ma uso e combinazioni inediti di materiali, tecniche, parole e affetti già esistenti.
Convertire gli spazi occupati e autogestiti in sindacati sociali e libere università, fondare imprese culturali e casse di mutuo soccorso, ambulatori medici e comunità di programmatori informatici, ripensare il diritto alla città e all’abitare: esempi tra gli altri.

Possessione.
Ci sono due modi di intendere il distacco dalla nostra essenza o natura. Nel primo caso, la natura umana è l’insieme delle facoltà della specie, presenti in ciascun individuo della stessa. Nel secondo, la natura sta in superficie o viene da fuori. In superficie: sentire il proprio corpo toccando il mondo, toccando se stessi; le immagini sono in primo luogo tracce somatiche e psichiche. Da fuori: le parole e il pensiero sono in primo luogo esteriori, non hanno proprietari, sono da sempre già lì, nella relazione – che è di volta in volta, e sempre, storicamente determinata.
Della lingua e del pensiero dobbiamo ogni volta appropriarci, ma è altrettanto vero che, innanzi tutto, siamo parlati e pensati, le parole con le quali discriminiamo la massa amorfa del pensiero non sono le nostre. È noto come queste ultime affermazioni averroiste facessero disperare Tommaso, detto d’Aquino ma nato a Roccasecca; annullando «i principi della filosofia morale».
Secondo il Commentator per eccellenza, Averroè, l’intelletto tutto, quello possibile come l’agente, è unico per l’intera specie, impersonale ed eterno. Ciò significa, nella critica di Tommaso, che pure la volontà viene da fuori al pari dell’intelletto, e in tal modo l’essere umano «non sarà [mai del tutto] padrone dei propri atti, e nessuno dei suoi atti sarà lodevole o biasimevole». L’intelletto possibile, in particolare, è un medio, un mezzo o elemento, nel quale i fantasmi del singolo vengono pensati dall’intelletto agente.
E ovviamente non vi è fantasma, frutto dell’immaginazione, senza sensazione. Esteriorità degli incontri, esteriorità del pensiero. Come nessuno, Franz Kafka ha colto che l’artista è un posseduto, il massimo della sua libertà consiste nel non poter vivere diversamente da come vive: Josefine, il trapezista, il digiunatore. Proviamo, con Averroè, ad andare più a fondo: solo nella possessione, una vita è degna di essere vissuta. Facendo esperienza dell’intelletto comune e impersonale, così ci insegna Spinoza, sperimentiamo la nostra eternità.
Autonomia.
Sembrerebbe allora che solo l’eteronomia, la determinazione e la dipendenza, ci rendano liberi. Ma libertà e autonomia, non sono sempre stati sinonimi? Sì, nel mondo dell’individuo sovrano, proprietario. No, se l’ontologia è relazionale, ovvero se vengono prima le relazione e poi gli individui individuati. Affermare, come fa Spinoza, che le relazioni vengono prima, significa anche asserire che le passioni e l’impotenza qualificano la nostra condizione, fin dalla nascita. Non nasciamo liberi, possiamo o meno liberarci. Così come non nasciamo civili, ma lo possiamo divenire istituendo la città e le sue regole.
L’autonomia, in questo senso, non ha nulla a che fare con la libertà degli individui, per la quale basta avere denaro, potere, armi. Si tratta di un’altra libertà, intesa come rapporto di forze, combattimento, invenzione democratica. Nella trama delle relazioni e delle passioni, singolare è il desiderio che ci fa e che facciamo, potenza connettiva e produttiva al contempo. Ma non esiste potenza pura, il desiderio è una frontiera, un rapporto differenziale tra attività e passività, vita e morte, gioia e tristezza, amore e odio, gratitudine e invidia.
Ci vuole una vita, per imparare la regola del desiderio, per conquistare l’autonomia. Le nozioni comuni, di cui Spinoza ci parla, sono regole del desiderio, forme di vita, linee di condotta, collettivi modi di esistenza che favoriscono gli incontri gioiosi, fondano e consolidano le istituzioni, combattono la malattia e la malinconia. Il desiderio, come l’intelletto, è comune e singolare al contempo, nesso di una relazione e differenza nella relazione. Per questo non esiste autonomia senza libertà comune, non vi è singolarità senza possessione.
Cornelius Castoriadis propone di pensare il rapporto tra la singolarità e il sociale, la storicità, in termini di «inerenza». Solo il narcisista assoluto, nel suo delirio funzionale, ritiene che questo rapporto, nel mezzo del quale la libertà diventa possibile, sia una condizione negativa, da sconfiggere attraverso potere e denaro.
Viviamo sempre nell’istituzione, nella storia; non siamo mai nudi, ma sempre carichi di determinazioni. Il desiderio, come principio di indeterminazione, coincide con la prassi istituente. È una questione di gruppi, di collettivi, di assemblee, di rivolte, di soviet. Autonomia, allora, è alternativa radicale alla catastrofe capitalista; la disunione, da ripetere ancora, che salva.
Il testo è un esperimento, ovvero la composizione delle parole di Francesco Raparelli e delle illustrazioni originali di Vittorio Giannitelli.
