approfondimenti
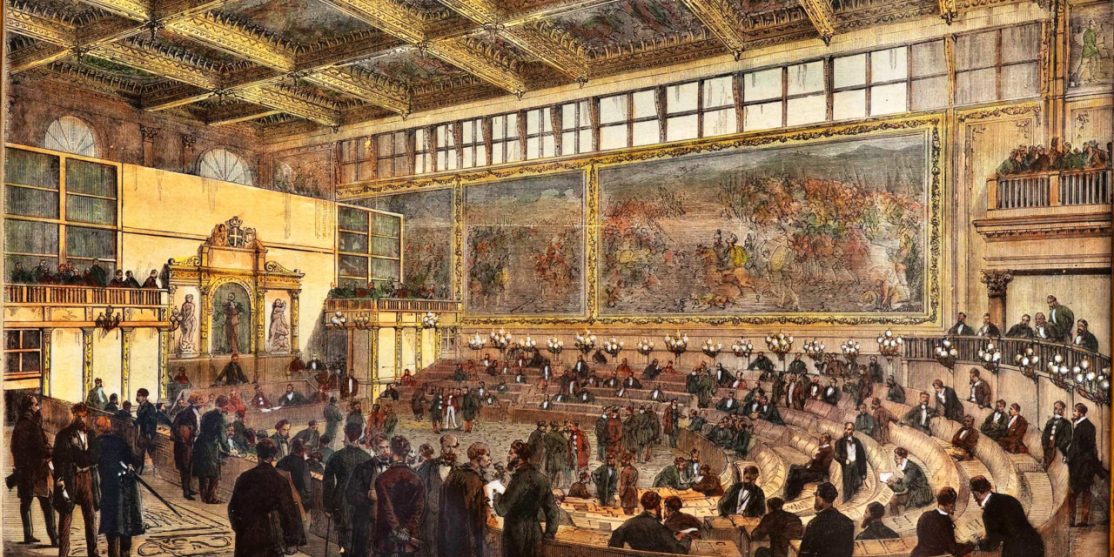
OPINIONI
Rapporto di minoranza (a un partito immaginario)
Come ricompattare una sinistra che sembra ormai sfilacciata e disorientata nel presente? Pubblichiamo un ampio contributo nella speranza di aprire un dibattito sul tema, che attraversa le questioni dell’ecologia, dei diritti sul lavoro, della teoria dei partiti e, in generale, di cosa significa agire da “minoranza” oggi
In assenza di un partito, in assenza cioè di una formazione soggettiva storica organizzata in forma adeguata per il presente, verrebbe difficile scrivere le note che seguono. Ma il condizionale è sbagliato, siamo all’indicativo presente. Si deve quindi tacere? Come dire, il mondo è tutto ciò che accade, e ciò di cui non si può parlare, per assenza dall’ordine degli eventi, si deve tacere? Oppure si può usare l’immaginazione, come uno scarto, un clinamen nell’ordine naturale delle cose, e figurarsi qualcosa che non c’è, cui destinare finzionalmente e funzionalmente queste note?
Scrivo e dunque scelgo la seconda strada. E siccome l’immaginazione fa sponda con la libertà, non mi riferirò a un ambito soggettivo definito, localizzabile e perimetrato, ma muoverò la critica a una costellazione di teorie, pratiche, atteggiamenti e forme della sensibilità diffuse e trasversali, non ascrivibili a un milieu determinato. Mi prendo le mie libertà nel dilatare i confini del partito immaginario, seguendo le piste dei vizi, a personale e modesto avviso, più nocivi che accadono a quella forma della sensibilità politica cui attribuiamo collocazione a sinistra, con una predilezione, per dato biografico, a quella “di movimento”, senza però dimenticarci quella più riformista, anche se, oddio, qui è proprio sparare sulla croce rossa.
Il rapporto è di minoranza, e il perché è di evidenza palmare: non vi sono esposte opinioni correnti, analisi di moda, o quant’altro è possibile riscontrare come diffuso, condiviso e maggioritario nel nostro partito immaginario. Va da sé, la ricerca di originalità e il taglio di minoranza farà più di un torto alla verità e alla ragione, e di questo sono consapevole: ma non si tratta di far bandiera di una mossa critica, di scoprire un nuovo paradigma del politico e costruirne l’edificio, o di una postura identitaria.
Si tratta di smuovere le acque intorbidite.

Contro l’egemonia dell’anima bella
In pieno romanticismo, quando la maggior parte degli autori tesseva l’elogio dell’anima bella, quella tutta tesa alla ricerca dell’assoluto, laddove vedeva far sintesi degli universali del bene e del bello, il vecchio Hegel intonava un controcanto di stridente potenza. Per lui l’anima bella tanto bella non era: seguendo la legge morale solo sotto l’aspetto di universale, e perseguendo un ideale di purezza di sé, l’anima bella si ritaglia il ruolo della coscienza giudicante, rifuggendo dall’azione.
L’anima bella è quella forma della sensibilità umana che vede come sommo bene la certezza di sé, della propria coscienza morale, e non riesce a esteriorizzarsi, vale a dire a trovare la forma di mediazione con la singolarità, la situazione, la realtà che nella concezione hegeliana produce la sintesi dell’in sé e del per sé, tra legge morale e inclinazione individuale: solo la determinazione dell’azione realizza l’unità spirituale, mentre l’anima bella «si strugge in consuzione nostalgica» per la propria incapacità di riconciliazione con una presenza reale, efficace, concreta, nel mondo.
Non occorre essere hegeliani, e seguire Herr Professor in profondità negli arcani della fenomenologia dello spirito per comprendere l’attualità della sua critica. Si può, un po’ come ladri nella notte, prendere a prestito questo flash filosofico e riportarlo al nostro presente.
Non so dire se quella dell’anima bella sia more geometrico la cifra della sensibilità prevalente, della disposizione morale egemone nella sinistra oggi. Non so cioè dimostrarlo, è una di quelle cose tipo il tempo e il linguaggio, se nessuno me lo chiede, lo so, se qualcuno mi chiede di spiegarlo invece no. E però è una sorta di ritornello, sinistra e anima bella, che suona bene insieme. Suona bene, certo, come capacità descrittiva, perché certo è che dal nostro punto di vista è con estremo fastidio che registriamo come sinistra e anima bella suonino bene assieme.
Perché una cosa è certa: a un certo punto la sinistra, quella rivoluzionaria, quella sociale, quella riformista radicale e anche quella di governo, ha perso mordente con la realtà, e non è più riuscita a comprendere come si agisce. Non che non ci sia più l’azione collettiva, o che non sia possibile registrare segnali di speranza in alcuni spezzoni di movimento, non fraintendetemi.
Usciti dalle temperie novecentesche, che tutto sommato garantivano quadro e cornice di senso, identità, presenza e razionalità anche nelle più scomposte e improbabili frange dell’universo variegato della sinistra big tent, si è entrati nel tempo fuor di sesto del neoliberismo e del postmoderno, dove finiscono le utopie e dove la lotta di classe perdura dopo la fine della lotta di classe, orfana del senso della possibilità, e riformista e rivoluzionaria. È in questo tempo senza utopia che si afferma l’egemonia dell’anima bella. È un’egemonia della sensibilità, non di un pensiero politico coerente, ma di una disposizione d’animo.
Come se la percezione della chiusura del possibile come progetto e come utopia tagliasse il momento dell’azione, non in quanto tale, non è che si smette di agire, ma come azione misurata, ben ponderata, che si pensa con il requisito dell’efficacia.
Come se si agisse in forma narcisista, estendendo un rispecchiamento del sé nella mediazione (insussistente) con il reale- ricercando di fatto la conferma consolatoria della propria identità, costruita sempre più sotto l’aspetto dell’universalità di un politicamente corretto che taglia i ponti col mondo, ritagliandosi un sottomondo competitivo dove si scontrano i reparti mobili della purezza delle coscienze giudicanti.
Il vecchio detto per cui c’è sempre uno più puro che ti epura acquista oggi un nuovo aspetto di verità, non più nella forma dello scontro di partito o di fazione politica, ma nel mercato culturale delle coscienze giudicanti, tanto meno capaci di presenza effettuale nel mondo, tanto più capaci di ferocia critica, terribilmente intransigente perché terribilmente ineffettuale. Eppure, egemone.
Ma l’egemonia dell’anima bella non è un’egemonia classicamente intesa, capacità di offrire risorse agli alleati, capacità di deterrenza verso gli avversari: è piuttosto un flusso di sensibilità che occupa un vuoto, e muove deterrenza solo sul fronte alleato, mentre si estranea al resto. Così facendo, stringe la presa su un perimetro destinato così sempre più a restringersi, e internamente sempre più a confliggere – nella cattiva infinità della tensione alla purezza che l’anima bella manifesta, sempre meno comune, sempre più irriducibilmente molteplice.
L’egemonia dell’anima bella nel campo largo della sinistra si presenta allora come una realtà autoevidente, che non ha bisogno di giustificazioni: chiunque può vederla all’opera.
La sua fenomenologia attuale si presenta sotto due forme generali: l’una, quella in cui si manifesta come pura coscienza giudicante, e che esaurisce la sua presenza nel mondo con la parola, senza azione ( come se la parola fosse sempre performativa- non è così); l’altra, in cui l’anima bella agisce, ma non può che agire in maniera autocentrata, fedele alla legge morale solo universalmente, in ultima analisi fedele solo alla propria immagine di sé, nell’ineffettualità del narcisismo.
Esempi dell’una e dell’altra potrei farne a iosa, certamente. Ma altrettanto certamente non voglio che il concetto si fissi – non che non lo voglia mediare con la realtà, non fraintendetemi né cercate di fregarmi – in questa o quell’altra schiera. Lo voglio più rappresentare sotto forma di una sensibilità diffusa che tutti tocca, chi in pieno, chi in parte. E soprattutto non voglio che il concetto si fissi nei soggetti perché non si tratta di spezzare quest’egemonia facendo amico-nemico, ma, come spezzando un incanto di magia nera, recuperare a un’altra modalità di presenza politica nel mondo anche chi oggi vive sotto l’incanto ineffettuale dell’anima bella. Poi, se si tratterà di fare amico-nemico per necessità, nessun problema in materia.
Come ci si muove allora contro l’egemonia dell’anima bella?
Sarebbe un errore farlo ingaggiando una battaglia culturale, fatta di manovre e attacchi. Si tratterebbe non soltanto di scegliere un terreno dove la coscienza giudicante si trova a proprio agio, comoda nella dimensione astratta del discorso, ma anche di mancare a una visione profonda e strategica della faccenda. La cura è contenuta, in qualche modo nella diagnosi: l’anima bella occupa il vuoto di senso della sinistra post novecentesca, e di quel vuoto è il sintomo principale. E contro un sintomo non ci si accanisce. Occorre interrogare il vuoto, e occuparlo con un senso rinnovato della possibilità dell’azione sociale.
Occorre reimparare come si agisce.

Come si agisce, o dell’azione efficace
Nella nostra tradizione, la classe non è il contenuto della rappresentazione di un intelletto esterno – una minoranza agente, un partito – ma il soggetto storico che prende partito. Nella sua formazione è la formazione di una razionalità alternativa alla modernità, e la sua azione è la sintesi di intelletto e volontà generali. Classe e partito, almeno idealmente, coincidono: come sostanza e attributo.
Non che da questo discenda automaticamente come si agisce: si tratta di una situazione per così dire ideale che si presenta materialmente come processo, con tutti caratteri del caso, la mutevolezza, la contingenza, l’incompiutezza, e così via. Vai a vedere se nella storia del movimento operaio si è visto all’opera l’intelletto generale del proletariato: forse no, ma ogni tanto ci si è andati vicino.
Mettendo il naso fuori dalla nostra tradizione, nel campo più largo della sinistra, vero è che il primato della classe s’indebolisce fino a rovesciare il rapporto fra sostanza e attributo, ma vero è comunque che la classe segna il punto almeno come principio di realtà: non c’è azione politica senza riferimento sociale, tutto il resto, che pure esiste nell’album di famiglia, è gesto estetico, volontarismo, individualismo, opportunismo.
Viviamo una situazione paradossalmente opposta da quella descritta da Marx nel Manifesto, quando si afferma che il principio e l’intensità della lotta di classe rende sempre più chiara e distinta l’esistenza storica della classe lavoratrice: alla nostra epoca sembra essere assegnato il destino della dissoluzione della classe operaia, come se questa tendenza alla molecolarità senza comune fosse un processo incontrovertibile. Io penso che noi non dobbiamo pensare che l’attuale stato di scomposizione sia destinale. O meglio, dobbiamo e vogliamo agire come se non lo fosse, per rendere vera la controtendenza possibile.
Certo che quel che ho alluso è che senza classe non c’è azione politica possibile, altrettanto la proposizione si può correggere così: senza possibilità della classe non c’è azione politica possibile, cioè dotata di potenza – reale, concreta ed efficace. La correzione rischiara la faccenda così: l’azione scopre il proprio telos, e torna ad avere senso quando essa verte sulla formazione del legame di classe, o meglio quando essa coincide con la formazione del legame di classe. Non importa che la classe abbia già preso massa perché l’azione sia possibile, efficace e adeguata, basta la tensione.
Non si deve quindi pensare il processo di formazione di classe, e di converso la sua insussistenza nella scomposizione, come momento “sociale”, ergo pre-politico, o strutturale nello sviluppo, ergo “economicista”. Questi due modi di pensare quella comune del lavoro che è la classe segnano le attuali forme d’impasse dell’azione politica, e determinano quel vuoto dove domina a sinistra la coscienza giudicante dell’anima bella. Segnano cioè l’impossibilità di fondare l’azione politica in assenza di un corpo sociale già strutturato o di uno sviluppo “progressista” delle forze produttive, e rimangono imprigionate lì, come mosche in bottiglia.
Certamente, i comportamenti, la vita quotidiana, le mentalità e gli atteggiamenti segnano il modo in cui la classe va formandosi, come momento, e altrettanto certamente le dinamiche di sviluppo delle forze produttive, tecnologia e rapporti economici sono l’alveo in cui scorre il fiume di questa formazione. Ma questa non si darebbe senza l’elemento politico, che è fatto da quelle attività secondo virtù, per dirla con Aristotele, che sono le lotte, la solidarietà, le vertenze, il mutualismo, le resistenze, l’organizzazione, e la mitopoiesi.
Non sono atti puri questi, ma le attività in cui l’uno si divide in due, per usare da cattivo discepolo il lessico di metafisica politica del mio buon maestro. Significa che nelle resistenze l’ordine delle cose viene sottoposto a un’apertura di possibilità, non c’è più un solo presente e i suoi futuri corrispondenti, ma c’è n’è un altro, radicalmente differente, che contende al tempo storico un modo alternativo e comune di produrre, appropriarsi delle risorse e di distribuirle. Un altro tempo, e un altro corpo, naturalmente, e questo due che si è diviso dall’uno è la classe lavoratrice, costituita nei suoi aspetti sociali, strutturali e politici.
Insomma, come si agisce e che cosa sia un’azione efficace bisogna proprio riscoprirlo: quello che propongo è che per farlo occorre prendersi cura dei processi di formazione della classe a venire, e che l’urgenza e il telos dell’azione sia prevalentemente qui.

L’arte della guerra e l’accumulo di forze
La prima è che la tesi di Horkheimer sull’eclissi della ragione va tenuta in debito conto. In breve e tagliando con l’accetta, il francofortese avverte che la ragione soggettiva, quella che non s’interroga sul fine, e riduce l’azione in un rapporto tra mezzi e fini, ha preso dominio della modernità. E senza capacità di fondare il fine, la ragione perde via via senso e si eclissa nella tecnica, cessando infine di poter conseguire l’obbiettivo di autoconservazione che la muoveva. La solidarietà sociale è quella forma dell’azione razionale che può far riscoprire una razionalità oggettiva, capace di fondare il fine, a partire dall’esigenza di garantire l’autoconservazione sovraindividuale.
L’avvertenza di Horkheimer è puntuale per noi, ci dice attenzione a non ridurre il problema dell’azione a un rapporto tra fini e mezzi, perché si finisce ad aver a che fare solo con puri mezzi: la tecnica, intrisa di razionalità strumentale promette potenza ed efficacia, senza poterle realmente conseguire. L’azione efficace sta altrove, e sta a noi fondarla con una rinnovata razionalità del comune.
La seconda è contenuta nel Trattato dell’efficacia del Jullien, il quale confronta la teoria dell’azione occidentale con quella cinese, attraverso i rispettivi trattati dell’arte della guerra.
Nella tradizione occidentale l’efficacia viene definita come la capacità di trovare il mezzo più economico, più rapido, più produttivo per perseguire uno scopo. Per questo occorre sviluppare attraverso l’immaginazione una forma ideale dello stato di cose che si desidera ottenere attraverso l’azione, che rappresenta l’obbiettivo e costituisce il modello cui attenersi.
Per i cinesi non c’è obiettivo né modello. Come dice Sun Tzu: «Le truppe vittoriose sono quelle che accettano il combattimento solo quando hanno già vinto; le truppe vinte sono quelle che cercano la vittoria soltanto nel combattimento».
Lo stratega cinese si muove nel flusso dell’immanenza, in una situazione contingente e mutevole che non va forzata, quanto piuttosto valutata attentamente momento per momento, alla ricerca della propensione degli eventi e di quanto questa possa essere o meno favorevole al proprio esercito. L’arte della guerra cinese si muove dentro la valutazione della contingenza, evitando o procedendo al conflitto a seconda di quanto la propensione sia o meno favorevole. L’azione consiste allora, oltre a muovere battaglia a tempo debito, a rafforzare e catalizzare tutti gli elementi che nel frattempo possono concorrere a volgere al meglio la propensione, e di contrastare e minimizzare quelli sfavorevoli. Scienza delle condizioni che muovono nella contingenza è l’arte dello stratega cinese, e l’efficacia dell’azione risiede nella lettura corretta degli eventi e nello scandire l’accrescimento della propria potenza alternando conseguentemente le proprie azioni di attacco e ritirata.
Certo, non si tratta di lasciare Machiavelli per Sun Tzu. Si può però imparare più di qualche cosa in termini di efficacia, quanto meno sulla lezione di arte della guerra relativa all’accumulo delle forze che è possibile ottenere muovendosi opportunamente e virtuosamente nella contingenza. È una lunga marcia molto probabilmente quella che abbiamo da fare, per la quale non possediamo ancora un’arte della guerra.
Incominciamo, almeno, a pensarci.
Il metodo della controtendenza
La tendenza fa tendenza, come a dire va di moda ed è argomento di buona conversazione. Certo, individuare gli elementi più vivi e dotati di potenza nel presente e per ciò capaci di segnare il futuro è sicuramente un esercizio importante, anche politicamente fruttuoso a certe condizioni. Può essere però anche un pericolo, o un ragionare ozioso, a certe altre. È un oggetto strano, la tendenza, da maneggiarsi con estrema cura, non fosse altro perché è un asserto sul futuro che vuole indirizzare il presente, ma noi non possiamo dire vero o falso mentre lo diciamo, e quindi il suo valore di verità lo possiamo vedere o che è nullo o che è un rischio. Oppure lo possiamo vedere in un terzo modo, cioè un asserto sul presente: identificando adesso quelle che ci sembrano le linee di forza dotate di maggior potenza per delineare il futuro, noi parliamo esclusivamente del presente. Credo che parlare di tendenza si possa fare in modo politicamente e analiticamente efficace solo in questo terzo modo. Negli altri due modi o si cazzeggia o si prende un rischio fondamentalmente inutile.
Poi, ci sono gli errori tipici. Succede che si dica”credo che andrà così”, e ci si comporta secondo tale credenza. Poi così non accade esattamente come da previsione e succede che si dica “ci sono stati dei problemi, ma comunque andrà così”: ci si trova a difendere la previsione, come se appartenesse alla nostra identità.
Ma questa, che doveva servire a spiegare i fatti, quando diventa attaccamento identitario milita contro i fatti stessi. Succede anche che la tendenza non sia oggetto di ragionamento previsionale, ma faccia parte di un atteggiamento, per così dire emozionale: si dà per quelli, e sono tanti, che scambiano i caratteri del tempo nuovo con quelli più vistosi e di superficie, e volendo giustamente appartenere al proprio tempo fino in fondo compiono l’errore di assumerlo senza critica e senza esercizio della ragione: lo si riscontra facilmente su chi a sinistra tesse l’elogio del tempo nuovo sul terreno della tecnica e della comunicazione.
Come si deve fare allora con la tendenza?

Innanzitutto direi che occorra definire il suo valore d’uso politico. E direi che serve due funzioni: una è quella di comprendere il modo di produzione capitalista sotto l’aspetto dinamico, di processo, l’altra è cogliere le mutazioni nella composizione di classe. La prima funzione coincide con il metodo di Marx, che è quello di identificare una serie di tendenze che, nella loro interazione sia solidale che contraddittoria, definiscono il capitale come processo. La comprensione del processo attraverso le tendenze che vi operano non va scambiata come una previsione futura, ma come una definizione del presente, a meno che qualcuno non pensi ancora che il punto politico della lettura del capitale stia nei suoi schemi di riproduzione, al fine di calcolare matematicamente il momento del crollo, o quantomeno i momenti acuti della contraddizione principale, tra sviluppo delle forze produttive e rapporti di produzione.
Soprattutto, quando si lavora a identificare la tendenza non bisogna dimenticare che questa opera dentro una serie di controtendenze, e non è che il rapporto che ne scaturisce è sempre quello di ritardare il pieno dispiegamento della tendenza. Potrebbe scaturirne un blocco disfunzionale, potrebbe emergere un’altra tendenza più potente capace di far prendere al futuro possibile una direzione inaspettata, potrebbe strutturarsi un ciclo di lotte capace di invertire i rapporti di forza attuali e mettere in difesa le tendenze di sviluppo del capitale per contrastare il protagonismo politico del lavoro. Quello che voglio dire è che non c’è necessità nella tendenza, e quello che potrebbe essere ci deve interessare solo fino a un certo punto, che è esattamente il punto dove comincia l’errore di scambiare il possibile con il necessario.
Poi, si tratta di assumere assieme all’identificazione della tendenza l’assieme delle controtendenze, cioè gli attriti, le resistenze e le permanenze non-contemporanee che si muovono in maniera opposta o non allineata alla tendenza, cercando di comprendere la retroazione di questo rapporto e la modificazione strutturale che viene a delinearsi.
Così come la verità della palla che rotola è che si ferma a un certo punto, perché sono vere sia la tendenza al moto perpetuo che la contingenza dell’attrito, allo stesso modo quello che ci interessa dal punto di vista dell’azione politica non è solo l’identificazione della tendenza, ma rilevare le controtendenze, e operare nel processo delle contraddizioni. Per questo il metodo della tendenza andrebbe chiamato in un altro modo, ossia metodo della controtendenza, per ricordarci di non incorrere in errore, che una volta rilevata la tendenza identificare attriti e contraddizioni è estremamente proficuo e rilevante, e che il valore d’uso di questa “doppia” identificazione sta nella comprensione della situazione presente in cui ci troviamo ad agire politicamente.
Per ciò che riguarda invece l’altro valore d’uso che avevamo richiamato, relativamente alle mutazioni della composizione di classe valgono queste avvertenze. La prima è che il quadro dei rapporti produttivi, che è uno dei fattori rilevanti della composizione, segue sempre con un certo ritardo i passaggi d’innovazione, quindi occorre fare molta l’attenzione a non incorrere in errori meccanicistici. La seconda è che la valutazione politica sul terreno di tale ritardo deve giocarsi tutta nel rapporto tra tendenza e controtendenza, e gli aspetti strategici di tale valutazione devono essere liberi da vincoli d’innovazione- non è necessario dover essere dalla parte della tendenza: non tanto perché non è detto che questa si realizzi, quanto perché l’efficacia politica potrebbe trovarsi, con maggiore probabilità, nello spazio delle contraddizioni.
Si capisce meglio quest’ultima cosa con un piccolo esempio. Prendiamo una classica tendenza marxiana, quella all’aumento della composizione organica, aumento del capitale fisso in rapporto al capitale variabile: sempre più macchine, sempre meno lavoratori, semplificando brutalmente. Questa tendenza di sfondo, presa così com’è, senza l’attrito della storia, ha comportato molti tentativi di fondare una soggettivazione potenzialmente comunista al di là e senza il lavoro. Vuoi la comunicazione libera da dominio, vuoi lo scambio linguistico senz’opera, vuoi l’essere governati e soggetti a comando, vuoi il vivente senz’altra determinazione, e vuoi tante altre cose.
Come se lo scemare del protagonismo politico del proletariato di fabbrica dovesse coincidere con la fine del ruolo politico del lavoro in generale.
Certo, gli economisti avvertono sempre che l’andamento tra innovazione tecnologica e domanda reale di lavoro è ciclico, e laddove si distrugge lavoro necessario poi se ne crea di altro, ma viene sempre il dubbio che il saldo reale sia sempre favorevole al momento distruttivo.
E siccome il dubbio non scava come una vecchia talpa, ma come un tarlo nella mia testa di legno, alla fine della fiera io proporrei al nostro partito immaginario che si presentino due mozioni al vaglio dell’assemblea.
Una che abbracci la tendenza all’aumento della composizione organica fino in fondo, ivi compresa la fine del protagonismo politico del lavoro, della sua contraddizione con il capitale come contraddizione non più principale, ma subordinata, e la fondazione di un’altra ontologia del soggetto fuori dal lavoro.
Un’altra che abbracci la controtendenza all’incremento della composizione organica, per riaffermare il protagonismo politico del lavoro e il primato della sua contraddizione antagonistica al capitale, magari puntando come base materiale di tale controtendenza sul lavoro necessario che può crescere sul terreno della salute, e della cosiddetta transizione ecologica, che non sarà magari né transizione né troppo ecologica, ma può basarsi, così come la salute, su di un’alta intensità di lavoro.
Io firmerei la mozione lavorista, s’intende.
Intermezzo
L’elemento marino: l’effetto generale della vulnerabilità nella crisi economica e nella sua cesura pandemica
Partiamo da una cosa libresca. Hans Blumenberg, in Naufragio con spettatore, ci fa ragionare su un classico luogo lucreziano-lo spettatore che guarda un naufragio dall’alto della scogliera. Sostiene Lucrezio che non c’è nulla di più rassicurante che contemplare le sicurezze altrui che-letteralmente-affondano. Non si tratta di un perverso godimento per l’altrui disgrazia, quello che i tedeschi chiamano Schadenfreude, ma la sensazione di sicurezza e stabilità che può essere assicurata, secondo l’epicureismo di Lucrezio, da un distaccamento tendenziale dalle cose mondane, che fa coincidere la posizione del saggio con quella dello spettatore.
Blumenberg ci conduce in un viaggio attraverso la storia della metafora della navigazione, cui il naufragio s’attaglia come punto limite di rappresentazione del rischio implicito dell’andar per mare, e che assume il senso di “stare per” gli atteggiamenti di sfondo che formano l’esistenza umana. Questa storia è anche la storia dello spettatore: all’atteggiamento aperto al rischio e alla scoperta, quello di chi va per mare, fa da contraltare quello di chi cerca nella vita incessantemente di porsi a distanza di sicurezza dal pericolo, cercando la propria posizione sulle “scogliere” della vita. E se l’orientamento prevalente è stato fino a un certo punto quello lucreziano, refrattario al pieno coinvolgimento, è nell’ambito della rivoluzione copernicana che l’atteggiamento prevalente cambia campo, e s’inizia a prediligere l’opzione del mare: lo fa Pascal, quando ci dice che vous étes embarqué, per dirci, parole di Bodei, «che bisogna riconoscere la precarietà, l’elemento marino, come il nostro ambiente naturale».
Per Pascal, «noi vaghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all’altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci vacilla e ci lascia; e, se lo seguiamo, ci si sottrae, scorre via e fugge in un’eterna fuga. Nulla si ferma per noi. È questo lo stato che ci è naturale e che, tuttavia, è più contrario alle nostre inclinazioni.
Noi bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile e un’ultima base sicura per edificare una torre che s’innalzi all’infinito; ma ogni nostro fondamento scricchiola e la terra si apre sino agli abissi».
Questa costellazione di metafore è assolutamente puntuale per cogliere alcuni aspetti di sfondo dell’attuale situazione storica, dalla crisi del capitalismo globale alle condizioni odierne della composizione di classe. A patto poi, come ogni buon espediente narrativo, di liberarcene a un certo punto del percorso: a tenerlo stretto si rischia di prendere una corrente metafisica, o di annegare per evitarla. Ma, ben prima di liberarcene, leggiamolo nel presente.

Siamo tutti imbarcati: la crisi economica assieme alla sua cesura pandemica ha spazzato via l’illusione epicurea di poter occupare posizioni a distanza di sicurezza dalle correnti marittime del capitalismo neoliberista, soprattutto per quelle figure sociali che “bruciano dal desiderio” dell’assetto stabile: la classe media, porzioni di classe operaia tradizionale, e l’individualismo proprietario, spesso cognitario, teso sempre a ricercare la “soluzione biografica alle contraddizioni sistemiche”. Così, chi ha sempre abitato l’elemento marino, come da tradizione degli oppressi, può incontrare ora nei flutti tanti abitanti delle scogliere.
Ci sono marosi e tempeste all’orizzonte: occorre costruire le zattere, magari ricombinando il legname alla deriva, frutto di precedenti naufragi. A patto di riconoscere tutti la precarietà come condizione comune, di accettare le regole dell’elemento marino.
Accade però che il bruciante desiderio dell’assetto stabile blocchi tale riconoscimento, e che l’impulso a cercar posizioni a distanza di sicurezza, per quanto vano, sia ancora all’opera. Lo vediamo in quegli atteggiamenti che di fronte all’urgenza pratica si ritagliano il lavoro dello spettatore, lo vediamo negli occhi di quelli che, appena toccata l’acqua, pensano subito alla riva, piuttosto che a nuotare.
Naufragi
Raccontiamo di due naufragi, tra quelli che ci accadono : il primo è quello della stabilità del lavoro, il secondo è quello della società della conoscenza.
La prima barca, che ha iniziato a imbarcare acqua da tempo, si reggeva date alcune condizioni. La prima è che vi fosse un rapporto equilibrato tra insediamento produttivo, e vita lavorativa. Poggiava la condizione sul fatto che la tua vita lavorativa fosse minore o eguale alla vita dell’azienda presso cui prestavi opera. A sua volta, tale condizione poggiava sui cicli d’ammortamento del macchinario e dell’insediamento, e in generale su cicli d’accumulazione lunghi abbastanza da poter fare del luogo della produzione un punto convenzionalmente fermo. È il tempo, e la sua accelerazione, ad aver ammazzato la stabilità dello spazio, e con essa la stabilità del lavoro.
La seconda è la concezione dello sviluppo capitalistico secondo la quale sono coincidenti l’interesse capitalistico con la massima diffusione delle conoscenze. Qui bisogna sgombrare il campo da ambiguità e fraintendimenti.
Primo: non è che il capitalismo smette di essere cognitivo se vengono meno le illusioni che hanno accompagnato l’apprendistato della messa al lavoro in massa di saperi, relazioni e linguaggi. L’idea di una società della conoscenza capace di liberarsi in tendenza del lavoro manuale e operaio, interessata a produrre come infrastruttura della propria capacità produttiva la massima diffusione dei saperi, e un ambiente metropolitano, giovane, brillante e tollerante è la forma ideologica in cui si è data l’utopia del capitalismo cognitivo. Il bagno di realtà l’ha fatto fare la crisi economica. O meglio, la stratificazione delle crisi che continuamente attraversiamo.
Secondo, capitalismo cognitivo non significa che tutto il lavoro è cognitivo. A rigore, neanche che la quota principale del lavoro sia cognitiva. Significa che il lavoro si ristruttura sull’asse cognitivo andando oltre la funzione di sorveglianza del processo cui il lavoro operaio è tendenzialmente destinato dato un certo grado di sviluppo della composizione organica del capitale.
Sfruttare il lavoro cognitivo non significa avere a cuore la massima diffusione delle conoscenze nel corpo sociale. Che sia mente o che sia mano, l’importante è il valore d’uso per il capitalista nel processo di valorizzazione. La retorica padronale contro il lavoro immateriale rimanda invece a un altro paio di cosette: la prima è la forma ideologica in cui si esprime, nella contingenza strutturale della crisi economica, il blocco dell’innovazione; la seconda, è l’istinto di classe che fiuta il pericolo per l’ordine costituito derivante da un blocco sociale organizzato dell’intellettualità di massa frustrata dal mancato sbocco dei propri saperi.

La fine del compromesso postfordista
In ultima analisi, lo smarrimento che si vive a sinistra muove a partire dal valore perduto del lavoro: è una forma di smarrimento che non ha a che fare tanto con la misura, quanto con lo shock da aspettativa mancata rispetto a quella cosa che entra nel processo di produzione per costituirne la fonte del valore, e che oggi ne esce avvinghiata a una spirale di svalorizzazione. Da una parte, questa spirale è quella dei rapporti di forza, che avviluppa salari e condizioni, trascinandoli verso il basso, dall’altra, la spirale insegue il divenire rendita dell’impresa capitalista, verso l’alto, e nella vertigine degli scambi finanziari scopre una nuova fonte di valorizzazione che permette, per un attimo, l’oblio, e strutturalmente una nuova subordinazione, di quella “primaria”.
Questa rinnovata capacità di comando sul lavoro elimina di fatto quella forma “pattizia” che ha gestito il passaggio postfordista, basata sul doppio binario del mercato del lavoro: una conservazione delle forme di diritto del lavoro, e un rallentamento dell’erosione delle conquiste operaie, per i lavoratori della media e grande industria, e una sostanziale deregolamentazione e precarizzazione nel lavoro in entrata, e per l’impresa a rete, fatta di piccole realtà e subappalti. La fine del compromesso postfordista avviene fondamentalmente per due fattori. Il primo viene alla luce dentro il permanere della crisi economica, e appare in negativo nell’assenza di una exit strategy fondata sull’innovazione capitalista – è l’istinto padronale per il plusvalore, che sia assoluto se non può essere relativo: va quindi rotto il patto sulla componente “garantita” del mercato del lavoro (usiamo le virgolette perché la garanzia qui verte solamente sulla conservazione formale dei diritti, e sull’erosione controllata del potere d’acquisto dei salari) affinché possa approfondirsi lo sfruttamento.
Il secondo è un riflesso diretto dell’incapacità delle forme pattizie di conservare nel tempo la risultante del rapporto di forze che ha dato vita al compromesso stesso.
Il mancato rinnovo dei rapporti di forza, implicito nel meccanismo della concertazione, che assume sempre virtualmente il conflitto, e funziona se lo evita, determina una situazione fra le parti tale per cui chi assume l’iniziativa- mettere in crisi il patto, rivederlo, renderlo inapplicabile nei fatti- guadagna forza nel rapporto, finché tale forza non arriva al punto critico di aver la capacità, per una parte, di poter rompere il compromesso, e magari imporne un altro.
Se c’è una lezione più importante di altre da trarre dallo sciagurato accordo del ’93 e dal meccanismo della concertazione nelle relazioni di classe, sta nel fatto per cui il conflitto non cessa se la sua rappresentazione fantasmatica viene istituzionalizzata dentro camere di compensazione preventive. Piuttosto è la rinuncia al suo esercizio concreto a funzionare, progressivamente, come fattore di indebolimento, fino a essere costretto a diventare elemento di conservazione, come attaccamento al momento originario della risultante delle forze che hanno formato il patto.
Fine del compromesso postfordista non significa l’immediata cessazione del doppio binario del mercato del lavoro; significa piuttosto che tale rappresentazione binaria cessa di avere senso nella sua capacità descrittiva: soprattutto significa la rimozione di un blocco che apre alla possibilità di una ricomposizione di classe.
Questa rimozione di blocco, e quest’apertura di possibilità si dà però in forma paradossale: si universalizza la vulnerabilità dentro forme molteplici di inquadramento che riproducono in maniera diffusa una gerarchia nei luoghi di lavoro. E quindi si deve dire che ciò che attraversa i fili dispersi della classe assomiglia più a una rivoluzione passiva piuttosto che a una combinazione attiva delle forze.
Non c’è dubbio alcuno che la vulnerabilità per tutti non sia né opportuna, né auspicabile e che tale situazione sia un prodotto di una sconfitta di lungo periodo della classe operaia, e che tale sconfitta abbia conosciuto al tempo di questa crisi occasione di accelerazione e approfondimento.
Ma al vocabolario della sconfitta s’aggrappa chi non ha la capacità di tramutare la situazione avversa in occasione propizia – se si vuole, oggi la potenza di tale trasmutazione sta nell’ordine della sincronia, nella capacità di valutare e agire nella situazione concreta mobilitando la propria forza in avanti – da quella posizione che si interroga su come si rovescia la debolezza in forza. Girare le spalle al futuro è ricercare quella posizione della scogliera, dove il lavoro delle conquiste passate è ormai lavoro morto – ordine diacronico di una sconfitta che non è più possibile tramutare in vittoria come tale.
Occorre un radicale mutamento di prospettiva, ci costringe a farlo un passaggio di naufragio nell’elemento marino.

Organizzazione politica nelle macerie del presente
Cinque tesi, a mo’ di riassunto, tanto per iniziare:
1
La sinistra nella sua doppia accezione, riformista e rivoluzionaria, di partito e di movimento ha perso mordente sulla realtà. Si è rifugiata in una comfort zone ben descritta da Hegel con il concetto di anima bella, soggetto che si accorda alla legge morale solo dal punto di vista dell’universalità, ed è quindi incapace di agire nel mondo, rimanendo chiuso nella contemplazione di sé, inoperosa e in ultima analisi narcisista.
2
La perdita di mordente, di attrito, di possibilità dell’azione efficace è la perdita del senso di realtà, e l’abbandono del realismo politico come precondizione di pensabilità dell’azione. L’idealismo che contraddistingue oggi la sinistra è per giunta cieco e opportunista, orfano persino dell’utopia.
3
Realismo, concretezza, efficacia. La rinascita della sinistra passa per una diversa presenza nel tempo e nella società. L’incapacità di vivere le contraddizioni del proprio tempo forma un pensiero idealistico e subalterno, che perimetra sugli universali del riconoscimento delle minoranze la comfort zone della sinistra, schiacciando l’azione sui dettami vittimistici del politicamente corretto, rendendo così ancora più difficile l’opera di rammendo di un corpo sociale sempre più lacerato, atomizzato e schiacciato sulla passione narcisistica dell’individualismo proprietario. La questione del riconoscimento reciproco di diritti e dignità può vivere con realismo, concretezza ed efficacia solo su un terreno più ampio di giustizia sociale, dentro un’ecologia della mente collettiva capace di superare il doppio legame della vittima, bisognosa di riscatto e riconoscimento, ma come tale impossibilitata a non ottenerlo mai in maniera soddisfacente.
4
Realismo, concretezza ed efficacia hanno i propri temi. Alcuni, non altri.
Sono il lavoro, la sostenibilità e la solidarietà sociale. Questi temi e il modo realista di svilupparli sono comuni sia alla sensibilità riformista che a quella radicale e rivoluzionaria: entrambe hanno perso mordente, entrambe possono riprenderlo. Possono anche fare strada assieme, tanto indietro siamo rimasti. C’è molta strada da qui al 1921.
5
Altrimenti detto: il lavoro, la sostenibilità e la solidarietà sociale vivono politicamente solo attraverso la costruzione sociale di istanze realistiche, concrete e dotate di efficacia.
La casa brucia, e l’urgenza ci chiama alla determinazione del possibile: ogni scatto nel presente poi aprirà scenari di possibilità più ambiziosi e radicali, e sarà come prendersi cura dell’accrescimento della propria potenza.
Pensare un’organizzazione politica oggi significa attraversare un paesaggio di macerie. Sono le macerie delle forme organizzative che hanno segnato la storia recente e passata, e sono le macerie sociali dei legami sfilacciati e consunti sia dal dispositivo “individualizzante” proprio delle politiche neoliberiste, acuito dagli shock delle crisi che abbiamo attraversato, sia dall’incapacità politica a sinistra di costruire modelli organizzativi e forme nuove dell’azione sociale capaci di contrastare tale tendenza.
Qual è l’atteggiamento giusto, quello da tenere, attraversando il paesaggio delle macerie del politico? Certamente non l’anastilosi, ossia cercare di segnare pietra per pietra nel tentativo di ricostruire gli edifici crollati così com’erano, ma neanche la tabula rasa, attraversare le macerie pensando che nulla di ciò che intralcia il cammino ora possa avere funzione nel presente.
Certamente le macerie non devono essere d’ostacolo, e molto lo sono state finché come macerie le abbiamo potute finalmente riconoscere.
Meglio: voglio dire che con un cambiamento di sguardo le macerie cessano di esser tali e diventano elementi, parziali, per ricostruire. Un paesaggio di macerie è guardato come si guarda una cosa distrutta, ed è uno sguardo carico di memoria: così lo sguardo rimane contemplativo, e non offre presa possibile sul reale, rimanendo fermi tra la nostalgia e il carattere inutile e distruttivo delle macerie per il presente.
Occorre una metamorfosi dello sguardo. Una metamorfosi per cui le macerie cessino di esser tali, peso, ostacolo, o memoria obbligata a ripetersi – e divengano elementi di disponibilità. Questa disponibilità diviene effettiva se e solo se è ospitata all’interno di un paradigma rinnovato della politica capace di darsi delle forme organizzative adeguate al presente: voglio dire, se le macerie sono ricombinate assieme a elementi nuovi, o relativamente tali, la sintesi è felice, funziona, e crea la necessaria corrispondenza tra forme del passato e forme del presente.
Allora e solo allora una metamorfosi della politica e ai modi in cui le persone si mettono assieme per farla non sarà più attraversare macerie, ostacoli e altri elementi disfunzionali.
Bisognerà però qualificare leve, risorse e punti di attacco di questa metamorfosi di sguardo e di pratica.
Punti di attacco. Abbiamo detto che la politica e le sue forme organizzate conseguenti possono crescere attorno alle determinazioni del possibile, cioè laddove più intensa è l’azione sociale: sono allora le esperienze legate alla produzione e alla riproduzione sociale quelle su cui puntare. Ce ne sono già tante, ma la questione non è di federarle per dar loro unità e sintesi direzionale.
Si tratta di farsi la domanda precedente, cioè come se ne accresce ed estende la potenza alle condizioni date. Si tratta di approfondire la domanda sull’organizzazione politica, partendo dall’idea che sia l’azione sociale a creare le condizioni di questo approfondimento, non il contrario – sarebbe come un velo di maya teorico calato sulla realtà, una sovradeterminazione dell’astratto.
Risorse. Sono di due tipi, umane e saperi. Per i saperi politici vale il discorso che abbiamo fatto su macerie e organizzazione. Finita l’utopia, la lotta di classe, l’attualità del comunismo nelle forme che hanno segnato la nostra storia recente, rimane la lotta di classe come immanenza e continuità, e utopia e attualità del comunismo come esigenze e bisogni da reinstaurare sotto forme nuove, che devono essere forme del possibile. Finché si fa coazione a ripetere, le forme esaurite saranno d’ostacolo, approcciato il sentiero nuovo non più. Questo è un processo rigorosamente bottom up:
non bisogna cercare il discorso ricompositivo, la grande narrazione che magicamente risolve la situazione di blocco, ma agire con efficacia e determinazione nel tempo del naufragio. Il discorso e la grande narrazione verrà dopo, a tempo debito.
Quelle umane, di risorse, sono di tre tipi: militanti politici, persone orfane di militanza politica ( chi ha espresso o esprime disponibilità potenziale, ma non ha struttura per esprimerla- detti anche cani sciolti), classe. Qualunque discorso sull’organizzazione che consideri separatamente questi tre tipi incorre in errore. Genericamente: tipo uno ricombinazione dell’identico; tipo due fronte del rancore; tipo tre elogio dello spontaneismo, pericolosamente affine alla “legge del menga”. Bisogna quindi partire da un’articolazione nuova, che risponda all’esigenza di contemperare nel dispositivo un coinvolgimento, necessariamente differenziale, dei tre tipi suddetti.
Apertura dell’articolazione nuova: venir meno del settarismo, assunzione di una interrogazione aperta sul politico, primato dell’azione sociale, coinvolgimento articolato e differenziale ( non solo di militanza full time) su questo terreno.
Leve. Dove si fa leva? Una volta si diceva dove più chiara e intensa si dà la tendenza di sviluppo capitalistico, e poi, no, è un errore, si fa leva dove la classe è più forte. Ora, la situazione ci chiama a un ragionamento diverso. Che deve fare i conti con la debolezza e lo sfilacciamento del legame di classe. Compito principale è quello della ritessitura del legame sfilacciato, essere elementi capaci di favorire una dinamica espansiva nel processo di formazione di classe lavoratrice. Processo immanente, eppure sempre scomposto e interrotto. La leva sta allora oggi nell’intervenire laddove i processi di formazione di legame sociale di classe si danno più intensamente, nel favorire le condizioni per la loro creazione, e nel rimuovere gli ostacoli e contrastare le dinamiche del rancore e dell’individualizzazione, principali forme della scomposizione attuale.

Tre ipotesi di lavoro
All’inizio ho avanzato l’idea che l’azione dotata di concretezza realismo ed efficacia si debba concentrare sul lavoro, la sostenibilità e la coesione sociale. Dal momento in cui concluderò con qualche nota relativa ai tre ambiti oggetto di proposta, che sono la ricaduta possibile della presente, perché si scrive sempre con l’illusione che ciò che si scrive muova il mondo o si muova nel mondo, e guai a levare l’illusione, per quanto folle e improbabile che sia, anticipo che saranno note inevitabilmente spurie e parziali. Sia perché si parla di cose che già ci sono, e una revisione completa e leziosa sarebbe una imperdonabile mancanza di rispetto da parte del sottoscritto, sia perché, laddove si vada nell’ambito dell’inattuale, si parla di cose pratiche, e seppur il pensiero speranzoso le vuole piene di implicita raffinatezza di saperi astratti, le cose pratiche sono rigorosamente di ordine collettivo, e collettivamente vanno trattate.
Le tre ipotesi di lavoro politico non sono particolarmente nuove in sé,
sia il sindacalismo, che l’associazionismo ambientalista e il terzo settore sono largamente presenti a sinistra. L’elemento di differenza vorrebbe qui essere riconosciuto e rimarcato si presenta sotto l’aspetto delle funzioni organizzative e dell’aspetto politico.
La differenza in negativo si presenta come una tensione che cerchi di evitare sia il modello della cinghia di trasmissione, sia l’indipendenza depoliticizzata della vertenza, quel tratto largamente presente nei movimenti ambientalisti e nel terzo settore, che è in assonanza con una tendenza storicamente presente nel movimento sindacale, ossia quella del trade-unionism pure and simple: ovverosia né articolazioni di una razionalità politica esterna, né elementi di vertenzialità sociale indipendenti e limitati a se stessi.
La differenza in positivo si presenta come modo di rispondere all’esigenza fondamentale relativa alla questione d’azione politica qui espressa:
la ritessitura dei fili dispersi della classe.
E’ una questione di qualità, if you know what I mean.
Note brevi sul sindacato
La lotta di classe è un animale strano: sopravvive a se stessa, un po’ come quell’animale mitologico che prendeva il nome di araba fenice, capace di risorgere dalle proprie ceneri. Sopravvive a se stessa, perché c’è, sempre e in qualche modo, in forme vuoi nascoste vuoi difformi dai desiderata di chi indulge in letture troppo astratte dei testi sacri, c’è anche quando non si presenta nelle forme politiche dell’assalto al cielo e della trasformazione comunista dello stato di cose presenti. Per questo il lavoro sindacale è prezioso, perché tiene il punto sul fatto che il lavoro è la forma dell’esistenza sociale in cui la lotta di classe sopravvive alla sua fine, prezioso perché la riscopre, prezioso perché può alimentarla e darle un nuovo corso.
L’antica divisione tra lotta economica e lotta politica, per cui la prima doveva farsi ancella della seconda, semplicemente è saltata da tempo, e di questa divisione va scoperta una articolazione nuova, diversa, adeguata al tempo.
L’umile suggerimento che mi viene da fare è che questa scoperta può funzionare in un verso solo, è dalla lotta economica che può ripartire quella politica. Quando si riparte, si riparte dalla parzialità, dall’interesse immediato e dal terreno scabro, e mai dall’universale. Certo, nessuna assicurazione stipula garanzie sul passaggio dalla lotta economica alla lotta politica, ma si tratta di quei rischi che sono figli della necessità, e come tali vanno percorsi.
Ora, questo non significa che chi intraprende oggi un’azione di lotta economica debba far velo sulla propria tensione politica, che la debba dissimulare, o peggio, negare. Nella ricerca dell’articolazione adeguata al tempo occorrerà però dotarsi di strumenti nuovi e rimpinguare così la cassetta degli attrezzi. Ne suggerisco un paio.
Il primo, è quello di dare degli obiettivi intermedi agli obiettivi intermedi, e qui dovrete perdonarmi il gioco di parole. Spiego meglio. Quale obiettivo si persegue, e ci si autoassegna a medio termine perché il concatenamento delle vertenze, tra vittorie e sconfitte, possa determinare un’apertura politica e non rimanere chiuso nella circolarità economica? Perché se non ci si dà un obiettivo, il rischio è che si rimanga chiusi nella circolarità vertenziale, e che il livello politico rimanga separato, quando c’è tensione politica, e spesso c’è, e che si esprima in una superfetazione politicista, mal digerita dagli eventuali iscritti, e in fondo estranea al lavoro sindacale. Di un simile obiettivo si può capire meglio con un’approssimazione a titolo di esempio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un passaggio, quasi un’inversione, nei valori egemoni nella composizione di classe. Da quelli formati e custoditi dal proletariato di fabbrica, la solidarietà, l’affidamento all’azione collettiva per il miglioramento delle proprie condizioni, e la credenza radicata nella dimensione politica, nelle varie gradazioni socialiste e comuniste, come progetto di emancipazione universale, della propria classe e di società nel suo complesso, si è passati a un predominio dei valori tradizionalmente piccolo borghesi come sistema di valori dominante e diffuso, anche sulla componente operaia, e nel lavoro dipendente in generale.
Segnatamente, la disillusione e il disincanto verso la politica sia come gestore della cosa pubblica che come custode di soluzioni palingenetiche, l’individualismo proprietario, e la soluzione biografica alle contraddizioni sistemiche. Ora, un obiettivo intermedio per gli obiettivi intermedi assomiglia a qualcosa che inverte questa tendenza, lavorando principalmente sui nessi solidali, e sulla sostituzione tendenziale della soluzione biografica delle contraddizioni sistemiche con l’affidamento all’azione collettiva per il miglioramento delle proprie condizioni lavorative.
Secondo attrezzo, simile al primo ma non identico, è quello che sviluppa la propria funzione a partire dalla necessità di fare bilancio sul piano delle vertenze e degli obiettivi intermedi. Sia per trattarli con la dovuta, e adeguata, razionalità politica, sia per sviluppare un certo distacco da essi.
Quali sono le condizioni in cui funzionano e noi diciamo che sono andati bene o male? Come li costruiamo, e quando e come riconosciamo che sono diventate insistenze inservibili? Il bilancio che propongo è un esercizio molto semplice, e dalle molteplici utilità. Può essere fatto dopo un ciclo di vertenze, o dopo un certo periodo in cui un’istanza viene agitata. È una griglia con tre piccole variabili: uno – sono migliorate oppure no le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori; due – è accresciuta oppure no la potenza del sindacato, numerica e simbolica; tre – è accresciuta oppure no la coscienza di classe nella vertenza e nell’agitazione dell’istanza, ovverosia se sia sedimentata o meno la solidarietà e l’affidamento all’azione collettiva nella risoluzione della contraddizione specifica. Vedrete che è un esercizio utile e anche illuminante, cui aggiungere una clausola: per un giudizio positivo nel bilancio deve essere positiva la terza variabile, cui va attribuito un peso nettamente superiore alle prime due messe assieme.
Non tanto come, piuttosto perché: sporcarsi le mani con il welfare
La tendenza alla sussidiarietà nelle forme storiche di welfare state assolve idealmente a due funzioni: una è quella di coinvolgere strati di società civile organizzata nell’erogazione di servizi, con l’idea che tale coinvolgimento possa costituire una forma di prossimità capace di migliorare l’efficienza del servizio, facendo leva sull’eccedenza positiva di legami sociali forti; l’altra è il contenimento dei costi strutturali a livello di personale statale impiegato in tali servizi. Nella sostanza è solo la seconda funzione a essere garantita, mentre la prima rimane una pia illusione, persa nello scoramento e nella disillusione della forza lavoro cui è scaricata sia la compressione salariale, sia la gestione di una relazione di servizio – il rapporto con l’utenza – spesso incapace di fronteggiare, causa mancanza di adeguato finanziamento, un livello minimo di soddisfazione del bisogno.
Ci tocca questa doverosa premessa, pesante per quanto minuta, per dire che quello che si afferma – l’opportunità in questa fase di provare a gestire pezzi di welfare come parte di una politica di movimento – non vuole essere un proposito ingenuo, quindi.
È chiaro che non è possibile con un atto di volontà eliminare questa contraddizione fondamentale del welfare di prossimità, ma d’altro canto non rappresentano soluzioni efficaci sia la sottrazione, che la sola leva dell’autorganizzazione conflittuale dei lavoratori e lavoratrici della sussidiarietà – per dirne una, il meccanismo dei bandi è formidabile nello spezzare la dinamica di lotta.
Credo che sia tempo di portare il ragionamento sulla progettazione a un livello nuovo, non più fuori, accanto o separato dallo spazio politico, ma come spazio strategico, immanente e centrale rispetto alla costruzione di un nuovo corpo politico. È una visione dove operano assieme il mutualismo, la declinazione dal basso, bottom up, di un welfare rinnovato, la militanza politica e sociale. Sui temi del lavoro, della sostenibilità e della coesione sociale non è più tempo di rivendicazioni sterili e astratte, della fuffa mainstream, o della postura vittimistica. È tempo della presenza, del realismo e dell’efficacia.
Chi storce il naso e pensa che questi siano pannicelli caldi o sussidiarietà compatibile non sta capendo il punto: senza azione concreta, realista ed efficace non c’è modo di contrastare la tendenza alla polverizzazione individuale, fragile e piena di rancore, del corpo sociale. Ed è un atto di realismo dirsi che l’attuale stato di scomposizione non permette di attivare lotte sul welfare contando sul protagonismo dell’autonomia sociale, cioè su una condizione preesistente di potenza autorganizzativa dell’utenza.
Il punto sta nel modo in cui stare nel terreno del welfare sussidiario, non più con una logica che punti solo a una costruzione di rete fine a se stessa, non più con logica free rider che sconfina con il fare predatorio, non più con logica indifferente a un impatto sociale positivo e duraturo, tanto per elencare alcune delle degenerazioni che toccano oggi il terzo settore.
Il modo allora è un modo politico- non del politico come professione, o del politico come identità perimetrata, ma del politico come capacità di tessitura dei fili dispersi della classe- una visione di mondo possibile e la volontà di calarla nel presente, con tutti i limiti e le contraddizioni del caso.
Si tratta quindi di assumere un intervento di progettazione sociale nel welfare sussidiario partendo dalle contraddizioni esistenti, e senza pretesa di cominciare avendo l’illusione di averle risolte, con la volontà di costruire dove non c’è, e rafforzare dove c’è, l’autonomia del sociale. Va da sé che questa è solo apparentemente una funzione assente nel quadro dei movimenti, perché la funzione mutualistica autorganizzata e gratuita, che è cosa che negli ultimi anni ha avuto sviluppo pratico, e si tratta alla fine di dare un’organizzazione funzionale integrata tra attività di welfare sussidiario e di mutualismo autorganizzato come qualcosa che possa costituire una potenza d’intervento.
Certo, se riesce nel suo proposito, che è triplice- garantire un servizio efficace in sé e capace di attivare legami sociali forti- trasformare radicalmente il dispositivo del welfare sussidiario -sviluppare autonomia sociale e coscienza di classe.

Ecologia politica
La questione ambientale negli ultimi tempi è tornata prepotentemente al centro della scena politica.
Sono fondamentalmente due le ragioni per cui questo accade: la prima è l’evidenza nella percezione collettiva dei cambiamenti climatici, che svelano i limiti dello sviluppo del capitale e la sua sete di consumo indefinito delle risorse naturali; la seconda è la tendenza di sviluppo capitalistico che cerca di misurarsi con tale limite, e che prende il nome di green economy, economia circolare, e green new deal quando prova a delineare una politica economica.
L’ecologia politica, così come è venuta formandosi nel brodo di cultura dei conflitti sociali, delle lotte operaie contro la nocività, nelle controculture e nei movimenti alternativi al calar del millennio, muoveva dalla scarsa evidenza empirica e immediata dei cambiamenti climatici, fondata invece sul rigore della ricerca scientifica, e dalla divaricazione tra istanze ambientaliste e lavoro, tra culture operaie e movimenti ecologisti.
Basta solo questa scarna presa d’atto per delineare un’agenda di ricerca politica: l’ecologia politica ha bisogno di fare i conti con le proprie ragioni, modificandosi radicalmente proprio a partire dalla giustezza delle sue ragioni fondative, per aver capacità d’incidere radicalmente sul tempo nuovo.
L’errore fatale, che oggi spesso ci appare davanti, è quello di considerare scontata, popolare e di massa, l’istanza ambientalista, e altrettanto scontata la conversione ecologica del capitale. Si dice: basterà suonare lo spartito di sempre perché questo processo è ormai inscritto, definito e avviato nel divenire delle cose.
Nulla di più sbagliato: c’è un principio gattopardesco, quello per cui dall’alto si dice che tutto deve cambiare affinché tutto rimanga identico, cui le cose finiscono per allinearsi. Il destino dell’ecologia politica che non riflette su sé stessa è quello di rimaner avviluppata in questo abbraccio della dissimulazione, per finire di conoscersi sconfitta proprio quando appare trionfante dentro a un falso movimento.
Credo ci sia bisogno invece di lavorare a fondo su un rinnovamento dell’ecologia politica: significa assumere in primo luogo stile e metodo della ricerca ecologica che è quello rigoroso dell’attenzione alla complessità, della tensione verso una lettura complessiva del reale, alla ricerca delle leve della causalità sistemica, e portarlo, di nuovo, nello spazio della politica e delle sue pratiche. Significa, poi, fare laboratorio di questa convergenza tra ecologia ed economia che è nell’aria del tempo nuovo – è una convergenza che va conosciuta, analizzata, criticata e mossa a nuove sollecitazioni di possibili trasformazioni radicali. La direzione di lavoro va decisamente sulle modalità e condizioni di possibilità di una modernità alternativa e inattuale, dove si possa compiere una decisa accelerazione verso la sostenibilità, piuttosto che farsi irretire dal pensiero della decrescita.
Ma il tempo nuovo ci interroga sulla questione ecologica soprattutto da un altro punto di vista. È possibile trasformare la coscienza ambientale in coscienza di classe? Quali sono le condizioni e su quali linee può costituirsi discorso e pratica di questo processo di trasformazione?
Sono domande difficili, e non aspettatevi una risposta definitiva e convincente. Non è qualcosa che si risolve con l’oziosa disputa nominalistica se il nostro tempo debba chiamarsi antropocene o capitalocene, né col richiamo alla radicalizzazione delle pratiche di piazza delle lotte ecologiche, perché può anche darsi la situazione in cui la borghesia faccia le barricate direttamente e per proprio conto, nell’ambito di un conflitto fra settori fossili e sostenibili.
Però rispondo che sì, è possibile, e che le condizioni si trovano principalmente sul terreno del lavoro, proprio dove la coscienza ecologica ha avuto origine, e proprio dove si era avuta una divaricazione, tuttora perdurante. Rompere questa divaricazione è la condizione prima per cui possa attivarsi questo processo, che si può svolgere sulle linee della responsabilità ambientale dell’impresa, e sull’alta intensità di lavoro che la transizione ecologica di processo e di prodotto richiede.
La responsabilità estesa ambientale è una crepa nel modello anglosassone d’impresa, crepa in cui il lavoro può inserirsi e attivare una controtendenza di allargamento di responsabilità sociale allargata ai rapporti di produzione, e l’alta intensità di lavoro può costituire, altrettanto e in maniera omologa, uno freno alla tendenza di svalorizzazione della forza lavoro, riattivandone protagonismo e centralità nel processo produttivo. Non si tratta di riesumare il modello renano, si tratta di un’apertura di possibilità dentro una probabile modificazione strutturale dei rapporti produttivi. La trasformazione possibile della coscienza ambientale in coscienza di classe può partire da qui, e innervare così società e territori, i luoghi dove ora vivono le lotte ecologiche, ancora deboli perché ancora orfane delle lotte del lavoro.
Tutte le immagini da commons.wikimedia.org
Qui per scaricare il pdf del testo
