cult

CULT
No love lost: La passione secondo Joy Division, o l’impossibile sutura dell’anima
A 40 anni dell’uscita di Unknown Pleasures, il primo LP dei Joy Division, una riflessione sulla loro politica/poetica che ha saputo rendere le miserie della società neoliberale e il malessere della cultura (europea) come divenire stesso della nostra condizione ontologica
Lascia che dall’oscuro regno dei dannati sorgano scheletri dai denti avvelenati
Thomas Pynchon, V.
Tra rivolta punk e disperazione dark
Nessun amore perduto: non solo uno dei brani più belli e potenti di Joy Division, ma anche l’enunciazione di una condizione ontologica epocale. Qualcosa come un’etnografia di ciò che diverrà la soggettività contemporanea, di quella desertificazione del reale che l’implosione della società fordista avrebbe portato con sé; lacerazione, alienazione, solitudine, angoscia, disamore, disumanizzazione, dissoluzione dei legami, mercificazione dei sentimenti, pulsioni autoritarie e neofasciste, ovvero la distopia (neoliberale) post-industriale colta nel mentre si fa dispositivo di potere, nel mentre si trasfigura dolorosamente in anima, No love Lost: “So long sitting here, Didn’t hear the warning. Waiting for the tape to run. We’ve been moving around in different situations, Knowing that the time would come. Just to see you torn apart, witness to your empty heart. I need it. I need it. I need it.”
La dissoluzione di ogni sostanza (Substance, è il nome della raccolta del 1988 con molti dei loro inediti), la leggerezza come divenire insopportabile della nostra condizione, l’impossibilità di un amore davvero pieno e romantico – “Love Will Tear Us part”, uno dei loro brani più famosi – ovvero lo scivolamento fra le superfici come topica del soggetto postmoderno; l’amnesia-epilessia (è noto che Ian Curtis ne soffriva) come Nausea del presente (il riferimento al romanzo di Sartre non è qui casuale), come impossibile sutura di un’anima strutturalmente lacerata, come specchio-sintomo della mancanza e della sua nostalgia – I Remember Nothing: “Get Weak all the Time – We just pass the time. Me in my own world – yeah you there beside- The gaps are enormous – we stare from each side”. Curtis descrive qui il rapporto con la moglie Deborah Woodruf, ma il disincontro amoroso, l’esperienza dell’amore come un fenomeno maledettamente barrato, per dirla con Lacan, viene sentito qui, certo in modo contraddittorio, come il portato di una nuova condizione socio-ontologica; è così che il desiderio di rivolta-punk si fa sempre di più un grido di disperazione-dark. Nessun amore perduto; dunque; è questo il no-future dei Joy Division, un no-future iscritto nel presente, nella desolazione urbana delle periferie di una Manchester sempre più risucchiata dalla miseria proletaria e dalla stagnazione fordista, nella sua disoccupazione giovanile di massa e nel proliferare di lavori-spazzatura come unica alternativa economica (come ben narrato dal film Control del 2007 di Anton Corbijn, tratto dall’autobiografia scritta dalla moglie di Curtis). E tuttavia si tratta di un no-future, come suggerito dallo stesso No Love Lost, sentito anche come irrimediabile eredità (culturale) del passato. Nessun amore perduto, ovvero non vi è nulla da salvare, nulla cui si possa restare legato. Attorno a noi, solo un deserto di Anime perdute (Dead Souls, ispirato liberamente a Gogol) e il rischio latente di nuovi autoritarismi neofascisti: “Someone take these dreams away. That point me to another day. A duel of personalities. That Stretch all true realities. Theykeep calling me. Where figures from the pas stand tall. And mocking voices ring the halls. Imperialistic house of prayer. Conquistadors who took their share”. Detto altrimenti, la passione secondo Joy Division.
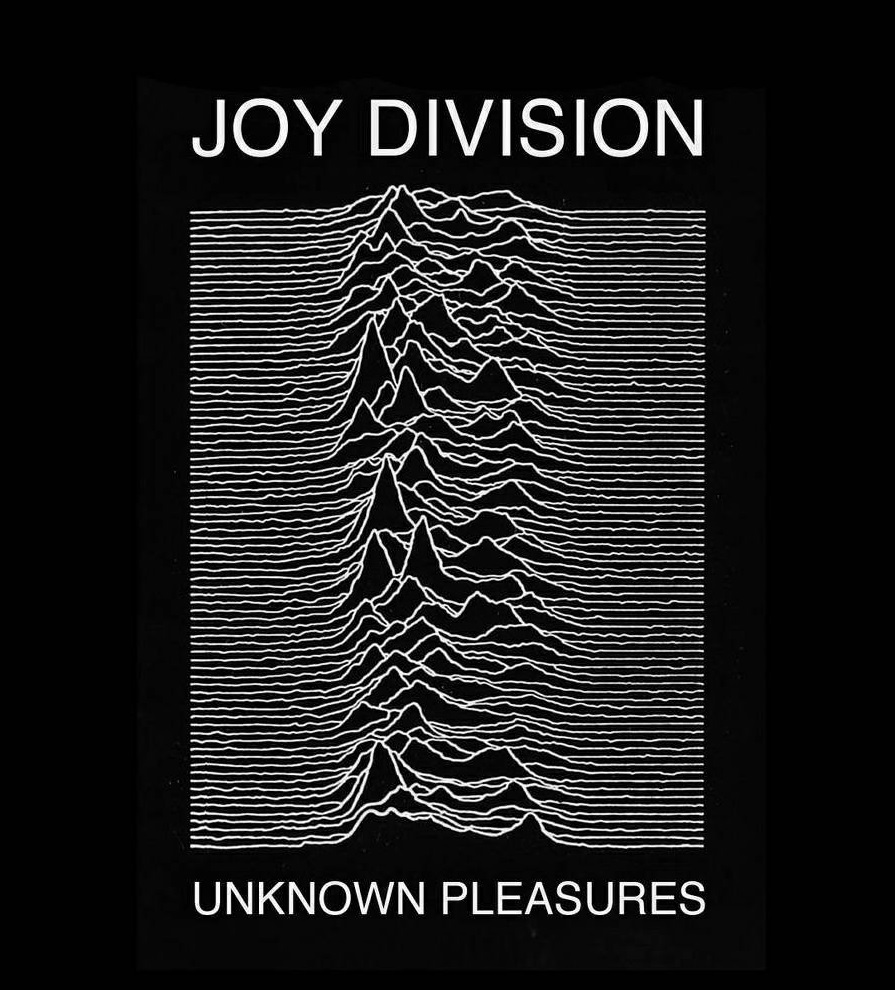
La rivolta dei figli della white working class: distruggi l’immagine di figlio di tuo padre
Dei Joy Division si è tornato a parlare alcuni giorni fa. L’occasione è stata una mera ricorrenza formale: a Giugno si compivano 40 anni dell’uscita di Unknown Pleasures, il loro primo LP. Si è scritto anche troppo della qualità rivoluzionaria della loro musica, della sua capacità di anticipare buona parte degli stili musicali degli anni ’80 pur non appartenendo, in senso stretto, a quel decennio. Attivi soltanto tre anni (tra il 1977 e il 1980, anno del suicidio di Curtis), e per lo più a Macclesfield e Salford, le terre desolate della Greater Manchester, appare chiaro che i Joy Division incarnavano più lo “stato d’animo” di buona parte dei giovani delle white working classes inglesi travolti dalla spirale discendente dei vertiginosi ’70 – iniziati con irrefrenabili pulsioni contro-culturali e rivoluzionarie e finiti con il populismo autoritario e neoliberale di Margareth Thatcher – che non lo spirito di quel glam già addomesticato e mercificato tipico dell’everything goes dominante nella musica anglosassone degli ’80. Figli autentici della fine degli anni ’70 – di quel grido di rabbia plebea che fu il punk inglese degli anni d’oro, i Sex Pistols prima di tutto, ma anche i Clash, Buzzcocks, The Fall, The Undertones, The Stranglers, Siouxsie and the Banshes, Chelsea, The Slits primo gruppo punk femminile, ecc. – i Joy Division hanno comunque rappresentato forse meglio di nessun altra band di quel momento il passaggio non solo musicale, ma anche politico-culturale, dal punk al post-punk alla new wave.
Infatti la potenza e il segno epocale dei loro album – An ideal for Living (1977), Unknown Pleasures (1979) e Closer (1980) – non può essere colta senza prenderli in considerazione anche come testi culturali. Più ultimo grido romantico di una disperazione esistenziale noir e modernista, che non prima espressione di un godimento post-moderno meramente edonistico, la musica dei Joy Division – nella sua amalgama poetica quasi perfetta tra suoni e testi – andrebbe presa prima di tutto, lo abbiamo anticipato, come l’espressione mimetica di una sorta di psicogeografia post-industriale, post-urbana e post-coloniale del tutto singolare. Il segreto per questa decodificazione sta nelle risorse e nelle citazioni stesse dei testi di Ian Curtis: Nietzsche, Burroughs, Ballard, P. Dick, Dostoevskij, Gogol, Conrad, Proust e le poesie di Jim Morrison si fondono qui alla perfezione con suggestioni musicali davvero eterogenee; il primo punk, Kraftwerk, Neu, Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie; tanto da sembrare quasi la stessa cosa.
Una psicogeografia, tanto tormentata quanto autistica e claustro-fobica, che l’immaginario estetico-culturale di Curtis (come buona parte del movimento punk e post-punk britannici), e sta qui il punto che vogliamo sottolineare, riconducevano non soltanto alla mera implosione economico-ontologica della società industriale post-bellica del welfare, al suo presente, ma soprattutto a qualcosa di ben più inquietante e irrisolto non solo della storia della Gran Bretagna, ma anche dell’Europa. Il progressivo svuotamento del soggetto, la sua precarietà-vulnerabilità ontologica, la sua malafede e sensibilità alla massificazione e agli autoritarismi più brutali, così come il divenire impossibile dell’amore e dei sentimenti profondi, vengono narrati/cantati come l’approdo inevitabile di una natura/cultura (moderna) corrotta già nelle sue viscere e quindi non più riformabile. Si tratta, letteralmente, dei Failures dell’uomo moderno per riprendere il titolo di uno dei 4 brani incisi nel loro primo EP, An Ideal for Living: “No, no, he can’t pick sides – all the failures of the modern man; No, no longer denies – all the failures of the modern man”.
La poetica/politica di Joy Division irrompe sulla scena come uno degli ultimi rovesci-nietzscheani della grande narrazione occidentale, e proprio nel momento (post-industriale) del suo definitivo disfarsi. Come recita ancora Failures, in uno stile ancora piuttosto in linea con il punk più ruvido di quegli anni: “Love in a hollow field – break the image of your father’s son”. (Non è possibile l’) Amore in un territorio desolato – distruggi l’immagine del figlio di tuo padre! I Joy Division proseguono in questo modo la rivolta giovanile iniziata negli anni ’60 contro la Gran Bretagna post-bellica, quella nata certo dal trionfo sul nazifascismo, ma rimasta ancora aristocratica-imperiale-coloniale-patriarcale-tradizionale fino alle viscere; la loro musica viene così a saldarsi con l’insorgenza culturale proletaria del primo rock, del free cinema, (con i film T. Richardson, K. Reisz, L. Anderson), ma anche con i riots razziali dei primi migranti post-coloniali e da altri movimenti politici e culturali. È un’altra delle espressioni di quello che Stuart Hall e compagni hanno denominato in Policing the Crisis, la crisi dell’autorità morale nella Gran Bretagna degli anni sessanta: una crisi da cui sorgerà il populismo autoritario neoliberale thatcheriano come risposta di Stato al “disordine” sociale. È in questo contesto che occorre leggere il costante e provocatorio richiamo dei Joy Division alla Germania e alla Seconda guerra mondiale nei loro testi. Si potrebbe dire, riprendendo uno testi più pionieristici prodotti dai Cultural Studies sulle sottoculture giovanili, che la loro “resistenza rituale” (Resistance Through Rituals, 1976) alla società in generale, e alla cultura della working class dei loro genitori in particolare, passava proprio attraverso questa sarcastica ri-appropriazione dell’estetica nazista. Come per altri esempi dello stile punk, e qui seguiamo invece da vicino le definizioni di Dick Hebdige di sottocultura, stava in questa re-significazione performativa del nazismo, la loro sfida “alla condizione di razionalità e di coerenza” del senso comune dominante della Gran Bretagna di quegli anni.
La riappropriazione ironica dell’estetica nazista come critica dell’Europa
Già il primo nome della band – Warsaw – annunciava che tipo di guerriglia estetico-culturale avrebbe ingaggiato la loro musica contro l’ordine simbolico della società britannica. Ispirato al noto brano di David Bowie (Warszawa, in Low, 1977), così come alle suggestioni berlinesi del primo album della sua nota trilogia, quel nome si poneva sin dall’allora come un importante e provocatorio significante storico: Warsaw, “Hollow field” della Seconda guerra mondiale, occupazione nazista, la rivolta del ghetto ebraico, deportazioni, campi di concentramento, distruzione, sterminio, ricostruzione dalle macerie nello stile anonimo del modernismo architettonico. Si sa che i Joy Division vennero osteggiati e accusati ai loro esordi di filo-nazismo e di farsi promotori di uno stile nazi-punk. Bernard Sumner (chitarrista) e Peter Hook (bassista) hanno negato in diverse occasioni questa filiazione, riconoscendosi, a differenza di Ian Curtis (più vicino ai Tories) come appartenenti per cultura al tradizionale laburismo inglese. È anche noto che i Joy Division hanno partecipato a Leeds nel 1978 a uno dei festival organizzati da Rock Against Racism. Il rinvio del loro primo nome al nazismo e alla Seconda guerra mondiale, così come anche di buona parte dei brani e dell’immaginario estetico di Curtis e compagni, non deve essere inteso quindi come un richiamo ideologico a quel regime, bensì come un’interrogazione-provocazione di fronte alle pulsioni neofasciste che emergevano nella società britannica in quegli anni di decomposizione del modo di produzione fordista.
Warsaw, dunque, come rovina dell’Europa, anziché come emulazione o propaganda. Lo stesso taglio critico, ma ancora più sprezzante e provocatorio nella sua aggressione al senso comune dominante, persegue il nome scelto definitivamente da Curtis per la band. Joy division in effetti viene preso dall’argomento centrale del romanzo La casa delle bambole di Karol Cetinsky, superstite di Auschwitz. Il romanzo racconta l’esperienza di vita di una ragazza polacca, Daniella Preleshnik, all’interno di ciò che veniva denominato dai nazisti come la “divisione gioia” dei campi di sterminio, ovvero in quel reparto dove le deportate più giovani erano costrette a prostituirsi con gli ufficiali nazisti. La scelta di Joy Division come nome sembra voler ricordare la permanenza come traccia (nel presente) della catastrofe razziale nazista di cui è stata capace quell’umanità europea dei genitori delle nuove generazioni, e da cui era nata – non senza complicità e miserabili autoassoluzioni – la società del dopoguerra. “No lost love in the House of Dolls”: un richiamo a non dimenticare una delle espressioni più aberranti della storia della violenza di genere, una pratica razzista di origine schiavista rispuntata nel cuore stesso dell’Europa. È anche in questo senso che si può leggere la controversa copertina di An Ideal for Living (inneggiante un giovane hitleriano con il classico tamburo della gioventù nazista, la scritta Joy Division in caratteri gotici e un disegno interno di un giovane ebreo vittima dei nazisti), così come l’ambivalente titolo e buona parte delle parole delle sue quattro canzoni.

Si tratta di un grido di allarme di fronte alle spinte autoritarie manifestate dalla società britannica in un momento di tensioni politiche e razziali. Sintomatico dell’operazione semiotica è lo stesso brano Warsaw, che evoca sin dall’inizio la figura di Rudolf Hess. Curtis non lo nomina direttamente, ma lo rende palpabile dando il via alla canzone con il numero di prigioniero di guerra assegnato a Hess dopo la sua cattura in Scozia nel 1941: non, dunque, il solito one, two, three, four, ma “350125 go”, lasciando poi come ipnotico e martellante ritornello del pezzo 31G (31 come la chiave del teatro europeo di guerra, G per Germania). Tutto il brano appare poi come una fantomatica ed ermetica biografia del gerarca nazista, raccontata come se fosse egli stesso ad esprimersi, pronunciando un gelido quanto cinico atto d’accusa (contro la società britannica?) in cui lascia trapelare la sua delusione per il “tradimento” di chi meglio avrebbe dovuto comprenderlo, date le non poche affinità storiche: “I can see all the cold facts. I can see through your eyes. All this talk made no contact. No matter how hard we tried”. Vale la pena ricordare che un altro dei primi brani incisi dal gruppo – At a Later Date – cominciava con una frase urlata da Curtis: Do You Remember Rudolf Hess?
Anche gli altri brani di An Ideal For Living – i già citati No love Lost, Leaders of Men Failures – hanno come leit-motiv un costante rinvio all’esperienza nazista. Particolarmente suggestivo il formidabile No Love lost, in cui Curtis torna in modo esplicito sul romanzo di Cetinski, chiudendo entro la sua sordida riconsiderazione i confini di un nuovo territorio musicale, che cominciava a lasciarsi dietro il punk più tradizionale: “You’ve been seeing in darkness, not in learning. Hoping that the truth will pass. No life underground – wasting never changing. Wishing that this day won’t last. To never see you show your age. To watch until the beauty fades. I need it. I need it. I need it”. Nessun amore perduto, anzi una vita di sole violenze e senza amore: a restare è solo il desiderio che finisca una lunga notte di devastazione fisica e morale, di solitudine, di sottomissione forzata e quotidiana umiliazione. Il discorso sul nazismo come metonimia del presente si chiude con Leaders of men, un brano che diviene assai significativo anche alla luce della nostra attuale congiuntura storica, con i suoi sovranismi regressivi e con l’autoritarismo razzista di nuovi “capi carismatici”: “The leaders of men – born out your frustration The leaders of men – just a strange infatuation. The leaders of men – made a promise for a new life. No saviour for our sakes – to crush the internees of hate. Self-induced manipulation – to crush all thoughts of mass salvation”. Il rischio di una deriva autoritaria della società britannica è uno dei leit-motiv di molti dei loro brani: si pensi, per esempio, a Decades, Autosuggestion e al bellissimo Shadowplay.
Non è difficile vedere qui i nessi con alcune delle auto-critiche più famosi al totalitarismo nazifascista prodotte dall’Europa e dagli Stati Uniti tra gli anni del primo e del secondo conflitto mondiale e l’immediato dopoguerra: dalla Psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich, al noto racconto L’infanzia di un capo di Sartre, da Lo Straniero di Camus alle critiche all’autoritarismo della prima scuola di Francoforte e al classico Germania senza lutto. Psicoanalisi del post-nazismo di Alexander Mitscherlich. Per non parlare poi di testi più noti come La svastica sul sole di P. Dick o più recenti come Il complotto contro l’America di P. Roth. Ma può essere suggestivo tracciare delle connessioni anche con altre espressioni culturali di taglio genealogico sull’eredità dell’Europa a loro più o meno contemporanee, come i primi di film di Wim Wenders – Alice nelle città (1973) e Falso movimento (1975) – buona parte di quelli di Rainer W. Fassbinder – Il matrimonio di Maria Braun (1979) e Terza generazione (1979) – e anche il cinema di Bertolucci – Il conformista (1970) e La strategia del ragno (1971). I Joy Division sembrano voler proporre con altri mezzi (e attraverso ciò che Dick Hebdige definì in un altro dei classici prodotto dai Cultural Studies come il linguaggio tipicamente bricoleur, performativo e volutamente apolitico e provocatorio dello stile punk) la famosa ingiunzione di Adorno: dopo Auschwitz non è possibile nemmeno scrivere una poesia. Occorre interrogare quello che Freud aveva definito da un’altra prospettiva come Il malessere della cultura (Europea). La radice del male sta proprio nella fenomenologia stessa della civiltà (occidentale). Sta qui buona parte dell’eredità della loro musica, della loro Transmission, per dirla con uno dei loro pezzi più belli e noti. “Listen to the silence, let it ring on Eyes, dark grey lenses frightened of the sun. We would have a fine time living in the night. Left to blind destruction. Waiting for our sight”.
Lacerazione ontologica e disamore come archeologia (postcoloniale) del presente
Una delle cose più belle dei testi di Curtis, e che in qualche modo fanno da supporto al nostro discorso, sta in quello che possiamo chiamare con Roland Barthes la loro testura. Mi riferisco al détournement più o meno situazionista come metodo, ovvero alla selezione di trame, versi e citazioni da altri testi tagliando fuori dalla citazione ogni riferimento che possa accennare alla sua vera fonte. È così che le frasi diventano chiuse in se stesse, qualcosa di più simile ad aforismi, riconfigurandosi da significati in significanti che non possono prescindere da quello che Stuart Hall chiamava in Encoding and decoding (1988) la decodificazione da parte dei riceventi nell’evocazione di una qualche enunciazione. Diverse volte lo stesso Curtis ha reso esplicito questo suo modo di procedere, ribadendo che i suoi testi non veicolavano alcun messaggio chiuso nella bottiglia, bensì pensieri vuoti, senza un referente esplicito o una qualche codificazione già pronta per l’uso.
Frasi e parole che in qualche modo rinviano solo a se stesse, in una nuova riformulazione del “grado zero della scrittura”, ovvero di quella strategia narrativa che (ancora) Barthes vedeva come necessario punto di partenza di una letteratura libera, non borghese, non controllabile, anarchica e rivoluzionaria. Si pensi, da questo punto di vista, al doppio livello dei testi di Curtis nei brani da noi riportati: collocare diversi aspetti dell’esperienza nazista sulla filigrana del presente, sullo sfondo della condizione contemporanea, senza farne alcun riferimento esplicito, abolendo ogni rinvio diretto, rendono quella condizione storica, al tempo stesso, certo come una parte presente del nostro contemporaneo, ma anche viceversa, ci mettono di fronte a ciò che Ernst Bloch ha chiamato la “non-contemporaneità del contemporaneo”. Detto altrimenti, la poetica dei Joy Division ci riporta sulla traccia della parte migliore del lavoro di Giorgio Agamben: il nazismo, l’autoritarismo (oggi diremmo il populismo) come nomos della biopolitica moderna. Con e contro Agamben, e con e contro i Joy Division, vorremmo aggiungere un’altra parola (assente dal lessico di Agamben, implicita nella storicità stessa dei Joy Division): “capitalistica”. La volontà di potere, la sopraffazione dei deboli, la pulsione dispotica, l’estetizzazione della politica, rappresentano sì un nomos, ma del capitalismo biopolitico moderno. Ci sembra stia proprio qui la potenza e il tratto epocale di ciò che si può chiamare la politica dei Joy Division: nell’aver saputo rendere le miserie della prima società post-industriale (e neoliberale) e il malessere della cultura (europea) come divenire stesso della nostra condizione ontologica.

Le parole di una delle loro fan più note, intervistata nel documentario biografico di Grant Lee (2007), suonano qui davvero eloquenti, “Era un gruppo che attirava gli outsider e le ragazze. All’epoca mi sentivo molto vulnerabile e loro mi comunicavano qualcosa. Quello che mi piaceva dei Joy Division è che erano un gruppo legato al loro ambiente. Quando suonavano non pensavi a loro come a una band, ma come al rumore che ti circondava”. Difficile negare che questo rumore, fatto di disoccupazione, lavori di merda, depressione, pulsioni neofasciste, crisi economica e angoscia, continui ancora a circondarci. Nessun amore perduto, dunque, nulla a cui restare legato: condizione angosciante certo, ma anche libera e ricca di possibilità. Non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Sta a noi pensare cosa farcene. Intanto, a Joy Division ciò che è di Joy Division!
Foto di copertina tratta da qui
