cult
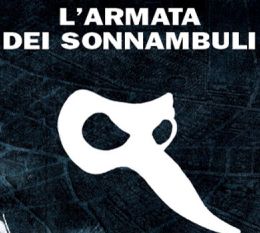
CULT
L’Armata dei Sonnambuli
Il “romanzo del Terrore” dei Wu Ming: nel clima infuocato della Rivoluzione avanza un nuovo tipo di restaurazione. Un eroe mascherato, un uomo di scienza e una donna del popolo cercheranno di fermarla
Prima di cominciare a leggere procuratevi la colonna sonora; alzate il volume del vostro dipositivo e cliccate sul tasto destro sul mouse qui
“Te lo si conta noi, com’è che andò. Noi che s’era in piazza della Rivoluzione”: pare di sentirlo davvero, il racconto che sgorga dal corpo sociale che popola gli anfratti maleodoranti, eccitati e in preda alla febbre e al trambusto del Terrore rivoluzionario che viene fuori dalle quasi 800 pagine de “L’Armata dei Sonnambuli”, il nuovo romanzo collettivo dei Wu Ming.
Va a finire (ma non vi preoccupate, quello che segue non è uno spoiler, la trama la scoprirete da soli assieme al finale) che in questo affresco corale, umanissimo e radicale, potente e mai caricaturale, realismo e favola si contaminano e a loro volta tracimano con le pagine della vita vera, perché nelle ultime pagine il romanzo entra nella storia approfondendo il percorso degli Oggetti Narrativi non Identificati wuminghiani. Lasciamo alle settimane che seguiranno, e alle discussioni che verranno, di trovare analogie e differenze tra le discussioni sulle incombenze dei giorni che ci tocca vivere e la storia narrata dell’Armata dei Sonnambuli. Per ora concentriamoci sul racconto, che scorre fluente ma che come al solito non contiene tesi semplicistiche o allegorie a chiave.
Si affonda dentro le strade bagnate di sudore, lastricate di sangue e annaffiate di alcolici di pessima qualità. Siamo a Parigi, l’epicentro dello scandaloso evento storico che arbalta il mondo. Ma si aprono anche i sentieri selvaggi delle regioni a qualche giorno di viaggio dalla città della Bastiglia ma separate anni luce dalle scosse telluriche repubblicane. I due luoghi, la città e la provincia, rappresentano rispettivamente l’effervescenza terragna della sommossa permanente e l’arretratezza quasi metafisica della servitù. Due universi contigui ma inconciliabili, parte della stessa nazione che si ritrova nel fervente subbuglio con gli occhi del mondo antico puntati addosso: chi sta in alto in preda al terrore e chi sta in basso impegnato a riscaldare con combustibile di fortuna l’ardore rivoluzionario.
Nel mezzo, tra il passato superstizioso e il futuro agguantato con rabbia, vi troverete in un altro luogo: nella fortezza biopolitica del castello di Bicêtre, istituzione totale e paradigma panottico che si staglia alla periferia meridionale della capitale francese. La struttura viene impiegata simultaneamente come orfanotrofio, prigione, manicomio e ospedale. Nel castello degli orrori mentali si sperimentano forme nuove di comando e obbedienza: quelle provenienti dall’ancien régime non sono più efficaci. Bisogna andare oltre la pura “restaurazione”. “La controrivoluzione è a sua volta una rivoluzione, oppure non è nulla”, si legge in uno dei passaggi chiave del romanzo nel quale cominciamo a scoprire le mosse dei nemici del popolo. Bicêtre è il laboratorio delle tecniche governamentali citato anche da Foucault nella sua “Storia della follia nell’età classica”. Perché non basta sostituire le catene con la camicia di forza per giungere a condizioni di trattamento più umane: l’ipnosi, il mesmerismo, il magnetismo sono discipline nuove, affilate e adatte ai tempi nuovi. Consentono di muovere massa di sonnambuli forzando la loro volontà. I fluidi elettrici che attraversano il corpo sociale possono essere manovrati dall’alto e non necessariamente a fin di bene.
Uno dei personaggi principali, il medico Orphée d’Amblanc intraprende una cavalcata nel cuore di tenebra delle province sperdute che lo porterà a vivere esperienze angoscianti, il corpo ancora pulsante delle ferite ancora doloranti delle guerre d’America. È in missione per conto della polizia giacobina. Sono pagine che si leggono col fiato sospeso, quelle che raccontano l’indagine nelle terre dei bifolchi timorati di Dio che non sanno ancora cos’è la rivoluzione, in mezzo alle genti ancora sottomesse all’incantesimo del potere assoluto. Il potere funziona come un’ipnosi collettiva, una fascinazione magnetica che spinge anche all’autodistruzione, riesce anche a mandarti a morire in trance, senza farti sentire il dolore fisico. La restaurazione che si spaccia per rivoluzione è in agguato.

Proprio all’inizio del romanzo, il monarca sconfitto Luigi XVI sale su un palcoscenico davanti ad una platea urlante per finire con la testa mozzata. Perché il potere nella temperie dell’immediato post-ottantanove come nelle cerimonie del lusso nobiliare prima, è anche spettacolo, rappresentazione. La rivoluzionaria (e attrice teatrale) Claire Lacombe durante il passaggio dal Terrore al Termidoro, descrive gli eventi che accadono nella Convenzione della sala da spettacoli del Palazzo delle Tegolerie: “Questi politici si alzano sui banchi per i loro discorsi come un attore calcherebbe le scene. Per loro il popolo è un pubblico, nient’altro”. Ad esperire la relazione tra messa in scena e sovranità, e a rendersi conto di come “rappresentare il popolo” significhi “agire per conto suo” ma anche “metterlo in scena”, l’attore goldoniano e di origine bolognese Léo Modonnet, al secolo Leonida Modonesi, che veste i panni di un vendicatore rivoluzionario con tanto di maschera nasuta di Scaramouche. Prende a saltare sui tetti e a combattere contro i muschiatini reazionari della “Gioventù Dorata” perché non ha più senso stare al chiuso di un teatro quando, grazie alle scosse rivoluzionarie che hanno fatto saltare le regole, il palcoscenico è “divenuto grande quanto Parigi”: “Gli spettacoli più emozionanti erano quelli dove la gente perdeva la testa per davvero, i cannoni tuonavano e poteva capitare, da un momento all’altro, che gli spettatori si trovassero a recitare”.
Leonida interpreta fuori dal palcoscenico un eroe rivoluzionario che non ha nulla a che vedere col suo omonimo spartano della battaglia delle Termopili. Per questo si accorge che “Uno da solo non basta” e che per tagliare la testa del serpente controrivoluzionario bisogna costruire un’alleanza. A fargli prendere coscienza, e condurre più in là la riflessione dei Wu Ming sull’uso dal basso dei miti e delle narrazioni, c’è il personaggio di Marie Noziére, donna del popolo che vive sulla sua pelle il limite della Rivoluzione borghese: quando si tratta di attaccare i “monopolisti”, quelli che speculano sulla fame e sul lavoro dei diseredati, il Terrore che con le sue compagne aveva provato a scatenare contro affaristi e taglieggiatori cambia verso, colpisce a morte Marat, ghigliottina Danton e Robespierre, si insinua presso i rivoluzionari dei foborghi. Il medico-investigatore, l’artista di strada e la donna rivoluzionaria sono in primo piano, a segnare una maturità espressiva e una capacità altissima di rappresentazione dei personaggi. Dietro di loro si muove una moltitudine di uomini e donne, ritratti qualche volta appena abbozzati e altre volte più approfonditi, che disegnano un mondo pieno di sfumature vergate con leggerezza e tratti forti marcati con mano sicura: solo così si può raccontare una rivoluzione e si intende la forza materiale (e rivoluzionaria) delle tante vite che almeno per un attimo sollevano lo sguardo oltre l’orizzonte: a più voci e intrecciando più sguardi. Vi capiterà di affezionarvi a qualcuno dei “comprimari” (ne citiamo qui solo alcuni: il ciabattino e guardia rivoluzionaria Treignac, l’allibratore Bernard La Rana, il debole commissario Chauvelin, la femministra Pauline Léon) per accorgervi che in una rivoluzione non esistono personaggi secondari e che in un racconto rivoluzionario che si rispetti tutti hanno una funzione chiave che muove la storia. A meno che non vi capiti di essere arruolati nell’Armata dei Sonnambuli.
