cult

CULT
Istituire il molteplice, fare il comune
“Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune” è il titolo del libro di Michele Spanò che fornisce una lettura diversa del diritto privato
Non è certo un caso che alcune tra le più avvertite analisi delle trasformazioni della composizione di classe tra la metà degli anni ’70 e gli anni ’80 del Novecento ponessero il problema delle istituzioni e del diritto come problema squisitamente politico.
Foucault assumeva le istituzioni sociali come il campo sperimentale all’interno del quale consolidare innovativi processi di soggettivazione e avviare le corrispondenti trasformazioni; Deleuze vedeva nella giurisprudenza romana il modello per una creazione di diritto capace di prolungare la singolarità e di modularne le libere convenzioni.
Nell’uno, come nell’altro, caso, diritto e istituzioni venivano sottratte all’interdetto critico-ideologico che le aveva trattate come sterili strumenti della riproduzione del dominio e veniva inaugurato un campo di ricerca, teorico e politico assieme, che solo recentemente, ulteriormente sollecitato dalla questione dei beni comuni, del sindacalismo sociale, del lavoro intermittente e precario, viene acquisendo la centralità e la profondità analitica che merita.
Tra i più recenti contributi, quello di Michele Spanò si segnala per vari motivi*.
Il primo: questo lavoro non si esercita sul campo giuridico dall’esterno. La decostruzione della «topologia giuridica moderna» che viene qui elaborata lavora sulle linee di sviluppo interne degli istituti del diritto e sulla particolare configurazione delle relazioni sociali che essi pervengono a realizzare istituendo giuridicamente (e non traducendo linearmente) il rapporto di capitale.
Il progetto di giuridificazione della politica e il suo compimento nella dottrina e nelle pratiche del diritto del secolo XIX modulano un’individuazione del soggetto che agisce come autentica struttura per il funzionamento dei rapporti sociali di produzione. Stato e mercato, politica ed economia, sviluppano una medesima logica e stilizzano allo stesso modo l’individuo e le sue relazioni.
Il secondo motivo che rende indispensabile la ricerca di Spanò è la sua messa in correlazione «dipolare» di pubblico e privato, Stato e società.
Non si tratta qui, come tendenzialmente recita la retorica liberale, di una dicotomia la cui tensione si tratterebbe di sfruttare per allargare gli spazi di libertà e di scambio, o, come in altre formule del discorso politico, per integrare alle istituzioni democratiche un supplemento sociale, ma di mettere a fuoco il regime di funzionamento di una macchina che lavora sulla coppia sovranità / patrimonialità facendo del soggetto di diritto privato non già il contraltare del pubblico quanto piuttosto il fondamento delle regolarità di quest’ultimo.
Lo Stato nasce per rendere possibile l’accumulazione privata di capitale; il privato soggetto di diritto per rispecchiarsi nell’universale del diritto «pubblico» che riconfigura e generalizza il rapporto sociale complessivo.
Il terzo motivo di interesse sta nella capacità di Spanò di assumere come decisivo il passaggio d’epoca che segna la composizione di classe contemporanea.
Quello che egli chiama, deleuzianamente, «il divenire giurisprudenza della politica» è il riflesso delle profonde trasformazioni che investono il lavoro e la sua organizzazione con lo sfondamento della giornata lavorativa, la crisi del rapporto di salario, l’immediata messa a valore della cooperazione sociale.
Interessi e bisogni, desideri e necessità che emergono con la tendenziale generalizzazione della gig economy e con le insorgenze che la attraversano rendono letteralmente «impossibile» l’impiego tanto della tradizionale mediazione assicurata dallo schema pubblicistico della legge (una decisione da tutti voluta e per tutti valida), quanto di quella privatistica del contratto (una decisione valevole per le parti che hanno concorso a stabilirla).
L’eterogeneità che segna il lavoro vivo contemporaneo, così come i regimi della sua messa a valore, disabilita e svuota di senso l’intero sistema di figure e di istituti di negoziazione fissati dalla vicenda novecentesca del diritto.
Che il diritto vada immediatamente considerato una politica significa perciò, da un lato, trattarne archeologicamente logiche e istituti, dall’altro, liberarlo come la grammatica capace di articolare ed istituire in modo differente i rapporti che può essere messo in grado di sostenere una volta esso venga definitivamente sottratto alle forme delle quali è sin troppo semplice evidenziare l’esaurimento.
La mossa archeologica è qui funzionale a sottrarre il diritto civile alla sua declinazione privatistica e al recupero di istituti e prassi che, interne alla sua tradizione, possano essere piegati alla produzione di effetti giuridici – effetti che concernono non la tutela di «diritti», ma la difesa e l’ulteriore dispiegamento di autonomie – del tutto innovativi.
Leggere con gesto ipermoderno il diritto romano antico, ad esempio, permette di mettere a valore non soltanto l’assenza, all’interno di quest’ultimo, di una teoria della persona e di una teoria della rappresentanza – è proprio grazie a teoria della personificazione rappresentativa che la modernità istituisce il soggetto collettivo per poterlo istantaneamente abrogare dissolvendolo nel pulviscolo dei rapporti privati –, ma permette anche di rinvenire nella procedura il laboratorio in cui si esprime quella specifica inventività dell’operazione giuridica che a Roma funge da cerniera tra domanda sociale e risposta istituzionale.
La civitas è un nomen vuoto, il rapporto tra le sue parti; la res, l’espressione contenziosa dell’intensità che istituisce la relazione come normativamente saliente.
Il diritto romano permette perciò di esporre fino in fondo la particolarissima operazione che la prassi giurisprudenziale è capace di realizzare. Attraverso di essa si produce e si riproduce immediatamente la cooperazione sociale, senza il bisogno di riferirla ad alcunché – sostanze, soggetti, «cose» – che la preceda.
Ciò che è dato, ciò che è, non precede l’operazione che lo «pone in essere», secondo la formula usata da diversi giuristi del primo Novecento, ma risulta sulla scia del materialissimo «effetto» di diritto che dall’operazione viene realizzato.

Il principio reiteratamente invocato dall’istituzionalismo italiano: ubi societas ibi ius –, non allude a una società preesistente e giuridicamente capace, ma esprime il principio di immanenza che si dispiega tra cooperazione e interazione una volta l’una e l’altra usino della grammatica del diritto per potersi realizzare.
La comune produzione del comune si offre come espressione dell’immediatezza di prassi autonomamente capaci di istituirsi e di risolvere orizzontalmente, nel vincolo della procedura, i conflitti che le attraversano.
Il diritto non è la norma: esso è piuttosto il principio d’ordine del sociale; il modo attraverso il quale il sociale si dà con l’immediata organizzazione dei gruppi che in quel quadro interagiscono.
Sono in particolare gli istituti della tutela e del rimedio (strumenti particolarmente maneggiabili quando in questione sono i beni comuni o le questioni ambientali) quelli dei quali Spanò sottolinea i potenziali effetti di diritto.
Il soggetto del diritto soggettivo è da sempre prodotto. Esso è prodotto dalle routines della macchina che decodifica i rapporti come rapporti di diritto privato o di diritto pubblico, secondo il funzionamento «dipolare» della logica di sovranità. La tutela o il rimedio, al contrario, si vincolano all’evento che si viene producendo e al soggetto che, nell’evento, si viene configurando.
Una «class action» non trasfigura l’interesse di molti nell’unico interesse di un soggetto di diritto che preesiste all’azione in giudizio, ma mette in comune interessi (o bisogni, o desideri) in una sola performance procedurale, che «pone in essere» un soggetto «potente ed effimero», destinato a giocare e a vincere una sola volta, per poi ricomporsi altrimenti e affiliarsi in forme differenti.
La «classe» è qui, nella «class action», ma non solo, «composizione predicativa, attributiva, funzionale»: assemblaggio di singolarità. Un’assemblea la cui capacità di agire – nella particolare torsione «tortificante» del diritto civile impressa dai contenziosi sui servizi, sulle utenze, sui beni comuni – è determinata dall’evento che l’ha istituita.
Un’assemblea che trova nel diritto il modo per articolare la politicizzazione integrale – la politica è negli oggetti, nell’ambiente, dentro casa – della propria forma di vita.
Nel diritto civile, una volta liberato dalla presa privatistica che lo ha modernamente compresso e ritrascritto, si offre la possibilità di un contenzioso che fa segno a dimensioni eminentemente processuali di soggettivazione.
Il molteplice non vi trova personificazione o rappresentanza, la propria unificazione, come nella fictio della volontà generale, ma – come invece accade nel diritto romano – vi deposita la forma di una relazione tra la procedura e le sue topiche singolari che rinvia a un’inclusione, o a forme di generalità, vocazionalmente insature.
Una logica dei casi – sempre aperta – si concatena a una logica degli eventi; mentre l’affidamento alla procedura – una grammatica, non una norma – non sterilizza né l’apertura di nuovi casi, né la produzione di effetti giuridici in grado di comporre altre figure della soggettività.
Il diritto è in grado di fare il molteplice senza perciò ridurlo all’Uno. Qui si esprime il doppio nodo dell’operazione di Spanò. Da un lato, le figure della composizione moltitudinaria della soggettività che rendono impossibile pensare al Soggetto come preliminarmente dato o «costituito».
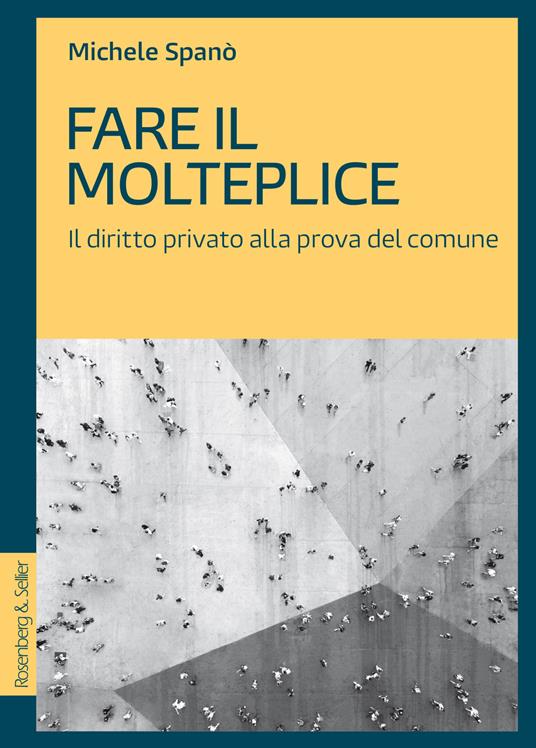
Dall’altro, la generalizzazione del ricorso ad un lessico dei «diritti» (dell’ambiente, dei «beni comuni», dei fruitori di servizi e dei consumatori, degli intermittenti e dei precari) che per potersi render effettuale deve però recuperare un’altra idea, e un’altra pratica, del diritto.
Si tratta di un’opzione in grado di politicizzare i contenziosi che attraversano la contemporaneità, senza comprimerli vittimisticamente in un lessico dei «diritti» che ne svuoterebbe immediatamente la potenziale tensione istituente.
Il diritto lo si fa, letteralmente. E farlo significa anche destituirlo delle figure e degli istituti che nella fase gloriosa del diritto pubblico e della costituzione democratica hanno prodotto, sul loro rovescio, l’individuo proprietario e la fantasmagoria della merce. Fare il molteplice – l’operazione del diritto – significa allora, nell’immanente materialità di una prassi contenziosa, istituire il comune.
* Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune, Rosenberg & Sellier, Torino 2022.
Tutte le immagini da commons.wikimedia.org
Questo articolo è pubblicato in collaborazione con Euronomade
