cult

CULT
X-Risk: archeologia dell’estinzione
Tra pandemie globali, disastri ecologici e scenari catastrofici riguardo all’Intelligenza Artificiale o all’ingegneria genetica, mai come oggi l’umanità si è trovata a dover fare i conti con il pensiero della propria estinzione. In “X-Risk. How Humanity Discovered Its Own Extinction”, il suo nuovo libro che esce martedì per i tipi di Urbanomic, Thomas Moynihan compie un’archeologia sulla storia degli umani che pensano l’estinzione umana e prova a dare una visione “razionale” dell’estinzione, che diversamente dall’apocalisse e dalla sua fascinazione per la fine, deve essere intesa come un ennesimo e urgente monito a coltivare nonostante tutto la vocazione della ragione.
Mai come oggi l’umanità si era trovata a fare i conti con il pensiero della propria scomparsa in un modo così realistico e urgente. Il disastro climatico, il collasso economico-finanziario, il pericolo di un olocausto atomico, il dilagare di una pandemia su scala globale e numerosi altri fattori hanno scosso drammaticamente il nuovo secolo, precipitandolo in uno scenario di rischio senza precedenti. Quello in cui viviamo sembra essere a tutti gli effetti il millennio della ‘fine’, dell’inconsistenza di tutti quegli ideali e garanzie su cui l’umanità aveva precedentemente edificato le proprie basi di specie e di civiltà. A differenza del tipico scetticismo post-moderno però, la posta in gioco del nostro presente non riguarda semplicemente lo scetticismo dei valori, la crisi del senso, ma la sopravvivenza della vita in quanto tale, uno scenario di rischio parossistico in cui al nichilistico non-tempo della post-modernità si contrappone l’asfissiante “iper-presente” dell’ultimo ventennio (cfr. F.J. Bonnet, After Death, Urbanomic, Falmouth 2020): è questa la precarietà fondamentale che caratterizza la Stimmung dell’estinzione. Tuttavia, la faccenda è ben più complessa di come potrebbe immediatamente apparire: realizzare l’idea dell’estinzione non significa abbracciare qualche bizzarra ideologia messianica della fine, né feticizzare la sparizione dell’uomo in senso masochistico e sacrificale. Piuttosto, sforzarsi di pensare l’estinzione vuol dire concepire un simile evento nel modo più razionale possibile, riposizionando da principio il significato stesso del decadimento, della distruzione e della sparizione degli enti in senso ontologico, quale prerogativa indispensabile dell’essere e agire nel mondo.

Come ha recentemente rimarcato Joshua Sokol nella sua breve rassegna sull’origine dei buchi neri, non è sufficiente dire che l’universo tenda naturalmente e linearmente alla dissoluzione perché, in un certo senso, è la sua stessa struttura a costituirsi come un processo di sterminata distruzione sempre-già in atto, un’incessante e roteante esplosione che – per citare Bataille – è qualcosa di speculativamente “incomparabile”. La pretesa che il mondo come lo conosciamo possa continuare a esistere preservando il suo stato di cose è stata ormai minata dalle proposte di voci provenienti da numerosi e diversi campi del sapere, al punto che la minaccia della ‘fine di tutte le cose’ è ormai divenuta un argomento non solamente da science fiction, ma reale, oppressivamente attuale, e non certo al riparo da pareri e posizioni contrastanti. La prospettiva di un ‘mondo-senza-di-noi’, di un pianeta desolato, disabitato da tracce umane ed abbandonato a un silenzio infinito, ha assunto ad oggi delle connotazioni filosofiche, scientifiche ma soprattutto etiche che non possono più essere dimesse come semplici profezie. In questo eterogeneo impasto di diagnosi e proposte, quel che più conta non è la dinamica con cui l’estinzione umana farà capolino, se essa avverrà sotto forma di cataclisma ecologico (ad opera di un pianeta ormai esausto e fuori controllo), ipertecnologico (attraverso l’implementazione di una super-intelligenza in grado di spazzare via i propri creatori) o evolutivo (la fine della “parentesi” umana, rimpiazzata da nuove e inimmaginabili forme di vita). Piuttosto, ad accomunare questo esuberante immaginario vi è l’esigenza di pensare l’estinzione prescindendo dalle sue forme particolari, un’impellenza dettata dal fatto che la fine sia già qui e che non ci sia più tempo per pensare altrimenti.
Dalle proposte etico-scientifiche di John Leslie, passando per il fortunato doomsday argument e oltre, le tesi sulla sparizione della razza umana si sono sinora distinte – direttamente oppure no – per il loro cupo e rassegnato pessimismo, intrappolando il concetto di estinzione o in una barcollante ed esasperata apologia della difesa dei tratti umani o in un triste e rassegnato fatalismo. Per quanto riguarda la prima di queste reazioni, è sufficiente citare quei riscontri di derivazione dichiaratamente antropocentrica come ad esempio l’eco-pessimismo di Roy Scranton: sostenendo che non possiamo fare altro che imparare a morire […] come civiltà», Scranton propone di ricostruire dalle ceneri dell’Antropocene un umanismo nuovo, più saldo e per questo più chiuso e paranoide (R. Scranton, Learning to Die in the Anthropocene, City Light Books, San Francisco 2015, p. 21). In questo caso, il pensiero dell’estinzione non viene elaborato internamente, né sottoposto ad una disamina sufficientemente critica, ma soltanto ridimensionato per far fronte alle esigenze di un’umanità che deve sopravvivere (o, per usare i termini di Scranton, “rinascere”) nonostante tutto, in quanto unica depositaria di un futuro concepibile. Sulla sponda opposta, quella fatalista e anti-umanista, è possibile rintracciare tutta una serie di proposte che, con l’attualizzazione delle speculazioni sulla fine, hanno trovato una maturità teorica senza precedenti, come l’antinatalismo analitico-esistenziale di David Benatar (accelerare il processo di estinzione astenendosi volontariamente dalla procreazione), il Benevolent Artificial Anti-natalism del neurofilosofo tedesco Thomas Metzinger (porre fine alla sofferenza umana è un imperativo morale) o la misantropia radicale dell’Ahuman Manifesto di Patricia MacCormack (l’estinzione umana come liberazione di una nuova “creatività” naturale del mondo). Anche qui, la tendenza predominante sembrerebbe quella di pensare l’estinzione attraverso le lenti di un rigido dualismo, in cui l’umano e il non-umano sono contrapposti dogmaticamente, e la risoluzione passa soltanto per l’escissione radicale di uno dei due termini della relazione, che in questo caso sarebbe quello dell’homo sapiens.

X-Risk di Thomas Moynihan (Urbanomic, Falmouth 2020) sovverte completamente il baricentro del dibattito, presentando un’indagine sul concetto di estinzione che supera la precedente dicotomia e la dissocia dal suo aspetto immediatamente catastrofico, orientandola allo stesso tempo verso un’apertura pratica che rielabora criticamente anche le priorità etiche dell’umano. Nel corso dei sei densi capitoli del libro, Moynihan offre un inquadramento dell’estinzione che, prima che filosofico, è anzitutto storico o, per usare le parole dell’autore, è un’archeologia «[sul]la storia degli umani che pensano l’estinzione umana» (ivi, p. 7). Quella di X-Risk è così una puntigliosa crono-storia pluridisciplinare, i cui riferimenti dilagano nell’astrobiologia e nella cosmologia russa, nella geologia, nell’epistemologia e nell’antropologia mitteleuropea, ma anche nel moralismo francese e nelle scienze analitiche anglofone. Combinando un monumentale archivio di fonti (edite e inedite) con una serie di proposte decisamente originali, e amalgamando il tutto in una scrittura di pregevole chiarezza espositiva, Moynihan ci accompagna attraverso la lunga storia di quelle scoperte e di quei paradigmi che hanno elaborato il pensiero dell’estinzione attraverso le pindariche ipotesi sulla colonizzazione dello spazio e le affascinanti speculazioni sui viaggi nel tempo, sull’uomo acquatico e sulla biologia sintetica.
Il libro propone nel complesso tre tesi chiave, che fanno da spina dorsale alle sue quasi cinquecento pagine. La prima tesi, probabilmente la più impegnativa, è che l’estinzione umana sia un’idea «relativamente nuova» (ivi, p. 8), una presenza spettrale rimasta a lungo latente nella storia dell’uomo e che è esplicitamente emersa soltanto dopo l’orrore della bomba atomica. Benché infatti l’origine dell’X-Risk (sincresi di existential risk) risalga all’Età dei Lumi, è solo con il disastro nucleare di Hiroshima e Nagasaki che la capacità di poter realmente distruggere noi stessi e il pianeta che abitiamo è divenuta tangibile, al punto da rovesciare drammaticamente anche la nostra fiducia nell’intelligenza umana: se prima delle due grandi guerre vedevamo nell’intelligenza un nobile traguardo evolutivo, un miracolo adattivo in lungimirante espansione, la bomba ha gettato su di essa l’anatema di un’aberrazione del pensiero, di un genio maligno che persegue spietatamente la propria autodistruzione. Ciò che la bomba atomica avrebbe distrutto, detto altrimenti, non sarebbe stata soltanto l’ingenua fiducia nella benevolenza dell’animale umano, ma anche gli stessi meccanismi difensivi che tenevano quest’ultimo al riparo dall’angoscia dell’estinzione.
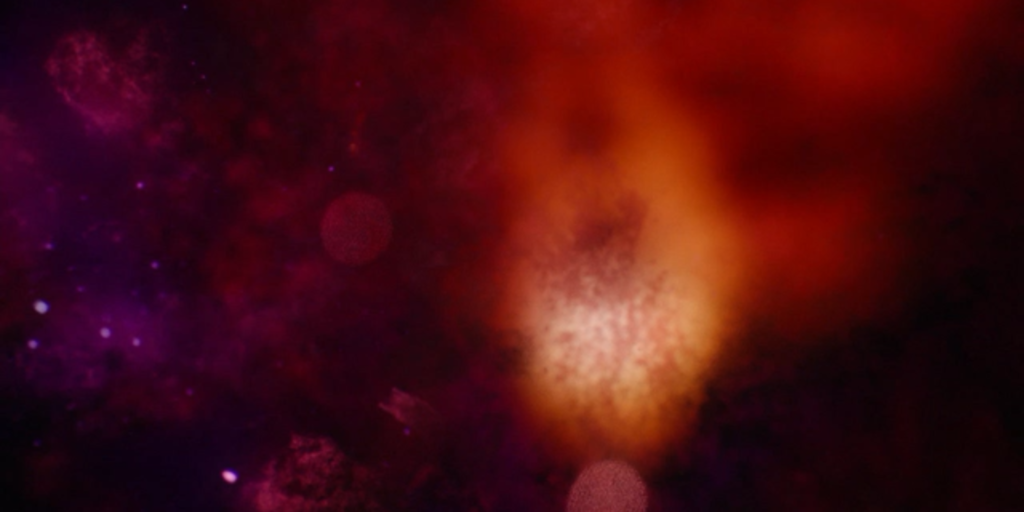
Prima della scienza moderna, infatti, in un periodo che si estende dalla preistoria sino alle soglie del 1600, il pensiero dell’estinzione appariva precluso da ciò che Moynihan definisce il «principio di pienezza», una legge universale e necessaria che postula l’indefinita permanenza di tutto ciò che esiste. L’idea di un mondo pieno, non mancante di nulla e permeato da un’infinita reversibilità ha degradato l’estinzione a una semplice «estirpazione locale», una negatività istantaneamente controbilanciata dall’indistruttibilità del valore degli enti. In quest’ottica, l’estinzione non sarebbe altro che un momento di transito, il catalizzatore di una successiva ed equivalente riorganizzazione della perennità della forma. Anche la morte, analogamente, non doveva essere intesa come qualcosa di (ineluttabilmente) insensato, ma come un «riciclo creativo» in cui nulla scompare mai veramente e tutto fluisce, scorre, si ridistribuisce in una macchinazione senza inceppature. Tutto ciò che può sembrare una perdita di valore non è altro che un riarrangiamento sovradeterminato della materia cosmica, di quella complessa architettura del mondo di cui noi esseri umani non siamo in grado di cogliere il disegno completo. Stando al principio di pienezza, le catastrofi, le crisi e le calamità rappresenterebbero il necessario momento di tregua tra un ciclo e l’altro dell’ordine naturale, lo iato filogenetico che separa una civiltà che tramonta da una che sorge: «per quante volte possa essere ‘annientata’, [anche] l’umanità riapparirà costantemente per ripopolare una terra desolata» (ivi, pp. 55-56).
Che ciò che è non possa sparire per sempre, ma solo rigenerarsi e perpetuarsi è stata un’idea a sua volta rinforzata dalla credenza secondo cui i fatti naturali risulterebbero intrinsecamente dipendenti da specifiche leggi morali. Che nulla venga creato e che nulla sia definitivamente distrutto, del resto, non sarebbe altro che l’ennesima dimostrazione della “buona forma” del creato, della sua connaturale moralità. Questa distorsione si sarebbe successivamente estesa anche agli albori della scienza moderna, quando l’Illuminismo ha conferito all’uomo la dote sovrana di manipolare il proprio mondo con il lume della ragione. Tuttavia, da Kant in poi, la consapevolezza di tali capacità ha anche gradualmente avvicinato l’uomo verso l’idea del tutto opposta: l’espansione incondizionata della ragione non conduce all’onnipotenza umana, ma alla consapevolezza della fragilità e della finitudine che abitano il reale. Il cosmo svelato dai lumi è sempre di più un cosmo desacralizzato, indifferente e per questo impermeabile a qualsiasi prescrizione etica o morale. La conquista della razionalità ha posto l’uomo davanti all’abisso della propria responsabilità: il riconoscimento della precarietà del progetto umano, e dunque l’X-Risk come minaccia esistenziale, sono il retaggio di questa nuova “maturità” della ragione, un traguardo “inevitabile” che si esplica nella necessità di assumere e rispondere ai propri rischi.

Il confronto con la precarietà del mondo è a sua volta strettamente legato alla seconda tesi chiave di X-Risk, per la quale il concetto di estinzione andrebbe drasticamente distinto da quello dell’apocalisse. Mentre infatti il pensiero dell’apocalisse rimane ancora preda del mito della pienezza (in quanto si propone di assicurare un senso alla fine, e cioè di significare l’inevitabile), l’estinzione sancisce la fine del senso, il definitivo confronto con il brutale mutismo del reale. Apocalisse ed estinzione non sono soltanto due idee distinte, ma persino “contraddittorie”: la prima è un giudizio profondamente morale, la rivelazione ultima del ‘progetto’ del mondo, la seconda è l’evento che spazza via la possibilità stessa della moralità. Una è conciliatoria, l’altra inconsolabile, una celebra la fantasia finale della volontà divina, l’altra taglia la testa a qualsiasi incarnazione onto-teologica.
Laddove le precedenti due tesi non risolvono del tutto la complicità tra estinzione e rassegnazione, è la terza ed ultima a dischiudere tutto il potenziale etico-politico del libro: la scoperta dell’X-Risk, scrive Moynihan, è una verità che ha certamente sconvolto il nostro modo di essere al mondo, ma lungi dal deprimerci, essa deve essere intesa come un ennesimo e urgente monito a coltivare nonostante tutto la vocazione della ragione. Riflettere sul rischio esistenziale implica un lavoro infinito, immane, costantemente esposto all’errore e alla smentita, ma è proprio la sua persistenza a mantenerci fedeli alla possibilità di fare la differenza, di continuare a compiere qualcosa di buono e di migliore. Scoprendo lo spettro dell’estinzione, «ci siamo resi conto che dobbiamo pensare meglio perché, così non fosse, potremmo non pensare mai più» (ivi, p. 43). È in questo più profondo e impegnativo senso che Illuminismo ed estinzione sono «le due facce della stessa medaglia», la spinta ad una compenetrazione di saperi, pratiche ed obiettivi le cui ramificazioni devono ancora essere pienamente dispiegate.

Pensare l’estinzione ripercorrendo le tracce del nostro lungo passato, e cioè senza schiacciare il concetto sulla narcisistica immediatezza del presente, è il più grande aiuto che la Storia ci possa dare, perché è solo avendo cura di questa progressiva consapevolezza che diviene possibile tramutare la premura per l’X-Risk in un impegno che, per quanto «incompleto» e «interminabile», è anche comunitario e globale (ivi, p. 11). Raffinare la nostra responsabilità nei confronti del più sconvolgente dei rischi apre il futuro ad un’assunzione etica della contingenza che non sia rassegnatamente pessimistica, né istericamente conservativa.
In definitiva, il confronto con l’estinzione è una «componente essenziale e inevitabile» di ciò che significa essere umani, un traguardo «monumentale» in cui l’essere razionali non vuol dire più reclamare la propria (presunta) superiorità di specie, ma divenire «responsabili per se stessi». Questo perché il rischio esistenziale non mette a repentaglio solo la nostra esistenza nel mondo, ma anche quella dell’agire morale in quanto tale. Come spiega Moynihan, non tutti gli X-Risk implicano l’estinzione. Illudersi che la nostra scomparsa dalla faccia della Terra costituirebbe il worst case scenario sarebbe un ragionamento ancora troppo antropocentrico: la vera disfatta, piuttosto, sarebbe la neutralizzazione del potenziale pratico tout court, una paralisi dell’agire razionale che ci intrappolerebbe in un limbo di «indicibile dolore» (ivi, p. 21). Del resto, la ragione è razionale non perché in grado di fornire sicurezza, certezza o protezione dalle insidie dell’ignoto. Essa è tale perché, parafrasando Reza Negarestani, è auto-correttiva: più che per i suoi fondamenti inviolabili, è grazie alla sua natura incessantemente esposta alla revisione che la ragione costituisce il più straordinario degli strumenti. Essere razionali significa, puramente e semplicemente, «essere ricettivi alla fragilità della vita nel cosmo» (ivi, p. 100). Ecco perché, nella sua perpetuazione, l’essere umano non si limita a riprodurre un rigido pattern di predisposizioni biologiche, ma trasmette una cumulativa capacità di “fare” e “realizzare” che rimette costantemente in gioco la sua insanabile fragilità ontologica. È stata proprio la prospettiva dell’estinzione a rendere reale questa capacità: siamo arrivati a capire che la nostra esistenza è in grado di preservare la differenza (di fare qualcosa) solo quando abbiamo compreso che essa dipende da noi e noi soltanto. Rielaborato attraverso la lente critica dell’estinzione, l’umano abbandona il fantasma della propria eccezionalità per diventare una prassi di costante auto-miglioramento, il “perché” che noi stessi dobbiamo costruire. Una “vera” intelligenza, a questo proposito, è quella che sa esercitare il proprio volere senza «inquinare» o «annientare» la biodiversità del pianeta, perché intelligente è «la capacità di divenire più contingenti attraverso il proprio duro lavoro» (ivi, p. 423).
In copertina e nel testo alcuni fotogrammi dell’episodio 8 di Twin Peaks – il ritorno di David Lynch
